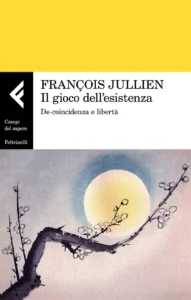1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“L’inaudito. All’inizio della vita vera” di François Jullien non è il solito libro che ti parla di cose strane o eccezionali. Anzi, è il contrario: ti fa notare che la vera stranezza, l’inaudito appunto, è nascosta proprio nelle cose più normali, quelle che vediamo tutti i giorni ma che smettiamo di vedere davvero perché ci sembrano scontate. È come se il linguaggio e le abitudini coprissero la realtà, rendendo tutto banale e generando quel senso di noia, il tedio, che ci fa sentire la vita piatta. Jullien dice che per risvegliarci da questo torpore e scoprire l’inaudito che è sempre lì, nel nostro ordinario, nelle persone che incontriamo (l’Altro), persino dentro di noi, serve uno scarto. Non è solo pensare diversamente, ma un vero e proprio spostamento nella nostra percezione e nel nostro modo di stare al mondo. È una specie di etica che ci spinge a vivere in modo più pieno, a non farci appiattire dalla routine. Il libro esplora questa idea attingendo a diverse filosofie, anche lontane dalla nostra, e usando la letteratura per farci sentire questa vertigine del quotidiano. È una sfida a guardare il mondo e noi stessi con occhi nuovi, per trovare l’esistenza vera dove meno ce l’aspettiamo.Riassunto Breve
Il linguaggio e le abitudini di pensiero tendono a rendere familiare e scontato ciò che si vede ogni giorno, coprendo la realtà. Questo processo fa sì che non si noti ciò che è “in-audito”, cioè non ancora percepito nella sua profondità. L’inaudito non è qualcosa di strano o eccezionale, ma è l’ordinario che sfugge alla comprensione e al linguaggio proprio perché è sempre presente e visibile. È come lo sconosciuto che si nasconde nel noto. Questa difficoltà a integrarlo lo rende a volte noioso o banale, ma anche vertiginoso. Per poter cogliere l’inaudito serve fare uno “scarto”, un distacco dalle solite maniere di pensare e percepire. Questo scarto non è solo un dubbio, ma un vero e proprio spostamento che rompe la routine e permette di vedere ciò che è nascosto dall’abitudine. Solo così si aprono delle fessure nel modo in cui si pensa e si parla di solito. Incontrare l’inaudito mostra che c’è qualcosa nell’ordinario che non si può spiegare del tutto, come il colore o la vita stessa. Questo qualcosa che sfugge alla piena ragione è la base per creare cose nuove e autentiche, spingendo il pensiero oltre i limiti del linguaggio conosciuto. Affrontare l’inaudito, invece di evitarlo, è la vera sfida. L’inaudito è ciò che si ripete continuamente ma non viene notato, e questa mancata percezione genera noia, il “tedio”. Il reale, che sembra sempre uguale e senza sorprese, è in realtà l’inaudito che non si riesce a vedere, e per questo annoia. Per superare il tedio e accedere all’inaudito, serve di nuovo uno scarto, una rottura nelle abitudini. Solo una discontinuità permette di far emergere ciò che è nascosto dall’essere troppo evidente. Accedere all’inaudito è una scelta di vita, un atto coraggioso che rompe con la routine. Non è scegliere tra opzioni, ma fare un salto nell’imprevisto, un “e-sistere”, cioè stare fuori dalle condizioni imposte. L’inaudito è anche l'”in sé”, ciò che non si può conoscere fino in fondo. Non è un mistero lontano, ma l’alterità irriducibile che si incontra nell’esperienza. La vita tende a rendere l’inaudito familiare per non essere disturbata. Invece, accedervi significa incontrarlo nella sua unicità senza assimilarlo. Questo ha un effetto immediato sulle relazioni, aprendo all’altro e superando l’egoismo. Anche l’inconscio è un inaudito dentro di noi, l’altro che si manifesta in sintomi ripetitivi che possono annoiare. La psicanalisi cerca di capire questo inaudito interiore. Affrontare l’inaudito, fuori e dentro di sé, è una risorsa contro il tedio e permette alla vita di esprimersi pienamente. L’inaudito affiora nell’esperienza ma la supera, senza però essere qualcosa di separato o un “Aldilà” metafisico. È un punto in cui l’esperienza va oltre i suoi limiti, causando smarrimento, ma resta legata a ciò che appare. A differenza della metafisica che cerca realtà ideali, l’inaudito si manifesta come un “minimale metafisico” nelle cose più semplici, come un volto. La metafisica tradizionale e la società evitano l’inaudito, negandolo o mettendolo in un mondo superiore per sentirsi sicuri. Esperienze forti come il godimento, che rompono gli schemi e toccano un “al di là” non catalogabile, vengono spesso ignorate dal pensiero. C’è differenza tra “scomparire” (ritirarsi dalla presenza) e “dis-apparire” (essere visibile ma perdere la capacità di emergere, diventando opaco e noioso). Questo dis-apparire accade quando la presenza si stabilizza troppo, si “staglia”, nascondendo l’Essere stesso. La metafisica ha provato a risolvere questo problema in vari modi. L’inaudito, invece, si manifesta rompendo lo stagliarsi noioso dell’Essere, rendendo la presenza di nuovo viva. Accedere all’inaudito richiede “discoprimento”, che non è trovare qualcosa di nascosto, ma togliere ciò che impedisce di vedere l’ordinario nella sua intensità inaudita. Questo implica una “de-coincidenza” da sé e dal mondo, una tensione che crea l'”e-sistenza”. Esistere è la capacità di andare oltre l’assimilazione, di stare fuori dal mondo pur essendoci dentro. L’inaudito nutre questa e-sistenza, aprendo a un “al di là” possibile nell’esperienza stessa, senza bisogno di una trascendenza separata. La vita stessa, quando si ripete e dis-appare, diventa inaudita e richiede discoprimento per essere capita. Capire l’inaudito richiede di rompere con ciò che è già noto. Questo si fa con una “de-coincidenza”, un distacco interno dalle definizioni che ci bloccano. Quando le cose e le parole si adattano perfettamente, diventano banali e nascondono il loro “in sé”. Solo uscendo da questa conformità si rivela ciò che è presente ma non si vede. La metafora è uno strumento chiave. Non confronta per assimilare, ma trasporta direttamente in altro, creando uno scarto che mantiene viva l’alterità. Questo “trasporto” non è solo un modo di dire, ma fa emergere l’inaudito nel linguaggio e nell’esperienza. La metafora rivela ciò che è già qui, reso opaco dall’abitudine. Questo vale anche per l’Altro come persona. L’inaudito dell’Altro non è ciò che non si conosce e si vorrebbe identificare, ma la sua “ipseità”, la sua unicità che non si può ridurre a una definizione. Voler conoscere l’Altro completamente porta al tedio, perché lo si assimila al proprio mondo. Incontrare l’inaudito dell’Altro rompe la solitudine e apre a nuove possibilità. Lo sguardo, in particolare, è un luogo dove l’inaudito dell’Altro irrompe, mostrando una profondità che va oltre la superficie. Riconoscere l’inaudito dell’Altro significa accettare la sua radicale estraneità senza volerla assimilare. È una scelta etica che supera il tedio della familiarità e mantiene vivo l’incontro, liberando il sé dalla sua identità bloccata e permettendogli di crescere. La ricerca dell’inaudito completa un percorso filosofico che unisce l’analisi dei concetti con l’uso della letteratura per esprimere l’esperienza. Questo metodo sta tra la tecnica di modellare i concetti e la poetica di inventare nel linguaggio. Ci si chiede se questa riflessione filosofica sia ancora valida oggi, in un mondo dominato da superficialità e dibattiti mediatici che ignorano l’inaudito. È possibile continuare questo lavoro senza cadere nello sviluppo personale o nei falsi eventi? Ci si interroga se opere filosofiche profonde siano ancora possibili o se siano superate. Si riflette sulla pazienza necessaria per leggere libri impegnativi e sul senso della lettura profonda. La questione non è la solitudine del filosofo, ma se questo tipo di pensiero abbia ancora spazio nella cultura attuale, dominata dallo svago. Ci si chiede se possa sopravvivere e se rappresenti una forma di resistenza.Riassunto Lungo
1. L’inaudito nel quotidiano
Il linguaggio e la percezione che usiamo ogni giorno tendono a nascondere la vera natura delle cose. Le parole ci danno un primo orientamento, come quando diciamo “mare”, ma allo stesso tempo appiattiscono l’esperienza, riducendola a qualcosa di già noto e atteso. Questo modo di pensare abituale ci impedisce di vedere ciò che è “inaudito”, cioè ciò che non abbiamo ancora davvero percepito o compreso in tutta la sua profondità. L’inaudito non è qualcosa di strano o eccezionale; al contrario, è ciò che sfugge alle nostre categorie di pensiero e al nostro linguaggio, anche se è estremamente comune e presente nella vita di tutti i giorni. È l’aspetto sconosciuto di ciò che ci è più familiare, che non riconosciamo proprio perché lo abbiamo sempre davanti agli occhi. Questa difficoltà a integrarlo nel nostro modo di pensare lo rende spiazzante e difficile da afferrare, e spesso lo percepiamo semplicemente come noioso o banale.Come scoprire l’inaudito
Per poter incontrare l’inaudito, serve fare uno “scarto”. Questo significa distaccarsi dalle nostre abitudini di pensiero, dal modo in cui percepiamo le cose di solito e dal modo in cui comunichiamo in modo convenzionale. Questo scarto non è un semplice dubbio teorico, ma un vero e proprio spostamento pratico che rompe la routine e la continuità dell’esperienza che ci siamo costruiti. Solo questo cambiamento di prospettiva, con il suo desiderio di esplorare, può portarci verso l’inaudito, aprendo nuovi spazi e altri modi di vedere e pensare oltre ciò che è già stato detto e stabilito.L’inaudito e la creazione
Quando entriamo in contatto con l’inaudito, scopriamo che c’è qualcosa che non si può integrare nel cuore stesso delle cose più ordinarie, come l’esistenza di un colore o il mistero della vita. Questo residuo, che non trova una spiegazione logica completa, è la base per creare qualcosa di veramente nuovo e autentico. Permette al pensiero di andare oltre i limiti del linguaggio stabilito e di inventare nuove possibilità che prima non vedevamo. La vera sfida non è evitare l’inaudito, ma affrontarlo e accoglierlo.Ma siamo certi che questo ‘inaudito’ sia davvero la ‘vera natura delle cose’, o non piuttosto un’altra, magari più complessa, interpretazione della realtà?
Il capitolo afferma che l’inaudito svela la “vera natura delle cose”, ma non fornisce le basi per sostenere questa pretesa di verità. Perché ciò che sfugge alle nostre categorie abituali dovrebbe essere intrinsecamente più “vero” della nostra percezione quotidiana? Questa è una posizione filosofica significativa che richiederebbe un’esplorazione più approfondita e un confronto con altre prospettive. Per comprendere meglio le diverse visioni sulla natura della realtà, sulla percezione e sul ruolo del linguaggio, è consigliabile studiare discipline come la fenomenologia e l’ontologia. Autori come Merleau-Ponty e Heidegger hanno dedicato ampio spazio a queste tematiche, offrendo strumenti concettuali per analizzare il rapporto tra l’esperienza, il linguaggio e ciò che consideriamo “reale”, che possono aiutare a contestualizzare e valutare criticamente l’assunto del capitolo.2. Oltre il Tedio: L’Inaudito come Risorsa
L’inaudito non è qualcosa di strano o che capita raramente. È invece ciò che si presenta di continuo, sempre uguale, ma che non riusciamo a vedere o sentire. È lì, sotto i nostri occhi, si fa sentire, ma ci sfugge proprio perché è sempre presente e si ripete senza sosta. Non accorgerci di ciò che è sempre lì genera un senso di noia profonda, il tedio. Il mondo, la realtà, quando la vediamo come qualcosa di immutabile e ripetitivo, diventa quell’inaudito che non riusciamo a cogliere e che ci annoia.Come si accede all’Inaudito
Per riuscire a vedere l’inaudito e vincere la noia, serve un cambiamento, una vera e propria rottura nel nostro solito modo di sentire e di pensare. Solo se c’è una pausa, un’interruzione nella routine, possiamo far emergere quello che è nascosto proprio perché troppo evidente. Riuscire a cogliere l’inaudito è una scelta importante per la nostra vita, un’etica dell’esistenza. Richiede una decisione forte, un gesto coraggioso che ci allontana dalla routine di ogni giorno e dalla rassegnazione. Non è come scegliere tra due strade, ma è un vero e proprio salto verso ciò che non ci aspettiamo, un “e-sistere”, che significa mettersi al di fuori delle regole e delle situazioni che ci vengono imposte.L’Inaudito come “in sé” e il suo effetto etico
L’inaudito è anche l'”in sé”, quella parte delle cose che non riusciamo a conoscere con i soliti strumenti. Non è un segreto da scoprire o qualcosa che sta in un altro mondo lontano. È invece quella diversità profonda e unica che possiamo solo sfiorare attraverso le nostre esperienze. Di solito, la vita cerca di rendere l’inaudito simile a quello che già conosciamo, per non sentirsi disturbata. Invece, riuscire a cogliere l’inaudito vuol dire proprio non renderlo uguale a noi, ma incontrarlo così com’è, nella sua unicità. Quando riusciamo a fare questo, c’è subito un effetto importante sulla nostra etica: ci apriamo verso gli altri e superiamo il nostro egoismo.L’Inaudito dentro di noi e la sua importanza
C’è un inaudito anche dentro di noi: è l’inconscio, quella parte “altra” che si manifesta spesso attraverso sintomi o comportamenti che si ripetono e che, proprio per questa ripetizione, possono generare un senso di noia interiore. La psicanalisi rappresenta uno sforzo per iniziare a dare un senso a questo inaudito che portiamo dentro. Riuscire ad affrontare l’inaudito, sia quello che incontriamo nel mondo esterno sia quello che scopriamo dentro di noi, diventa una risorsa fondamentale per superare il tedio e permettere alla vita di esprimersi e dispiegarsi in tutta la sua pienezza.Su quali basi filosofiche o psicologiche poggia questa visione dell’inaudito e del tedio?
Il capitolo introduce concetti complessi come il tedio, l’inaudito, l'”in sé” e l’inconscio, ma non esplicita chiaramente a quali tradizioni di pensiero si rifaccia. L’uso di termini come “e-sistere” suggerisce un possibile legame con la filosofia esistenzialista, mentre il riferimento all’inconscio e alla psicanalisi rimanda a specifici ambiti della psicologia. Per comprendere meglio le premesse e le implicazioni di questa prospettiva, sarebbe utile approfondire autori che hanno trattato temi simili, come Kierkegaard o Heidegger per il concetto di tedio e l’esistenza, Sartre per l'”in sé”, o Freud e Lacan per l’inconscio e la psicanalisi. Questo permetterebbe di contestualizzare l’argomentazione e valutarne la solidità rispetto a dibattiti già consolidati.3. La vertigine dell’ordinario
L’inaudito emerge nell’esperienza quotidiana, spingendone i confini, ma senza rimandare a un mondo separato o a un “Aldilà” trascendente. È un momento cruciale in cui ciò che appare nella realtà di tutti i giorni sembra traboccare, provocando un senso di smarrimento o “vertigine”. Tuttavia, questo non significa che l’inaudito ci porti fuori dalla realtà che percepiamo; resta saldamente legato a ciò che si manifesta. A differenza della filosofia tradizionale che cerca di superare l’esperienza costruendo realtà ideali e lontane, l’inaudito si rivela come una forma di “metafisica minima” proprio nelle cose più comuni e ordinarie, come nel semplice guardare un volto o osservare un paesaggio all’alba.Come la realtà gestisce l’inaudito
Spesso, sia la filosofia classica che la società in generale tendono a evitare o a classificare l’inaudito. Lo negano o lo collocano in un ambito che va oltre i nostri sensi, cercando così di rassicurarsi. Esperienze molto intense, come un profondo godimento, che rompono i nostri schemi abituali di comprensione e toccano qualcosa che non può essere facilmente etichettato o spiegato, vengono spesso messe da parte o rimosse dal pensiero comune.Due modi di non essere presenti: scomparire e dis-apparire
È importante distinguere tra “scomparire” e “dis-apparire”. Scomparire significa ritirarsi dalla presenza, come accade con un tramonto o con la morte. Dis-apparire, invece, è diverso: qualcosa è perfettamente visibile, ma perde la sua capacità di emergere veramente, di farsi notare nella sua pienezza. Questo succede quando la presenza diventa troppo stabile, troppo “fissa” o “stagliata”, generando un senso di noia o vuoto. Questo “stagliarsi” è visto quasi come un fallimento dell’Essere stesso, che si nasconde proprio nella sua stessa presenza manifesta.Il ruolo dell’inaudito
La filosofia ha cercato in vari modi di risolvere questo problema, ad esempio sdoppiando il concetto di Essere o introducendo l’idea che l’Essere si ritiri in sé stesso. L’inaudito offre una soluzione diversa: si manifesta “incrinando” questo “stagliarsi” noioso e ripetitivo dell’Essere, rendendo la presenza di nuovo viva e evidente.Come accedere all’inaudito
Per accedere all’inaudito è necessario un “discoprimento”, che non significa scoprire qualcosa di totalmente sconosciuto. Piuttosto, è un ritirarsi di ciò che impedisce di vedere l’ordinario nella sua sorprendente e intensa realtà. Questo “discoprimento” implica un “non coincidere” completamente con sé stessi e con il mondo, una sorta di tensione che costituisce l'”e-sistenza”. L’esistenza, in questo senso, è la capacità di andare oltre il semplice essere assimilati o integrati nel mondo; è un tenersi fuori da esso pur rimanendovi pienamente presenti. L’inaudito nutre questa “e-sistenza”, aprendo la possibilità di un “al di là” che si trova all’interno dell’esperienza stessa, senza bisogno di una realtà separata e trascendente. Anche la vita stessa, quando diventa ripetitiva e sembra “stagliarsi” e “dis-apparire” nella sua routine, diventa inaudita e richiede questo “discoprimento” per essere veramente compresa e vissuta.Questa visione dell’Altro, che nega la possibilità di una conoscenza piena e valorizza l’estraneità radicale, non rischia di rendere impossibile ogni vera relazione o comprensione reciproca?
Il capitolo presenta una prospettiva affascinante sull’incontro con l’Altro, ponendo l’accento sull’accettazione della sua irriducibile singolarità e mettendo in guardia contro il desiderio di una conoscenza totale che porterebbe alla noia. Tuttavia, questa enfasi sull’estraneità radicale sembra trascurare le dimensioni fondamentali della relazione umana che implicano la ricerca di comprensione, empatia e costruzione di significati condivisi. Non è chiaro come, nella pratica, un rapporto possa svilupparsi e prosperare se si rinuncia a priori alla possibilità di conoscere l’altro in profondità, al di là della sua “inaudita” unicità. Per esplorare questa tensione, sarebbe utile confrontarsi con discipline come la psicologia sociale, che studia i processi di interazione e comprensione interpersonale, e la sociologia, che analizza la costruzione delle identità e delle relazioni all’interno dei contesti sociali. Autori come Martin Buber, con la sua filosofia del dialogo, offrono prospettive alternative sull’incontro con l’Altro che meritano di essere considerate per arricchire il quadro proposto dal capitolo.5. Il Senso del Pensiero Inaudito Oggi
La ricerca dell’inaudito completa un percorso iniziato con lavori precedenti, visti come capitoli di un unico progetto. Questo progetto si basa su due idee forti: la forza dello scarto, usata come strategia, e la promozione dell’esistenza, intesa come etica. Questo cammino prosegue ricerche già fatte, segnando una nuova fase nel lavoro filosofico. L’inaudito segna l’inizio di questo percorso, nato dal passaggio dalla filosofia greca a quella cinese. Si usa la Cina per prendere le distanze da una filosofia basata sull’Essere, ponendo una domanda chiave: cosa offre il pensiero cinese che la tradizione europea ha ignorato, al di là di concetti come l’Essere o la Verità? Il compito del pensiero è permettere all’inaudito di manifestarsi.Il Metodo e la Sua Rilevanza
Per dare voce all’esperienza, si usa un modo di fare filosofia che unisce l’analisi dei concetti, tipica della filosofia, con la letteratura, in particolare Proust. Questo metodo si trova tra due esigenze: una tecnica, che modella i concetti nella storia del pensiero, e una poetica, che inventa nel linguaggio per esprimere ciò che non è mai stato detto. Sorge la domanda se questa riflessione filosofica possa ancora farsi capire oggi in un contesto dominato dal mercato della felicità e dagli anniversari, pieno di libri superficiali. È possibile continuare questo lavoro senza cadere nello sviluppo personale o nei falsi eventi? Si evitano i dibattiti mediatici che ignorano l’inaudito.Il Posto del Pensiero Profondo
Questo porta a chiedersi se opere filosofiche profonde siano ancora possibili oggi o se siano superate. Ci si interroga sulla pazienza necessaria per leggere libri impegnativi e sul significato stesso della lettura profonda. La questione non è la solitudine di chi pensa, ma se questo tipo di pensiero abbia ancora un posto nella cultura attuale, dominata dallo svago e dalla comunicazione. Ci si chiede se possa sopravvivere e se rappresenti una forma di resistenza.Ma il “passaggio dalla filosofia greca a quella cinese” non rischia di essere una semplificazione eccessiva per definire ciò che è “inaudito”?
Il capitolo fonda la ricerca dell’inaudito su un contrasto tra la filosofia europea, legata all’Essere, e il pensiero cinese. Tuttavia, questa dicotomia potrebbe trascurare la vasta diversità interna a entrambe le tradizioni, rendendo la base dell’argomentazione meno solida. Per comprendere meglio se l’inaudito sia davvero assente nella tradizione europea o se il pensiero cinese offra spunti unicamente inediti, sarebbe utile approfondire specifiche correnti filosofiche. Si potrebbe esplorare il pensiero di autori come Lao Tzu o Chuang Tzu per il lato cinese, e confrontarli non solo con la metafisica dell’Essere, ma anche con filosofi europei che hanno esplorato l’alterità o l’inedito, come Lévinas o Derrida. Approfondire la storia della filosofia comparata e la sinologia può fornire il contesto necessario per valutare la validità di tale “passaggio”.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]