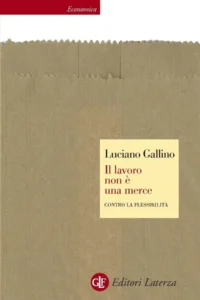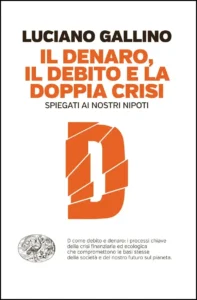1. Il governo d’impresa e la sua ombra irresponsabile
Grandi aziende mostrano comportamenti irresponsabili in molti settori. Questo accade nella finanza, per l’ambiente, nelle condizioni di lavoro e per la sicurezza. Esempi di scandali finanziari includono Parmalat, Cirio, Enron e WorldCom. Frodi materiali come Bre-X mostrano la gravità di queste azioni. Le conseguenze ricadono su risparmiatori, lavoratori e intere aree geografiche. Questi problemi si verificano in diversi paesi e tipi di attività economica. Per contrastare ciò, si parla di responsabilità sociale d’impresa (RSI). La RSI suggerisce alle aziende di includere volontariamente temi sociali e ambientali nelle loro attività. Questo va oltre le semplici leggi. Tuttavia, c’è un fatto strano: mentre si discute sempre più di RSI, gli scandali aziendali aumentano. Sembra quasi che l’irresponsabilità sia diventata una caratteristica del modo in cui funziona oggi il capitalismo.Il Governo d’Impresa: Chi Decide e Come
La capacità di un’azienda di agire in modo corretto dipende molto da come è gestita al suo interno. Questo si chiama governo d’impresa. Riguarda chi prende le decisioni importanti. Le persone chiave sono gli azionisti, che possiedono l’azienda, i manager, che la dirigono ogni giorno, e i dirigenti operativi. I rapporti tra questi gruppi non sono sempre facili; sono spesso basati su chi ha più potere. La struttura ufficiale prevede organi come il Consiglio di Amministrazione, ma la realtà è più complessa. Spesso, pochi azionisti possiedono molte azioni, dando loro un grande potere decisionale. Inoltre, strutture come le partecipazioni incrociate tra aziende, le catene di controllo (piramidi societarie) e le acquisizioni veloci rendono difficile capire chi ha davvero il potere e quindi la responsabilità finale.L’Evoluzione del Potere e le Conseguenze
Guardando al passato, nel capitalismo chiamato ‘manageriale’ (fino agli anni ’80), i manager si concentravano sulla produzione. In parte, si occupavano anche di questioni sociali. Questo era possibile grazie a buoni profitti e a un ambiente politico favorevole. Molti pensano che quel periodo fosse più attento agli aspetti sociali rispetto a oggi. L’aumento delle aziende che agiscono in modo irresponsabile sembra legato a un cambiamento. I proprietari (gli azionisti) sono tornati ad avere un ruolo più forte nel governo delle aziende. Usano questo potere spesso per aumentare soprattutto il valore delle azioni. Questo dimostra che puntare solo sulla buona volontà delle aziende (la RSI volontaria) non è sufficiente. È necessaria una vera riforma del modo in cui le aziende sono governate.Ma se la Responsabilità Sociale d’Impresa è la soluzione, perché la sua crescente diffusione sembra coincidere con un aumento degli scandali aziendali?
Questo è un punto cruciale sollevato dal capitolo, che evidenzia una contraddizione apparente che merita un’analisi più approfondita. Il capitolo suggerisce che l’aumento degli scandali, nonostante il maggiore dibattito sulla RSI, possa indicare l’inefficacia di un approccio volontario o addirittura che l’irresponsabilità sia intrinseca al capitalismo moderno. Tuttavia, la relazione tra questi due fenomeni potrebbe essere più complessa. È possibile che la maggiore attenzione alla RSI porti anche a una maggiore trasparenza e, di conseguenza, a una maggiore scoperta e denuncia di comportamenti scorretti che prima rimanevano nascosti? Oppure la RSI è talvolta utilizzata come mero strumento di facciata (il cosiddetto “greenwashing” o “social washing”) per distogliere l’attenzione da pratiche irresponsabili? Per esplorare queste sfaccettature, sarebbe utile approfondire gli studi sulla teoria dell’agenzia (autori come Jensen e Meckling), le diverse scuole di pensiero sulla RSI (come quelle legate alla stakeholder theory, ad esempio Freeman), e le analisi critiche del governo d’impresa e del capitalismo contemporaneo.2. Stato e Famiglie: I Protagonisti della Proprietà d’Impresa
Lo Stato mantiene un ruolo importante come azionista in molte imprese in tutto il mondo. Spesso, lo Stato controlla società che forniscono servizi pubblici essenziali, come l’energia e i trasporti. Nonostante le molte privatizzazioni avvenute dagli anni ’90 in diverse parti del mondo, il peso economico dello Stato come proprietario non è diminuito in modo significativo a livello globale. Paesi come la Cina, ad esempio, mostrano ancora una forte presenza statale nelle grandi aziende quotate in borsa.Lo Stato come proprietario
Gestire aziende partecipate dallo Stato presenta sfide particolari. Gli interessi dello Stato come proprietario possono andare oltre il semplice guadagno massimo, includendo obiettivi sociali o strategici importanti per il Paese. I dirigenti che rappresentano lo Stato in queste aziende si trovano spesso in una posizione difficile, influenzati da pressioni politiche esterne. Inoltre, a volte hanno competenze manageriali meno specifiche rispetto ai dirigenti professionisti delle imprese private. Queste situazioni possono rendere il governo di queste aziende meno efficace.Il capitalismo familiare
Accanto allo Stato, il capitalismo familiare rimane una forma di proprietà d’impresa molto diffusa e importante. Questo vale soprattutto nei paesi economicamente sviluppati come Stati Uniti, Francia e Germania. L’idea che le grandi imprese familiari siano un fenomeno del passato non corrisponde alla realtà. Molte grandi società a livello globale sono ancora controllate dalle famiglie che le hanno fondate o dai loro eredi. Questo include sia aziende storiche che nuove realtà emerse di recente. Anche in Italia, pur essendosi ridimensionate alcune grandi famiglie storiche, nuove imprese a controllo familiare hanno raggiunto dimensioni internazionali.Le sfide del capitalismo familiare
Il capitalismo familiare deve affrontare problemi specifici legati alla gestione di gruppi familiari numerosi, alla successione tra generazioni e al bisogno di bilanciare gli interessi della famiglia con quelli degli altri azionisti.Ma se la gestione delle imprese statali è così esposta a pressioni politiche e carenze manageriali, come il capitolo stesso suggerisce, è davvero razionale o efficiente che lo Stato mantenga un peso economico così rilevante a livello globale?
Il capitolo evidenzia le intrinseche difficoltà nella gestione delle imprese a partecipazione statale, citando l’influenza politica e le possibili lacune nelle competenze specifiche dei dirigenti. Tuttavia, non approfondisce a sufficienza le implicazioni di queste sfide sull’efficienza economica complessiva o sulla giustificazione del mantenimento di un ruolo così esteso da parte dello Stato. Per esplorare questa tensione, sarebbe utile confrontare le performance delle imprese statali con quelle private in contesti simili, analizzare la letteratura sulla political economy e il rischio di “rent-seeking” nelle aziende pubbliche. Approfondimenti in materia di corporate governance comparata e studi sui diversi modelli di capitalismo di stato, magari leggendo autori che si occupano di economia istituzionale o di privatizzazioni, potrebbero fornire gli strumenti necessari per valutare criticamente la persistenza di questo modello di proprietà.3. Il Capitale Cerca Rendita: L’Ascesa del Valore Azionario
Tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento, le grandi imprese nei paesi sviluppati hanno affrontato una crisi: i loro profitti diminuivano rispetto ai soldi investiti. La causa era l’esaurimento del vecchio modello produttivo basato sulla produzione di massa e su un’organizzazione rigida. Per contrastare questa crisi e rendere il capitale più redditizio, si è diffusa una nuova idea guida: massimizzare il valore per gli azionisti. Questo significa che l’obiettivo principale non è più solo fare profitti dalla produzione, ma far crescere il valore di mercato dell’impresa, cioè il prezzo delle sue azioni in borsa. Anche se un’impresa non genera subito grandi guadagni, l’aspettativa che il valore delle azioni aumenti diventa il motore principale degli investimenti.Investitori e il Focus sul Breve Termine
Un ruolo centrale in questo cambiamento è stato assunto dagli investitori istituzionali, come i fondi pensione e i fondi comuni. Questi enti gestiscono enormi capitali, cresciuti in modo esponenziale, e detengono quote significative e concentrate nelle imprese quotate. La loro influenza è forte, e la usano per spingere i manager a orientare le strategie verso l’aumento del valore azionario, anche con interventi diretti o negoziati riservati. L’attività di questi investitori promuove un orizzonte temporale breve, spesso chiamato “corto-termismo”. Mantengono le azioni per periodi limitati, a volte meno di due anni, e chiedono risultati rapidi, costringendo le imprese a concentrarsi su variazioni di valore quotidiane o trimestrali invece che su piani a lungo termine.Il Mercato Azionario e la Speculazione
A causa di questo focus sul breve termine imposto dagli investitori, la borsa si trasforma. Diventa un luogo dove il valore delle azioni è sempre più influenzato dalle aspettative future e dai comportamenti imitativi degli investitori, che tendono a seguire le mode del momento. Questo meccanismo può generare spirali speculative, dove il prezzo delle azioni sale o scende in modo scollegato dalla reale capacità produttiva dell’impresa, cioè da come l’azienda sta andando davvero. Di conseguenza, la funzione principale del mercato azionario diventa garantire che i titoli possano essere comprati e venduti facilmente (la liquidità) e far aumentare il loro valore di mercato. Al contrario, il ruolo della borsa nel finanziare direttamente le imprese attraverso la vendita di nuove azioni diventa sempre meno importante e marginale.Ma è davvero sufficiente invocare una “legge globale” e l’azione di “antagonisti” per domare un capitale che ha prosperato proprio sulla deregolazione, o il capitolo non sottovaluta le immense resistenze e la complessità di tale impresa?
Il capitolo, pur individuando correttamente la necessità di superare l’approccio volontario alla RSI e di contrastare la deregolazione, non approfondisce adeguatamente come si possa concretamente passare da questa constatazione a una “regolazione globale” efficace. La semplice menzione di “antagonisti” e di una generica “legge” non chiarisce i meccanismi politici, giuridici ed economici necessari per imporre regole vincolanti a livello transnazionale, né le immense resistenze che un tale processo incontrerebbe da parte degli attori economici dominanti e degli stati che beneficiano dello status quo. Per esplorare queste sfide, sarebbe utile approfondire gli studi di economia politica internazionale e le analisi sulle dinamiche di potere globale, leggendo autori come Susan Strange o David Harvey.7. Lo Stato competitivo e l’impresa globale
La globalizzazione cambia il modo in cui lo Stato agisce. Lo Stato diventa “competitivo”, cioè cerca di aiutare il proprio paese a fare meglio nel mercato globale. Questo cambiamento spesso include la vendita di aziende pubbliche e servizi a privati (privatizzazione). Le attività economiche che prima gestiva lo Stato passano così nelle mani delle imprese private.La responsabilità delle grandi aziende
In questo nuovo contesto, le grandi aziende che operano in molti paesi (transnazionali) hanno un ruolo enorme. Ci si chiede quanto siano responsabili delle loro azioni. Si parla di una certa “irresponsabilità d’impresa” e si sente il bisogno di regole più chiare. Per rispondere a questo, sono nate iniziative come la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) e codici di comportamento. Queste sono spesso volontarie, cioè le aziende scelgono liberamente se seguirle. Esistono anche organizzazioni nel mondo e leggi nei singoli paesi che suggeriscono come le aziende dovrebbero essere gestite meglio e in modo più trasparente.I limiti delle azioni volontarie
Molti però dubitano che queste azioni volontarie siano davvero efficaci. Alcuni pensano che siano usate più per migliorare l’immagine delle aziende che per garantire un vero rispetto per le persone o per l’ambiente. Anche se si cerca di rendere obbligatorio per le aziende dire cosa fanno per la società e l’ambiente (rendicontazione), è ancora difficile renderle legalmente responsabili per i danni che provocano.Le sfide del sistema globale
Il sistema economico globale di oggi affronta grandi problemi. Ci sono forti differenze economiche tra i paesi e anche tra le persone all’interno dello stesso paese. Molte persone vivono in una condizione di incertezza riguardo al lavoro e al futuro (insicurezza sociale). L’ambiente subisce un forte impatto; l’idea di “impronta ecologica” mostra che il modo in cui produciamo e consumiamo non è sostenibile. Inoltre, la finanza (banche, investimenti) ha un potere enorme, influenzando come si accumula la ricchezza e le regole del mondo degli affari.Davvero possiamo credere che la “responsabilità” delle multinazionali si risolva con iniziative volontarie, mentre lo Stato “competitivo” abdica al suo ruolo di garante e regolatore?
Il capitolo mette in luce le contraddizioni di un sistema globale dove il potere d’impresa cresce, ma la sua responsabilità legale resta elusiva. Tuttavia, non indaga a sufficienza le cause profonde di questa elusività, né chiarisce se la trasformazione dello Stato in attore “competitivo” abbia indebolito la sua capacità di imporre regole vincolanti a tutela dei diritti e dell’ambiente. Per esplorare queste dinamiche, è fondamentale studiare la teoria critica dello Stato, le analisi sulla finanziarizzazione dell’economia e le critiche ai modelli di governance globale. Autori come Saskia Sassen, Wolfgang Streeck, o Robert Wade offrono chiavi di lettura essenziali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]