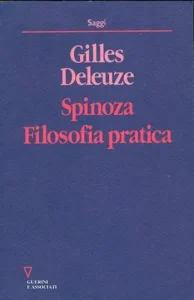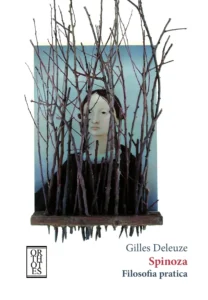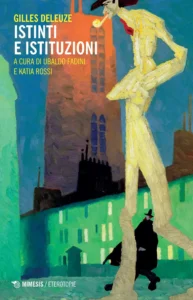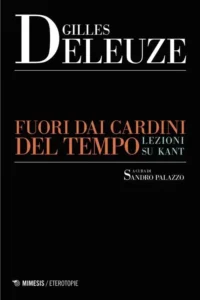1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“L’immagine-movimento. Cinema 1” di Gilles Deleuze non è il solito libro sul cinema, è un viaggio pazzesco dentro come funzionano le immagini e il tempo sullo schermo. Deleuze parte dall’idea che il movimento nel cinema non è solo mettere insieme foto statiche, ma è qualcosa di vivo, una “sezione mobile della durata”, che lui chiama “immagine-movimento”. Spiega come il “montaggio” non sia solo tecnica, ma crei un’immagine indiretta del tempo, e analizza come diverse scuole di “teoria del cinema”, dall’americana alla sovietica, lo usano in modi diversi. Poi si addentra nelle “immagini viventi”, che sono come centri di indeterminazione nell’universo di immagini, e le divide in tre tipi fondamentali: l'”immagine-percezione” (come vediamo le cose), l'”immagine-azione” (come reagiamo e modifichiamo gli “ambienti specifici”), e l'”immagine-affezione” (come ci sentiamo dentro, spesso legata al volto o a “spazi qualsiasi” indefiniti). È affascinante vedere come queste idee si manifestano nei film, esplorando anche le “pulsioni” che emergono da “mondi originari” o le diverse “forme” dell’azione, dalla grande forma (SAS’) alla piccola forma (ASA’). Ma il libro non si ferma qui, introduce l'”immagine mentale”, che riguarda le relazioni e il pensiero, e mostra come questa porti a una vera e propria “crisi dell’immagine-azione” nel cinema del dopoguerra, dove i legami si rompono e emergono i cliché. È un modo super stimolante di pensare il cinema, non come semplice storia o tecnica, ma come un modo per capire il movimento, il tempo e persino la mente stessa.Riassunto Breve
Il movimento non è lo spazio percorso, che si può dividere, ma l’atto di percorrere, che è un tutt’uno e accade ora. Non si può capire il movimento mettendo insieme punti fermi o momenti immobili. Il movimento vero esiste in una durata che cambia sempre. Pensare il movimento da punti fissi può farlo in due modi: quello antico usa “momenti importanti” per mostrare forme eterne, vedendo il movimento come un passaggio ordinato; quello moderno usa “momenti qualsiasi” per analizzare il movimento con elementi materiali e una serie di istanti uguali. Il cinema, all’inizio, sembrava fare come il pensiero antico, mettendo insieme immagini fisse (i fotogrammi). Ma il cinema più evoluto, con il montaggio e la telecamera che si muove, crea “immagini-movimento”. Queste non sono immagini ferme a cui si aggiunge movimento, ma immagini dove il movimento è già presente. Il movimento è una parte che si muove della durata, che è il cambiamento continuo del Tutto. Ogni spostamento nello spazio mostra un cambiamento nel Tutto. Il Tutto non è un insieme chiuso, ma è Aperto e cambia sempre. Gli insiemi stanno nello spazio, il Tutto sta nella durata. Il movimento collega le cose di un insieme al Tutto che cambia. L’inquadratura definisce un insieme chiuso, con un punto di vista e un fuori campo che può rimandare ad altri insiemi o al Tutto invisibile. Il piano, definito dal montaggio, è il movimento che si crea nell’insieme inquadrato. È l’immagine-movimento, una parte mobile della durata. La telecamera mobile e il montaggio liberano il movimento dalle cose, creando il movimento puro. Il piano è come una prospettiva nel tempo che fa cambiare gli elementi e si lega a un Tutto aperto. Il montaggio unisce le immagini-movimento e crea un’immagine del tempo che non si vede direttamente. Questo tempo ha due lati: l’intervallo, che è il presente che cambia, e il tutto, che è il passato e il futuro. Diverse scuole di cinema usano il montaggio in modi diversi. La scuola americana (Griffith) unisce le parti per fare un’unità. La scuola sovietica (Eisenstein) usa contrasti e salti. La scuola francese (d’anteguerra) organizza il movimento nello spazio. L’espressionismo tedesco usa luce e ombra per mostrare intensità. Immagine e movimento sono la stessa cosa, sono la materia. L’universo è un piano dove le immagini agiscono e reagiscono. Dove ci sono esseri viventi, ci sono intervalli tra azione e reazione. Questi intervalli creano le immagini viventi, che scelgono e organizzano le azioni esterne per percepire e reagire in modo non immediato. Quando le immagini-movimento si legano a un centro vivente, diventano di tre tipi: immagine-percezione (l’esterno scelto), immagine-azione (la reazione organizzata), immagine-affezione (il sentire interno, tra percezione e azione). L’immagine-affezione si vede nel cinema soprattutto con il primo piano, spesso sul volto, che mostra una qualità o una potenza pura, staccata dallo spazio e dal tempo. Il primo piano rende il soggetto un’Entità, un affetto puro. L’immagine-affezione appare anche negli “spazi qualsiasi”, luoghi senza coordinate precise dove qualità e potenze sono esposte direttamente, come negli spazi creati dall’espressionismo (ombre), dall’astrazione lirica (luce) o dal colorismo (colore). L’immagine-azione si manifesta quando qualità e potenze si concretizzano in ambienti specifici. Tra immagine-affezione e immagine-azione c’è l’immagine-pulsione, che lega mondi primordiali e energie grezze, esplorata dal naturalismo. L’immagine-azione si concentra sul rapporto tra ambienti definiti e comportamenti. L’ambiente è una situazione che spinge il personaggio all’azione per cambiarla (grande forma S-A-S’). Questa forma si trova nel western o nel film storico. C’è anche la piccola forma (A-S-A’), dove l’azione iniziale svela una situazione nascosta, tipica del film poliziesco o della commedia di costume, usando l’indizio. Le forme possono trasformarsi (Figure), come in Hitchcock che introduce l’immagine mentale, o terzità, che riguarda le relazioni, il significato e la legge. Le relazioni sono esterne alle cose che legano. Hitchcock mostra come le relazioni cambiano l’azione. Dopo la guerra, l’immagine-azione va in crisi. I legami tra situazione e azione si indeboliscono. Le situazioni sono frammentate, gli spazi indifferenti, e domina il girovagare. Ciò che lega tutto sono i cliché, immagini e suoni che circolano. Questa crisi rompe lo schema classico e cerca un’immagine autonoma oltre i cliché.Riassunto Lungo
1. Il movimento, la durata e l’immagine in movimento
Il movimento non è semplicemente lo spazio che viene percorso, che è qualcosa che possiamo dividere in parti e che appartiene al passato. È invece l’atto stesso di percorrere, un processo che non si può dividere e che si svolge nel presente. Non si può capire il movimento vero mettendo insieme posizioni fisse nello spazio o momenti immobili nel tempo, pensando a una semplice successione. Fare così significa perdere il movimento reale, quello che avviene in un tempo concreto che scorre, chiamato durata.Diversi modi di vedere il movimento
Ci sono stati storicamente due modi principali di pensare il movimento partendo da momenti singoli. Il pensiero antico lo legava a “momenti speciali” o “pose”, che rappresentavano forme perfette e immutabili. Il movimento era visto come il passaggio ordinato tra queste forme fisse. La scienza moderna, invece, si concentra su un “momento qualsiasi”, analizzando il movimento attraverso le parti materiali che lo compongono e una successione meccanica di istanti tutti uguali tra loro. Entrambi questi approcci, a loro modo, tendono a non cogliere la natura continua e vivente del movimento.Il cinema e l’immagine-movimento
All’inizio, il cinema sembrava confermare l’idea di poter ricostruire il movimento da immagini statiche (come i fotogrammi) e da un tempo astratto, un po’ come pensavano gli antichi o come percepiamo comunemente le cose. Ma il cinema si è evoluto. Attraverso tecniche come il montaggio e l’uso di telecamere che si muovono, ha creato quelle che possiamo chiamare “sezioni mobili” o “immagini-movimento”. Queste non sono immagini ferme a cui si aggiunge il movimento; sono immagini in cui il movimento è già presente, è una loro caratteristica immediata. Il movimento è come una fetta in continuo cambiamento della durata, che è il flusso costante di tutto ciò che esiste. Ogni spostamento nello spazio mostra un cambiamento nella qualità di questo Tutto.L’inquadratura e il Tutto
Il “Tutto” non è un insieme chiuso di parti; è qualcosa di aperto, che cambia senza fermarsi. Gli insiemi di oggetti si trovano nello spazio, ma il Tutto si trova nella durata che scorre. Il movimento collega gli oggetti di un insieme al Tutto che cambia e che loro stessi manifestano. Riporta gli oggetti dalla chiusura di un sistema alla durata che è aperta, e riporta la durata agli oggetti che essa spinge ad aprirsi. L’inquadratura, cioè quello che vediamo dentro il bordo dello schermo, definisce un sistema chiuso, un insieme di parti. Questo sistema serve a dare informazioni, a definire uno spazio e un punto di vista. L’inquadratura determina anche ciò che sta fuori dallo schermo, il “fuori campo”. Questo fuori campo ha due aspetti: uno relativo, che rimanda ad altre parti dello spazio che potremmo vedere dopo, e uno assoluto, che rimanda al Tutto, alla durata, a una presenza che non vediamo ma percepiamo.Il piano come immagine in movimento
Il “piano”, così come è definito dal modo in cui il film è tagliato e montato (“découpage”), è il movimento che si crea all’interno di ciò che è stato inquadrato. Ha due facce: da un lato mostra il rapporto tra le diverse parti dentro l’inquadratura, dall’altro esprime il cambiamento che avviene nel Tutto. Il piano è l’immagine-movimento, una sezione mobile della durata. Agisce quasi come una sorta di “coscienza” del film, dividendo la durata tra i diversi oggetti e riunendo gli oggetti dentro la durata che scorre. La possibilità di muovere la telecamera e il modo in cui le scene sono montate liberano il movimento dagli oggetti che si muovono, creando quasi un “movimento puro”. Il piano, essendo una sezione mobile, è come una prospettiva sul tempo che fa cambiare gli elementi inquadrati e si riferisce a un Tutto che è aperto e in continuo cambiamento. L’unità di un piano sta proprio in questa unità di movimento o in questa prospettiva sul tempo che offre. Anche i “falsi raccordi”, cioè quei momenti in cui sembra esserci una rottura nella continuità tra una scena e l’altra, non sono solo errori, ma possono essere visti come manifestazioni di questo “Aperto”, del Tutto che sfugge agli insiemi chiusi definiti dall’inquadratura.Ma siamo sicuri che concetti così astratti come la “durata” o il “Tutto” offrano davvero una chiave di lettura concreta e universalmente valida per capire il cinema, o non siano piuttosto costruzioni teoriche che rischiano di allontanarsi dalla pratica filmica?
Il capitolo introduce concetti filosofici profondi come la durata e il Tutto per definire il movimento e l’immagine cinematografica. Tuttavia, il modo in cui questi concetti si traducano concretamente nell’analisi dei film o nella loro produzione potrebbe non essere immediatamente chiaro per chi non ha familiarità con questo specifico approccio teorico. La distinzione netta tra i modi storici di pensare il movimento e la “vera” natura del movimento, così come la definizione del piano come “coscienza” del film, si basano su premesse che potrebbero essere considerate più interpretative che oggettive. Per esplorare a fondo queste tematiche e valutare la solidità di tale impianto concettuale, è utile approfondire la filosofia del tempo e del movimento, in particolare il pensiero di Henri Bergson, da cui derivano molte delle idee esposte. È altrettanto importante confrontare questa prospettiva con altre teorie del cinema che adottano approcci differenti, magari più legati all’analisi formale, semiotica o storica del linguaggio filmico, per comprendere i limiti e i punti di forza di ciascun quadro interpretativo.2. Le diverse facce del montaggio
Unendo le immagini-movimento, il montaggio crea un’immagine indiretta del tempo. Questo tempo non è quello lineare che misuriamo con l’orologio, ma ha due aspetti fondamentali che si intrecciano: l’intervallo, che rappresenta il presente in continuo cambiamento, e il tutto, che abbraccia l’immensità del passato e del futuro. Il modo in cui il montaggio realizza questa composizione varia notevolmente tra le diverse scuole cinematografiche, ognuna con una visione unica di come dare forma a questi elementi temporali.L’approccio americano: composizione organica
La scuola americana, con figure come Griffith, punta a una composizione organica. Usando il montaggio parallelo e quello convergente, mettono insieme diverse parti e azioni per creare un’unica scena coerente e unita. Il primo piano, poi, non solo cambia la dimensione delle immagini, ma aggiunge anche un punto di vista più personale e soggettivo, quasi come se vedessimo attraverso gli occhi di qualcuno. In questo approccio, il tempo è percepito in modo pratico e concreto, sia come intervallo che come totalità empirica, legata all’esperienza diretta e osservabile.La visione sovietica: composizione dialettica
Passando alla scuola sovietica, con registi importanti come Eisenstein, Pudovkin, Dovženko e Vertov, troviamo un approccio basato sulla composizione dialettica. Qui si usano il montaggio di opposizione e i salti improvvisi per mostrare il passaggio tra idee o situazioni opposte e per dare più forza ed energia alle immagini che si susseguono. Il tempo, in questa visione, è visto sia come intervallo che si manifesta attraverso questi salti, sia come una totalità che si costruisce e prende forma man mano che le immagini si scontrano e si uniscono. Vertov, in particolare, si concentra su come questa dialettica emerga dalla materia stessa delle immagini filmate.La scuola francese d’anteguerra: composizione quantitativa
La scuola francese d’anteguerra si concentra invece sulla quantità di movimento, seguendo una composizione quantitativa. Utilizzano “macchine” cinematografiche, semplici o complesse, per organizzare e misurare il movimento nello spazio del film. Il tempo, in questo contesto, è inteso sia come intervallo che è un’unità numerica che può variare (una quantità relativa), sia come simultaneità (una quantità assoluta, quasi un “sublime matematico” nella sua vastità e complessità). C’è una chiara distinzione tra ciò che è materiale e ciò che è spirituale nel modo in cui il movimento e il tempo sono rappresentati in questo stile.L’espressionismo tedesco: composizione intensiva
Infine, l’espressionismo tedesco adotta una composizione intensiva. Questo stile si basa molto sul forte contrasto tra luce e ombra e sull’idea che le cose inanimate possano avere una sorta di “vita non-organica” o un’energia propria. La geometria usata nelle inquadrature è spesso distorta o esagerata (prospettivista) e crea un senso di accumulo o tensione visiva che aumenta l’impatto emotivo. Il tempo è percepito come un istante, un punto di massima intensità, e questa intensità può crescere all’infinito (un “sublime dinamico” che travolge lo spettatore). In questo approccio, l’idea di una vita nelle cose inanimate si lega a uno spirito che non è semplicemente psicologico, ma qualcosa di più profondo e inquietante.Queste diverse scuole mostrano chiaramente come il montaggio, collegando ogni singola immagine al quadro generale, riesca a dare forma all’immagine indiretta del tempo in modi unici, definendo ogni volta in maniera differente il presente che cambia e l’immensità che lo circonda.Ma è davvero così automatico che un certo tipo di montaggio generi quella specifica percezione del tempo, o non si rischia di proiettare categorie filosofiche su scelte tecniche post-hoc?
Il capitolo descrive affascinanti corrispondenze tra le tecniche di montaggio delle diverse scuole e complesse idee sul tempo, ma la connessione appare talvolta più un’associazione descrittiva che una dimostrazione rigorosa. Come si passa precisamente dall’uso di un primo piano alla “totalità empirica” americana, o dai salti sovietici a una “totalità che si costruisce”? La mancanza di un’analisi più approfondita del perché questa relazione esista lascia spazio al dubbio che si tratti di interpretazioni teoriche applicate a posteriori, piuttosto che di effetti intrinseci e univoci delle tecniche stesse. Per indagare questa critica, è fondamentale esplorare le basi teoriche del montaggio e la filosofia del tempo nel cinema, leggendo autori come Gilles Deleuze, che ha dedicato studi fondamentali all’argomento, o approfondendo direttamente gli scritti teorici dei registi citati (Eisenstein, Vertov), per capire le loro intenzioni e giustificazioni.3. L’immagine in movimento e i suoi stati
La psicologia ha affrontato un momento di cambiamento profondo quando è diventato chiaro che non era più possibile tenere separate le immagini nella coscienza dai movimenti che avvengono nello spazio. Il superamento di questa separazione porta a riconoscere un’idea fondamentale: l’immagine e il movimento sono in realtà la stessa cosa. Questa immagine-movimento costituisce la materia stessa dell’universo. L’universo viene visto come un vasto piano dove infinite immagini interagiscono e reagiscono continuamente tra loro, in un flusso costante di cambiamento che diffonde luce ovunque.L’emergere degli esseri viventi
All’interno di questo piano universale di immagini in costante variazione, possono comparire dei punti particolari in cui si crea un intervallo. Questi intervalli non sono vuoti, ma definiscono l’esistenza delle immagini viventi, che diventano dei veri e propri centri di indeterminazione. Un essere vivente, in quanto centro di indeterminazione, non si limita a reagire immediatamente a ogni azione esterna che riceve. Al contrario, riceve le azioni solo su specifiche parti di sé e reagisce solo attraverso altre parti, operando una selezione tra le infinite azioni che provengono dall’esterno per costruire la propria percezione del mondo. La reazione non è più un riflesso immediato, ma è ritardata, e questo ritardo permette all’essere vivente di scegliere, organizzare e dare vita a un’azione nuova e originale.Le tre forme dell’immagine
Quando le immagini-movimento vengono considerate in relazione a uno di questi centri di indeterminazione, si manifestano in tre forme distinte. La prima è l’immagine-percezione: questa è l’immagine esterna che viene selezionata e messa a fuoco dal centro, una sorta di “presa” parziale e personale della realtà circostante. Non è la cosa in sé, ma il modo in cui essa appare a quel centro specifico. La seconda è l’immagine-azione: rappresenta la reazione non immediata del centro. È il momento in cui il centro organizza una risposta al mondo percepito, piegando l’universo che ha percepito in funzione dell’azione che è in grado di compiere. La terza è l’immagine-affezione: questa si colloca nell’intervallo, nel tempo sospeso tra la percezione e l’azione. È il modo in cui il soggetto sente se stesso interiormente, una qualità o una spinta motoria che si manifesta su una superficie ricettiva che, in quel momento, sembra immobile.L’immagine in movimento nel cinema
Queste diverse manifestazioni dell’immagine trovano un terreno fertile nel cinema, dove vengono esplorate in molteplici modi. L’immagine-percezione può essere presentata in modo oggettivo, mostrando semplicemente ciò che accade, oppure in modo soggettivo, attraverso gli occhi o i sensi di un personaggio. Spesso, però, il cinema sperimenta forme più complesse, come la “semi-soggettiva” o la “soggettiva indiretta libera”, dove è quasi la “coscienza” della macchina da presa a modellare la percezione che lo spettatore ha della realtà vista dal personaggio, andando oltre la semplice identificazione. Il cinema ha anche la capacità di spingersi oltre la percezione umana, esplorando stati come la “percezione liquida”, che supera la visione del mondo basata su oggetti solidi, o la “percezione gassosa”, che sembra raggiungere un livello quasi molecolare, mostrando il fotogramma non solo come un’unità statica, ma come l’elemento fondamentale che genera l’immagine e il suo continuo variare.Su quali basi teoriche si fonda questa distinzione apparentemente rigida tra due sole forme dell’immagine-azione?
Il capitolo presenta la divisione dell’immagine-azione in due forme principali (SAS´ e ASA´) come un dato di fatto, descrivendone le caratteristiche e le “Figure” di trasformazione, ma omette di esplicitare il contesto teorico da cui tale classificazione deriva. Questa lacuna impedisce di comprendere appieno la genesi e la validità di questo modello, lasciando il lettore senza gli strumenti per valutarne i presupposti e i limiti. Per colmare questa mancanza e capire su quali fondamenti poggia questa analisi, è indispensabile risalire all’autore che ha elaborato questa specifica teoria dell’immagine cinematografica, Gilles Deleuze. Approfondire il suo pensiero e confrontare questo approccio con altre teorie del cinema (come quelle semiotiche o strutturaliste) è cruciale per contestualizzare e criticare in modo informato quanto esposto nel capitolo.7. La Mente sullo Schermo: Relazioni e Crisi dell’Azione
C’è un terzo tipo di immagine, diverso da quelle che mostrano sentimenti o azioni: è l’immagine mentale. Questa immagine riguarda i legami, il significato delle cose e le regole. Questi elementi non si limitano a un semplice rapporto causa-effetto tra due cose, come spesso accade nell’azione. Il legame tra le cose è sempre qualcosa di esterno a esse. Possiamo distinguere legami naturali, che creano sequenze di immagini, e legami astratti, che formano un insieme più complesso.Hitchcock e i Legami Nascosti
Alfred Hitchcock è stato il primo a portare l’immagine mentale nel mondo del cinema. Nei suoi film, l’azione non è vista da sola, ma è sempre circondata da una rete di legami che cambiano il suo vero significato e scopo. Quello che diventa importante non è tanto chi fa cosa, ma l’insieme delle relazioni in cui chi agisce e l’azione stessa sono inseriti. Pensiamo a un crimine: non è solo un atto compiuto, ma può essere qualcosa che viene scambiato o passato a qualcun altro, diventando parte di un gioco più grande. Il legame è un elemento cruciale che entra nell’azione e la trasforma in qualcosa di simbolico. È la telecamera, più che i personaggi o i dialoghi, a mostrare questi legami mentali. Ci sono segni particolari che li rivelano, come oggetti comuni che improvvisamente assumono un significato speciale o simboli che portano con sé intere relazioni. Hitchcock spinge al massimo le possibilità dell’immagine basata sul movimento, coinvolgendo anche lo spettatore in questa complessa rete di relazioni. Questa sua attenzione particolare ai legami, però, anticipa in qualche modo un momento di difficoltà per l’immagine basata sull’azione.La Crisi dell’Azione dopo la Guerra
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema attraversa un periodo di crisi per l’immagine basata sull’azione. I collegamenti chiari tra una situazione e l’azione che ne deriva, o tra un’azione e la sua conseguenza, diventano più deboli. Non c’è più la convinzione che un’azione singola possa davvero cambiare una situazione generale. Compaiono nuove caratteristiche: le situazioni appaiono frammentate e sparse, i legami tra gli eventi e i luoghi sono fragili, e spesso si vede un vagare senza uno scopo preciso in ambienti che sembrano tutti uguali. Quello che tiene insieme, in modo strano, questo mondo frammentato sono i cliché, cioè immagini e suoni ripetitivi e impersonali che circolano ovunque, sia fuori che dentro le persone. Si diffonde la sensazione di un complotto generale che organizza e diffonde questi cliché. Questa crisi, molto visibile nel cinema americano del dopoguerra ma nata anche nel Neorealismo italiano e nella Nouvelle Vague francese, mette in discussione il modo tradizionale in cui percepiamo e reagiamo al mondo (lo “schema sensorio-motorio”).In questo scenario, la nuova immagine mentale non serve a completare o riparare l’immagine basata sull’azione, ma piuttosto a romperne il sistema. Cerca di trovare una sua strada autonoma, andando oltre i cliché che dominano il mondo frammentato.Ma cos’è esattamente questa “immagine mentale” e come la si distingue sullo schermo senza cadere nel vago?
Il capitolo introduce il concetto di “immagine mentale” come distinta da quelle di sentimento o azione, legata a “legami, significato, regole”. Tuttavia, la sua definizione e, soprattutto, la sua manifestazione sullo schermo rimangono piuttosto astratte. Come si concretizza visivamente un “legame astratto” o un “significato” in modo univoco, al di là dell’interpretazione? Il capitolo menziona segni particolari, oggetti comuni che assumono significato, o simboli, ma questi possono essere elementi di qualsiasi tipo di immagine cinematografica. Manca una chiara distinzione operativa. Per comprendere meglio come concetti astratti o “mentali” possano essere resi visivamente nel cinema, e per esplorare le teorie che sottendono queste distinzioni tra tipi di immagini, sarebbe utile approfondire la filosofia del cinema e la teoria del montaggio. Autori come Deleuze, Eisenstein o Bazin offrono prospettive diverse su come il cinema costruisce significato e rappresenta la realtà o il pensiero.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]