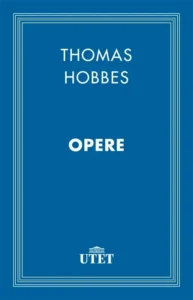1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Leviatano” di Thomas Hobbes… questo libro è una bomba, scritto in un’epoca di casino totale, guerre civili e robe religiose che spaccavano tutto. Hobbes si inventa una soluzione radicale per uscirne: lo stato moderno, il Leviatano appunto. Parte dall’idea di come siamo messi senza regole, nello stato di natura, dove è una guerra di tutti contro tutti, una vita da incubo, solitaria e brutale. Per scampare a ‘sta roba, gli individui si mettono d’accordo, fanno un contratto sociale e danno tutto il loro potere a un sovrano assoluto. È lui, il Leviatano, che diventa lo Stato, l’unica autorità che può garantire pace e sicurezza. Non è solo politica, Hobbes analizza pure come pensiamo, come usiamo il linguaggio, le nostre passioni, il desiderio di potere che ci muove. E poi si butta sulla religione, spiegando che pure lì, nel regno terreno, è il sovrano civile che comanda, non il potere spirituale separato. È un testo fondamentale per capire la filosofia politica moderna, la teoria dello stato, e ti fa pensare un sacco su libertà, obbedienza e perché accettiamo di essere governati. È un viaggio nella mente di un genio che cercava l’ordine nel caos.Riassunto Breve
La condizione umana originaria è uno stato di natura dominato dalla paura e dal desiderio di autoconservazione, dove gli individui, mossi da appetiti e avversioni, vivono in conflitto costante, una guerra di tutti contro tutti, rendendo la vita precaria e breve. Per superare questo disordine, gli uomini stipulano un patto sociale, cedendo il diritto di governare sé stessi a un sovrano assoluto, il Leviatano, creando così un potere comune irresistibile che garantisce pace e sicurezza. Questo Stato moderno è un costrutto artificiale, razionale, che monopolizza la forza e la politica, riducendo la pluralità a unità. La politica si basa su concetti come diritto naturale (libertà di usare il proprio potere per l’autoconservazione), legge di natura (principio razionale che impone la ricerca della pace e la rinuncia al diritto su tutto), contratto (trasferimento reciproco di diritti) e sovranità (potere assoluto del Leviatano). La legge civile, espressione della volontà sovrana, definisce giusto e ingiusto, incorporando la legge naturale e limitando la libertà individuale per la coesistenza pacifica. La ragione umana si manifesta come calcolo di nomi generali, e la scienza è la conoscenza delle conseguenze derivata da definizioni precise. Le passioni, come appetito e avversione, guidano il movimento volontario, e il desiderio incessante di potere caratterizza la natura umana, generando competizione e conflitto. La paura della morte e il desiderio di agi spingono all’obbedienza verso un potere comune. L’ignoranza delle cause naturali alimenta superstizione e religione, che ha radici nell’ansia per il futuro e nella credulità. La sicurezza degli individui è la ragione fondamentale della formazione dello Stato, poiché le leggi naturali non bastano senza una forza coercitiva. La generazione dello Stato avviene con la cessione del potere individuale a un sovrano, che detiene diritti indivisibili e inalienabili (legislativo, giudiziario, esecutivo, militare, dottrinale) essenziali per mantenere la pace. La monarchia è vista come una forma di Stato con specifici vantaggi, sebbene qualsiasi forma di governo con potere sovrano sia preferibile all’anarchia. Uno stato può nascere anche per acquisizione (conquista), ma i diritti del sovrano sono identici a quelli di uno stato per istituzione, fondandosi sempre sul consenso (implicito o esplicito) dei sottomessi. La libertà civile è l’assenza di impedimenti esterni definiti dalle leggi, non un’assenza di potere sovrano. I sistemi di persone (corporazioni, fazioni) sono legittimi solo se autorizzati dal sovrano. La sussistenza dello stato dipende dalla distribuzione sovrana delle risorse e dalla regolamentazione del commercio, con il denaro che funge da “sangue” dello stato. Il consiglio si distingue dal comando, mirando al beneficio di chi lo riceve, e richiede consiglieri competenti e con interessi allineati allo stato. Uno stato rischia la dissoluzione per difetti interni, come la mancanza di potere assoluto del sovrano, dottrine sediziose (giudizio individuale contro legge, coscienza contro legge, sovrano soggetto a legge, proprietà privata assoluta), la divisione del potere sovrano, l’imitazione di governi stranieri, la coesistenza di poteri civili e spirituali separati, difficoltà finanziarie, popolarità eccessiva di sudditi, grandezza di città o corporazioni autonome. Il compito principale del sovrano è garantire la sicurezza e il benessere del popolo attraverso leggi giuste e istruzione pubblica, mantenendo intatti i diritti sovrani e promuovendo obbedienza e concordia. La giustizia deve essere amministrata equamente, le tasse proporzionate, e lo stato deve provvedere ai bisognosi. Le leggi devono essere chiare e necessarie. Le punizioni mirano alla deterrenza e correzione, le ricompense incentivano il servizio. La politica cristiana si fonda sulla ragione e sulla parola profetica, con la ragione che riconosce i limiti di fronte ai misteri della fede. Le Scritture canoniche hanno autorità come legge solo per volontà del sovrano terreno. Il regno di Dio è una sovranità civile, fondata su un patto, e la vita eterna e il tormento eterno sono intesi come realtà terrestri. La Chiesa, in senso politico, è una società di credenti uniti sotto un sovrano; non esiste una Chiesa universale con autorità sovranazionale. Governo civile e religioso coincidono nel potere temporale del sovrano, che è l’autorità suprema nell’interpretazione delle Scritture nel suo dominio. L’ufficio del Messia si articola in redentore, pastore e re, ma il suo regno glorioso è futuro e non di questo mondo. Il potere ecclesiastico, prima della conversione dei sovrani, era un’autorità di insegnamento non coercitiva; la fede non può essere forzata. La scomunica era una misura interna alla comunità di fede. Il sovrano cristiano è il pastore supremo nel suo dominio. Si criticano le rivendicazioni di potere eccessivo del clero, in particolare del Papa, denunciando dottrine come purgatorio e transustanziazione come errori che creano “tenebre spirituali” e minano l’obbedienza civile. Il Regno di Dio non coincide con la Chiesa terrena, e il Papa non è vicario di Cristo con autorità terrena. Si contesta l’idea che i re derivino autorità dai vescovi o dal Papa. Credenze in demoni e idolatria derivano da errori sulla percezione e l’immaginazione, e la filosofia scolastica ha introdotto ulteriori oscurità. Il papato è visto come uno spettro dell’impero romano, un regno basato su ignoranza e superstizione. Non esiste una vera opposizione tra natura umana e doveri civili; la difesa dell’autorità protettiva è una legge naturale fondamentale. La sottomissione a un conquistatore si basa sul consenso in cambio di protezione. Giustificare il potere sovrano solo sulla conquista passata è un errore che mina la stabilità. La dottrina che stabilisce un governo civile ed ecclesiastico stabile si fonda su principi veri e ragionamenti solidi, radicati nella natura umana e nelle leggi divine e naturali, e mira a promuovere pace e lealtà attraverso la conoscenza dei doveri civili e della relazione tra protezione e obbedienza.Riassunto Lungo
1. Leviatano: Genesi dello Stato Moderno
Leviatano nasce in un periodo storico caratterizzato da guerre civili di religione. Si propone come una risposta razionale al disordine, allontanandosi dalle morali tradizionali e dalle teologie. Inizia così una nuova idea di politica, vista come una “scienza nuova”. Hobbes descrive la condizione umana all’origine della società, chiamata stato di natura. In questa situazione, le persone sono spinte dalla paura e dal desiderio di sopravvivenza e vivono in modo precario e conflittuale. La vita in questo stato è “solitaria, misera, sgradevole, brutale e breve”.Per uscire da questa condizione, le persone decidono di stringere un patto sociale. Con questo patto, rinunciano al diritto di governare sé stessi e lo cedono a un sovrano assoluto, chiamato Leviatano. Questo patto è un atto di unione, non di sottomissione. Crea un potere comune molto forte, capace di garantire pace e sicurezza. Il Leviatano rappresenta quindi lo Stato moderno, costruito in modo razionale. Questo Stato ha il controllo totale sulla politica e sulla forza, portando l’unità e superando ogni divisione.I concetti fondamentali del Leviatano
La politica di Hobbes si basa su alcuni concetti chiave: soggetto, diritto naturale, contratto, rappresentanza e sovranità. La legge diventa l’espressione della volontà del sovrano e definisce ciò che è giusto, superando le idee tradizionali di giustizia naturale o divina. Lo Stato, nato dal patto sociale, è sia religioso che civile. Questa caratteristica riflette la necessità di risolvere i conflitti religiosi, mettendo il potere religioso sotto quello del sovrano.Nonostante la sua logica razionale, il Leviatano presenta delle contraddizioni. Lo stato di natura, anche se è una condizione da superare, sembra quasi una prigione da cui non si può uscire. Il soggetto, che crea lo Stato, si trova poi in una condizione di servitù volontaria, sottomesso al potere sovrano che lui stesso ha contribuito a creare. La politica moderna, che inizia con il Leviatano, mostra quindi una natura ambivalente. Oscilla tra il desiderio di ordine e la realtà del disordine, tra la costruzione razionale e gli eventi storici imprevedibili. Il Leviatano, pur essendo legato a un periodo storico specifico, ha influenzato profondamente il pensiero politico moderno. Ha definito le categorie e le logiche dello Stato sovrano. La sua eredità è ancora presente oggi e influenza il modo in cui comprendiamo lo Stato e la politica, anche in un’epoca in cui ci si interroga sui limiti e sul futuro dello Stato stesso.Se il patto sociale è un atto di unione e non di sottomissione, come si spiega la condizione di “servitù volontaria” in cui si trova il soggetto una volta costituito il Leviatano?
Il capitolo presenta il patto sociale come una scelta razionale per sfuggire al caos dello stato di natura, ma non approfondisce le implicazioni di tale scelta sulla libertà individuale. Se il soggetto crea lo Stato per garantire la propria sicurezza, ma finisce per trovarsi in una condizione di sottomissione al sovrano, non si rischia di sostituire un tipo di prigione (lo stato di natura) con un’altra (lo Stato assoluto)? Per rispondere a questa domanda, è utile approfondire le teorie del contrattualismo e le critiche che sono state mosse al pensiero di Hobbes, ad esempio da autori come Locke e Rousseau, che hanno offerto interpretazioni alternative del patto sociale e del rapporto tra individuo e Stato.2. L’Origine e il Flusso del Pensiero
La Nascita del Pensiero dalle Sensazioni
Ogni pensiero nasce nel momento in cui un oggetto esterno agisce sui nostri sensi. Questa azione sensoriale si crea quando qualcosa da fuori preme sui nostri organi di senso. Questo contatto genera un movimento interno che viaggia fino al cervello e al cuore. La nostra percezione delle qualità sensibili, come luce, suono, odore, sapore, caldo e freddo, è in realtà la nostra reazione a questo movimento interno. Quindi, queste qualità non sono caratteristiche proprie degli oggetti esterni. Sono, invece, movimenti di materia che colpiscono i nostri organi in modi diversi, creando quelle che chiamiamo fantasie o apparenze.Immaginazione, Memoria ed Esperienza
L’immaginazione è come un senso più debole, è il ricordo sbiadito di un’impressione sensoriale che rimane anche quando l’oggetto che l’ha causata non c’è più. In realtà, immaginazione e memoria sono quasi la stessa cosa. La differenza sta solo nel tempo: parliamo di immaginazione quando ci riferiamo al presente, e di memoria quando ci riferiamo al passato. L’esperienza si forma accumulando ricordi di molte immaginazioni diverse.Il Pensiero Regolato e la Prudenza
Il pensiero non è un processo che avviene a caso. Segue sempre un ordine, un flusso mentale. Questo flusso può essere libero, come quando sogniamo, oppure può essere guidato dai nostri desideri e obiettivi. Quando il pensiero è regolato, diventa fondamentale per la ricerca e per scoprire cose nuove. Ci permette, infatti, di indagare le cause e gli effetti degli eventi. La prudenza, cioè la capacità di prevedere ciò che accadrà, nasce proprio dall’esperienza. L’esperienza ci consente di immaginare il futuro basandoci su ciò che è successo in passato. È importante ricordare, però, che questa prudenza è sempre una supposizione, non una certezza assoluta.Linguaggio, Limiti dell’Immaginazione e Pensiero Finito
A differenza degli animali, gli esseri umani sviluppano una comprensione più complessa. Questa comprensione va oltre le semplici sensazioni e arriva fino ai concetti astratti e ai pensieri, soprattutto grazie al linguaggio. Nonostante questa capacità superiore, l’immaginazione umana ha dei limiti naturali: è confinata al mondo del finito. Quando pensiamo all’infinito, in realtà non lo concepiamo pienamente. Piuttosto, riconosciamo che la nostra mente non è in grado di immaginare confini. Di conseguenza, ogni pensiero umano è inevitabilmente legato a ciò che percepiamo con i sensi, limitato a dimensioni e luoghi specifici. Per questo motivo, le riflessioni filosofiche che si allontanano troppo dalla realtà concreta e sensoriale perdono di significato.Ma se ogni pensiero deriva dai sensi, come possiamo spiegare l’esistenza di concetti astratti e idee innate che sembrano trascendere la pura esperienza sensoriale?
Questo capitolo presenta una visione del pensiero che radica ogni processo cognitivo nelle sensazioni, suggerendo che l’esperienza sensoriale sia l’unica fonte della nostra comprensione del mondo. Tuttavia, questa prospettiva solleva interrogativi importanti riguardo alla natura di concetti astratti, principi logici e idee innate che appaiono difficilmente riconducibili a semplici “movimenti” sensoriali. Per approfondire queste tematiche, è consigliabile esplorare le opere di filosofi come Kant, che ha criticamente analizzato i limiti dell’empirismo, o di studiosi della linguistica come Chomsky, che ha evidenziato l’esistenza di strutture innate nel linguaggio e nella mente umana.3. La Parola, Fondamento della Ragione e delle Passioni
La parola e la sua importanza
La parola è la più importante invenzione umana, ancora più importante della stampa. È fatta di nomi e appellativi collegati tra loro, che servono per ricordare i pensieri, comunicare con gli altri e costruire la società. Si crede che la parola abbia un’origine divina, ma il modo in cui si è sviluppata e diversificata è dovuto al bisogno degli uomini e al fatto che si sono sparsi in diverse zone del mondo.Gli usi e i rischi della parola
Principalmente, la parola serve a trasformare il pensiero in discorso, fissando le idee nella memoria e permettendo alle persone di parlarsi. Con la parola si possono registrare le scoperte, condividere ciò che si sa, esprimere cosa si vuole e anche divertire. Però, si può anche usare male la parola: si possono registrare pensieri sbagliati, usare paragoni che ingannano, dire di volere cose non vere e insultare.Nomi, ragione e scienza
I nomi, sia quelli propri che quelli comuni, sono essenziali. I nomi universali mettono insieme cose simili, e usando questi nomi e collegandoli tra loro si sviluppa il ragionamento. La verità e la falsità sono caratteristiche del linguaggio, non delle cose vere e proprie. Per questo, è importante dare definizioni precise per evitare di dire cose senza senso. La ragione, che distingue gli uomini dagli animali, è come un calcolo, un mettere insieme e togliere nomi generali. La scienza, invece, è conoscere le conseguenze, cosa che si ottiene usando bene la ragione e dando definizioni giuste. Se si sbaglia a definire i nomi, si creano assurdità, mentre definire bene i nomi è la base della scienza.Passioni, volontà e felicità
Oltre alla ragione, le passioni sono un altro aspetto fondamentale degli uomini. Queste passioni sono come degli ‘inizi interni del movimento volontario’ e si mostrano come desiderio e rifiuto, che sono reazioni di base a ciò che ci circonda. Ciò che si desidera è chiamato ‘buono’, ciò che si rifiuta ‘cattivo’. Queste parole sono soggettive e cambiano da persona a persona. Il piacere e il dispiacere sono ciò che si sente nella mente per questi movimenti, e sono legati al movimento della vita stessa. Da queste passioni principali nascono emozioni più complesse come la speranza, la paura, il coraggio, la rabbia e molte altre, ognuna con un suo modo di essere espressa con le parole. La decisione nasce dall’alternarsi di desideri e rifiuti, e finisce con la volontà, cioè l’ultimo desiderio o rifiuto che precede l’azione. Infine, la felicità è avere successo continuo nell’ottenere ciò che si vuole, una fortuna terrena in una vita che cambia sempre e non si ferma mai.Ma questa critica radicale, non rischia forse di cadere nella stessa ‘tenebra spirituale’ che denuncia, semplificando eccessivamente la complessità storica e filosofica?
Il capitolo sembra liquidare con facilità secoli di riflessione teologica e filosofica, riducendo fenomeni complessi come la fede e le istituzioni religiose a mere strategie di potere e fraintendimenti. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire la storia delle religioni e la filosofia della religione. Autori come Mircea Eliade, studioso del sacro, o pensatori come Paul Ricoeur, che ha esplorato il simbolismo religioso, potrebbero offrire prospettive utili per comprendere la complessità di questi temi.18. Le fondamenta dell’ordine civile
Compatibilità tra natura umana e doveri civili
Nonostante le diverse capacità mentali e passioni che caratterizzano gli individui, ognuno è predisposto a rispettare i doveri civili. Infatti, all’interno di una stessa persona possono convivere e alternarsi il giudizio e l’immaginazione, la ragione e l’eloquenza, il coraggio e il timore delle leggi. Queste diverse facoltà sono guidate dall’educazione e dalla disciplina, dimostrando che non esiste una vera contrapposizione tra la natura umana e le responsabilità richieste dalla vita civile.La legge naturale fondamentale e la sottomissione all’autorità
Una legge naturale di primaria importanza impone a ogni individuo di difendere con forza l’autorità che garantisce la sua protezione in tempo di pace. Rifiutare questo principio sarebbe illogico, poiché la sopravvivenza di ciascuno dipende proprio da quell’autorità che si vorrebbe indebolire. La sottomissione a un conquistatore avviene nel momento in cui, pur avendo la possibilità di opporsi, si sceglie di accettare la sua autorità, riconoscendolo come nuovo sovrano in modo esplicito o implicito. Questo atto di sottomissione, in cambio di protezione e libertà, rappresenta il fondamento della conquista e del diritto del conquistatore.I pericoli della giustificazione del potere sovrano attraverso le conquiste passate
È sbagliato che gli stati giustifichino il potere di chi governa basandosi sulla legittimità di guerre di conquista avvenute in passato. Questa giustificazione è pericolosa per la stabilità dello stato stesso, perché offre una scusa implicita per future ribellioni. In realtà, la tirannia non è altro che il potere sovrano visto in modo negativo da coloro che lo subiscono.Il ruolo del comando sovrano nelle esecuzioni
Le condanne a morte nel regno di Dio non nascevano da iniziative personali, ma da un ordine del sovrano. Queste esecuzioni venivano compiute dalla comunità seguendo un processo formale e con testimonianze pubbliche. Questo modo di agire smentisce l’idea che esista un diritto individuale di agire con zelo in materia di giustizia.L’importanza di diffondere la dottrina per la stabilità civile
Questa dottrina si basa su principi veri e ragionamenti solidi, radicati nella natura umana e nelle leggi naturali e divine. Il suo scopo è creare un sistema di governo civile e religioso stabile, che promuova la pace e la fedeltà dei cittadini. La chiarezza di questa dottrina e la sua coerenza con la ragione e le Scritture la rendono comprensibile a chiunque cerchi la verità. È fondamentale che questa dottrina sia insegnata nelle università, in modo che la conoscenza dei doveri civili e del legame reciproco tra protezione e obbedienza si diffonda ampiamente, rafforzando così l’ordine e la tranquillità pubblica.È davvero “naturale” sottomettersi a qualsiasi autorità che prometta protezione, come suggerisce il capitolo, o questo principio rischia di giustificare anche regimi oppressivi?
Il capitolo presenta la sottomissione all’autorità come una legge naturale fondamentale, ma non esplora a fondo le implicazioni di questa affermazione. Se la sottomissione è giustificata semplicemente dalla promessa di protezione, come si distinguono le autorità legittime da quelle tiranniche? Per rispondere a questa domanda, potrebbe essere utile approfondire la filosofia politica, studiando autori come Hobbes, che potrebbe condividere l’approccio del capitolo, ma anche Locke o Rousseau, che offrono prospettive diverse sulla legittimità del potere e sui diritti individuali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]