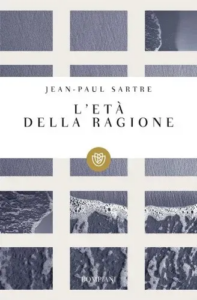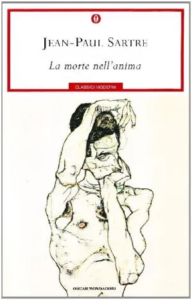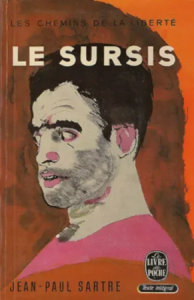Contenuti del libro
Informazioni
“L’essere e il nulla” di Jean-Paul Sartre è un viaggio pazzesco dentro la filosofia esistenzialista, che cerca di capire cosa significa esistere davvero. Non è un romanzo con personaggi o luoghi fisici, ma i protagonisti sono concetti enormi: l’Essere, il Nulla, la Coscienza (che Sartre chiama “per-sé”) e l’Altro. Il libro parte dall’idea che la realtà si manifesta a noi come fenomeno, ma poi scava più a fondo, mostrando che l’Essere delle cose (“in-sé”) è diverso dalla nostra Coscienza che le percepisce. La cosa più forte è che la nostra esistenza è definita dalla libertà assoluta, che però porta con sé l’angoscia e ci spinge a volte nella malafede, cioè a mentire a noi stessi per non affrontare questa libertà. Poi c’è l’incontro con l’Altro, che ci cambia completamente, ci fa sentire oggetti attraverso il suo sguardo e rende le relazioni un casino di conflitti e tentativi di possesso. Alla fine, Sartre ci sbatte in faccia la nostra totale responsabilità per tutto quello che siamo e facciamo, anche se la morte è un limite assurdo e non scelto. È un libro che ti smonta e ti rimonta, facendoti vedere la condizione umana in modo radicale, quasi come una psicanalisi esistenziale della nostra ricerca di essere completi, che però è una “passione inutile”.Riassunto Breve
L’esistenza si manifesta come fenomeno, un apparire che supera le vecchie idee di realtà nascosta o illusione. L’essere di una cosa coincide con il suo apparire, ma ogni apparizione è finita e rimanda a un’infinità di altre possibili manifestazioni. Questo implica che l’essere del fenomeno non si esaurisce nella sua apparizione e richiede un fondamento che vada oltre l’esperienza immediata. La coscienza emerge come una dimensione che trascende il fenomeno. Non è solo conoscenza di qualcosa, ma è sempre diretta verso un oggetto esterno. Esiste una coscienza di sé che non è riflessiva, che precede ogni pensiero e rende possibile la conoscenza. Questa coscienza è esistenza pura, non una qualità aggiunta, ed è fondata sull’essere. L’essere della cosa percepita non si riduce all’atto di percepirla; la cosa si manifesta come indipendente dalla coscienza che la coglie. L’essere è in-sé, è ciò che è, distinto dalla coscienza (per-sé), ma implicato nella sua struttura. L’essere si rivela come qualcosa che semplicemente è, contingente e inspiegabile. L’interrogazione sull’essere rivela che ogni domanda umana presuppone una relazione con l’essere e apre alla possibilità del non-essere. La negazione non è solo un giudizio, ma si manifesta nell’esperienza concreta, come nella distruzione o nell’assenza. Il nulla non è l’opposto dell’essere, ma la sua contraddizione, e presuppone l’essere per esistere. L’essere è pieno, il nulla è vuoto, e l’essere precede il nulla. L’angoscia è la manifestazione del nulla nell’esistenza umana. L’uomo, essendo “essere nel mondo”, si realizza superando il mondo nel nulla. La libertà è la capacità di distaccarsi dall’essere, condizione per l’emergere del nulla. L’angoscia è la consapevolezza di questa libertà e del vuoto che ci separa dal passato e dal futuro. La malafede è un tentativo di sfuggire all’angoscia, un autoinganno in cui si nega la propria libertà. Si basa sulla capacità umana di essere sia “fatticità” (ciò che si è) che “trascendenza” (ciò che non si è ancora). La sincerità è un ideale irraggiungibile perché la coscienza non coincide mai pienamente con sé stessa. La malafede è una “fede in malafede”, che sfrutta l’instabilità intrinseca della credenza. La possibilità della malafede risiede nella struttura della coscienza come “presenza a sé”, che implica una separazione interna, un “nulla”. L’essere cosciente (per-sé) esiste come evento contingente, non auto-fondato. La coscienza percepisce di non essere il proprio fondamento, rivelando la propria contingenza. Questa mancanza di giustificazione intrinseca è alla base del desiderio umano, una tensione verso una totalità irraggiungibile. Il possibile non è solo un’idea, ma una proprietà concreta dell’essere umano, che è costantemente proiettato verso ciò che potrebbe essere. L’ipseità, l’essere sé stessi, si situa nelle possibilità future, definendo la persona come libero rapporto con sé. La temporalità è essenziale per comprendere l’essere del per-sé, non come somma di istanti, ma come sintesi dinamica di passato, presente e futuro. La coscienza di durare emerge dalla riflessione, un tentativo di auto-fondazione che genera la temporalità psichica, distinta dalla temporalità originaria. La riflessione impura oggettiva il riflesso, creando stati psichici. La conoscenza intuitiva è presenza della coscienza alla cosa, una presenza negativa in cui il per-sé si definisce come ciò che non è la cosa. La negazione originaria svela l’in-sé e determina il per-sé. La qualità di un oggetto è il suo essere, non una percezione soggettiva. Quantità e spazio sono modi in cui la coscienza organizza l’indifferenza dell’essere. Il tempo universale nasce con la coscienza umana; l’essere in sé è atemporale. Le potenzialità degli oggetti sono proiezioni umane. La conoscenza è la presenza dell’essere alla coscienza attraverso il nulla che la coscienza è. Il mondo è umano perché la coscienza lo rivela. L’esperienza della vergogna rivela l’esistenza dell’altro. La vergogna emerge di fronte allo sguardo altrui, che ci oggettiva e ci costituisce come essere per l’altro. Lo sguardo altrui non è una percezione di un oggetto, ma un evento che ci rende oggetto per un’altra coscienza. Essere guardati si manifesta attraverso sentimenti come vergogna e paura, rivelando una dimensione del nostro essere determinata dalla libertà altrui. Il corpo è la forma contingente della nostra presenza nel mondo, un punto di riferimento costantemente trasceso dalla coscienza. Il dolore è la coscienza che si manifesta in un modo specifico, un legame contingente con il mondo. Il corpo, per la coscienza individuale, è contingenza esistenziale, percepita come nausea. Il corpo altrui è percepito come strumento e oggetto. La consapevolezza di essere oggetto per l’altro genera una terza dimensione del corpo, alienata dallo sguardo altrui. Il corpo trascende se stesso, indicando sempre oltre la sua fatticità. Le relazioni concrete con gli altri sono modalità conflittuali dell’essere-per-sé in un mondo condiviso. Si basano sul rapporto originario con l’alterità e sono intrinsecamente instabili. Un atteggiamento è il tentativo di assimilare la libertà altrui (amore, linguaggio), destinato al fallimento. Un altro atteggiamento è la reazione allo sguardo altrui (indifferenza, desiderio, odio, sadismo), anch’essa conflittuale. Questi atteggiamenti si susseguono in un circolo vizioso. L’esperienza del “noi” esiste, ma non come fondamento ontologico; è un fenomeno secondario all’essere-per-l’altro. L’azione umana è intenzionale e libera, mira a modificare il mondo partendo da una mancanza. La libertà è la condizione dell’azione, una scelta costante di sé nel mondo, identica alla coscienza. La libertà si concretizza nell’annullamento di un dato, si costituisce in relazione alla situazione (posto, passato, ciò che ci circonda, l’altro). La situazione non costringe, ma motiva. La libertà si appropria dei limiti, scegliendo se stessa in situazione. La morte non è una possibilità esistenziale, ma l’annullamento delle possibilità, un evento esterno. Non limita la libertà, ma la rivela nella sua totalità finita e situata. La morte è un destino dei progetti, non una struttura del per-sé. Di fronte a questa condizione, emerge la responsabilità totale. L’uomo è condannato ad essere libero e responsabile di sé e del mondo. La psicanalisi esistenzialista decifra i fini ultimi dell’esistenza, svelando il progetto fondamentale che anima ogni persona, basato su una scelta originaria e cosciente. Il desiderio umano è mancanza d’essere, spinta verso la completezza divina (in-sé per-sé), manifestata nell’appropriazione di oggetti. Possedere è un legame ontologico, un tentativo di possedere l’essere stesso. La conoscenza, l’arte, il gioco, la distruzione sono forme di appropriazione. Il possesso è una creazione e distruzione continua, un legame magico che riflette l’aspirazione impossibile all’auto-fondazione. La generosità è appropriazione distruttiva. Le qualità degli oggetti rivelano significati ontologici. La psicoanalisi esistenzialista decifra questi significati, esplorando come le qualità materiali riflettano scelte esistenziali. La passione umana è un tentativo fallimentare di raggiungere la completezza divina, una “passione inutile”. L’ontologia illumina un’etica radicata nella mancanza. Il valore emerge dalla mancanza ed è intrinseco all’essere-per-sé. La psicanalisi esistenziale è un’analisi morale dei progetti umani orientati verso la sintesi irraggiungibile di coscienza ed essere. L’uomo aspira a diventare causa sui, una divinizzazione di sé. Questo implica una perdita di sé nell’inseguimento di un ideale. Un esito è il superamento dello spirito di serietà, che attribuisce ai valori una trascendenza esterna e confonde il desiderabile con l’oggetto. Lo spirito di serietà occulta i valori simbolici e la libertà. La psicanalisi esistenziale svela che la meta è l’essere come sintesi di in-sé e per-sé. La libertà, origine del valore, riconosce la propria responsabilità. La libertà che si sceglie come libertà implica una tensione continua. Questi interrogativi etici trovano risposta nella morale.Riassunto Lungo
1. L’Essere si Manifesta: Dal Fenomeno al Cogito Preriflessivo
Il Fenomeno come Manifestazione dell’Esistente
Il pensiero moderno ha superato le tradizionali divisioni filosofiche. Si concentra sul fenomeno, visto come il modo in cui l’esistente si mostra. Questa nuova prospettiva elimina le divisioni tra: – ciò che è dentro e ciò che è fuori – l’essere vero e l’apparenza.L’esistente si presenta quindi come una serie di apparizioni, tutte importanti allo stesso modo. Non ci sono realtà nascoste o più vere di altre. Prendiamo ad esempio la forza: non è una potenza segreta, ma semplicemente l’insieme di tutti gli effetti che possiamo vedere. In questo modo, l’essere di un oggetto diventa la stessa cosa del suo apparire. Si supera così l’idea che l’apparenza sia qualcosa di ingannevole. Il fenomeno, quindi, è sia relativo che assoluto. È relativo perché ha bisogno di qualcuno che lo percepisca, ma è anche assoluto perché si mostra completamente in quello che è.
Il Dualismo Finito/Infinito e l’Appello Ontologico
Quando si riduce l’esistente solamente al fenomeno, nasce però un nuovo problema: la divisione tra finito e infinito. Ogni volta che qualcosa appare, questa apparizione è limitata, ma ci rimanda a una serie infinita di modi in cui lo stesso oggetto potrebbe manifestarsi. L’essere del fenomeno, anche se si mostra, non finisce nell’apparizione stessa. Il fenomeno dell’essere si rivela quindi come una specie diRichiamo che riguarda l’esistenza. Questo richiamo ci indica che è necessario trovare un fondamento, qualcosa che vada oltre la semplice esperienza di ciò che appare.La Coscienza Preriflessiva come Fondamento
Per capire la natura dell’essere che appare, dobbiamo guardare al suo stesso apparire. Ma dire che l’essere è solo ciò che viene percepito (“esse est percipi”) non basta. Non possiamo misurare l’essere della conoscenza con la conoscenza stessa. La coscienza emerge come una dimensione dell’essere che va oltre il fenomeno. La coscienza è sempre diretta verso qualcosa, è sempre coscienza di qualcosa di esterno. Esiste anche una coscienza di sé che è Preriflessiva, cioè che non è frutto di una riflessione. Questa coscienza non si mette in posa, ma viene prima di ogni pensiero e conoscenza oggettiva, rendendoli possibili. Questa coscienza non è una qualità che si aggiunge all’essere, ma è proprio l’essere stesso del piacere, dell’intenzione, del dolore. La coscienza è esistenza pura, che decide da sola cosa essere, che viene prima del nulla e che si basa sull’essere. L’esistenza cosciente è tale perché è consapevole di esistere. In questo modo, si rivela un assoluto che non è una sostanza, ma un modo di esistere.È davvero necessario postulare una “coscienza preriflessiva” per superare il dualismo finito/infinito, o esistono altre vie per comprendere il “richiamo ontologico” che il capitolo descrive?
Il capitolo presenta la coscienza preriflessiva come soluzione inevitabile al problema della finitezza del fenomeno. Tuttavia, questa conclusione appare piuttosto assertiva e potrebbe beneficiare di un confronto con altre prospettive filosofiche. Per rispondere alla domanda, sarebbe utile esplorare correnti di pensiero che, pur riconoscendo la problematicità del dualismo finito/infinito, propongono soluzioni alternative, magari attraverso una diversa concezione dell’essere o dell’esperienza. Approfondire autori come Heidegger o Levinas, che hanno affrontato tematiche simili con approcci differenti, potrebbe offrire una visione più ampia e sfaccettata.2. L’Essere Oltre la Percezione
All’inizio, si pensava che la filosofia potesse semplicemente ridurre ogni cosa a come appare, identificando la coscienza come la base di queste apparenze. Si credeva che il fondamento della conoscenza si trovasse nel percepire (percipi) e nella coscienza che percepisce (percipiens). Però, ci si chiede se la coscienza, da sola, possa davvero spiegare l’essere delle apparenze.Il limite del “percepire”
L’essere di una cosa che percepiamo non può essere solo l’atto di percepirla. Un tavolo, per esempio, non è solo la somma delle nostre percezioni soggettive. Il tavolo si mostra come un tavolo, qualcosa che va oltre il modo in cui lo conosciamo. Quindi, l’essere di ciò che percepiamo non può essere completamente compreso attraverso la conoscenza, perché ha una sua esistenza indipendente.L’essere del fenomeno e la passività
Si potrebbe pensare che l’essere di un fenomeno sia proprio l’essere percepito (percipi). Ma il ‘percipi’ è passivo, il che farebbe pensare che l’essere del fenomeno sia anch’esso passivo e relativo. La passività, però, significa dipendere da qualcosa di esterno e presuppone che esista già qualcosa di passivo. Perciò, il percepire non può dare origine all’essere di ciò che è percepito, perché quest’ultimo deve già esistere in qualche modo per poter essere percepito.La coscienza come “coscienza di qualcosa”
La coscienza è sempre coscienza “di” qualcosa. Questo vuol dire che la coscienza è sempre rivolta verso qualcos’altro, verso un essere che non è la coscienza stessa. Questa direzione verso l’esterno non è un atto della coscienza che crea l’oggetto, ma è piuttosto una relazione fondamentale con un essere che esiste già e che è indipendente dalla coscienza. Per essere coscienza, deve essere coscienza di un essere che la supera.La “prova ontologica” e l’essere preriflessivo
Si può proporre una “prova ontologica” basata sull’essere della coscienza prima della riflessione. La coscienza, nella sua essenza, è sempre coscienza di qualcosa, e questo significa che è fatta per andare oltre sé stessa. Non esiste coscienza che non abbia bisogno di rivelare un essere che la trascende. Una coscienza pensata come isolata non può creare da sola l’oggettività. La coscienza si definisce proprio come la capacità di mostrare un essere che non è coscienza, un essere che appare già esistente nel momento in cui viene rivelato.L’essere “in-sé” e la sua distinzione dalla coscienza
L’essere del fenomeno non può essere ridotto al semplice fatto di essere percepito. L’essere della coscienza non crea l’essere del fenomeno, ma lo presuppone. L’essere è “in-sé”, è ciò che è, ed è profondamente diverso dalla coscienza, anche se è legato alla sua struttura intenzionale. L’essere si rivela come qualcosa di non creato, che va oltre le categorie di attivo e passivo, ed è una positività piena che non deriva da altro e non può essere cambiato. L’essere semplicemente esiste, è contingente e “di troppo”, fondamento ultimo e inspiegabile di tutto ciò che appare.Se l’essere è “di troppo” e “contingente”, come può essere il “fondamento ultimo e inspiegabile di tutto ciò che appare”?
Il capitolo presenta l’essere “in-sé” come qualcosa di necessario per la coscienza, ma allo stesso tempo lo descrive come “contingente” e “di troppo”. Questa apparente contraddizione solleva interrogativi sulla coerenza logica dell’argomentazione. Per chiarire questo punto, sarebbe utile esplorare più a fondo il concetto di contingenza in filosofia, magari approfondendo autori come Sartre, che ha ampiamente trattato il tema dell’essere contingente e della sua relazione con la coscienza. Inoltre, una riflessione sulla natura del “fondamento ultimo” potrebbe beneficiare di un confronto con diverse tradizioni filosofiche che si occupano di ontologia e metafisica.3. Essere e Nulla: Alle Radici dell’Interrogazione
L’Interrogazione come Atteggiamento Fondamentale verso l’Essere
L’indagine sull’essere porta a capire che l’interrogazione è il modo in cui gli esseri umani si pongono di fronte all’essere. Domandare è un atteggiamento di base che rivela un legame originario con l’essere. Infatti, ogni domanda implica che ci sia qualcosa che interroga e qualcosa che viene interrogato. La domanda non è solo un modo per conoscere, ma è un comportamento che esiste prima della risposta, aprendo la possibilità di considerare anche ciò che non è, il non-essere.L’Esperienza della Negazione e la Comprensione del Nulla
La negazione non è solo un giudizio teorico, ma si manifesta in azioni concrete dell’esperienza umana. Un esempio è la distruzione, un atto tipicamente umano, che mostra come si possa comprendere il nulla in modo pratico, prima ancora di giudicarlo. Distruggere qualcosa significa percepire che l’essere è fragile e può anche non essere. Anche in situazioni semplici come cercare qualcuno in un bar, l’esperienza dell’assenza ci fa intuire il non-essere, precedendo qualsiasi giudizio negativo. L’assenza, quindi, è una via per sperimentare concretamente il nulla.Critica alla Concezione Dialettica di Essere e Nulla
Non è corretto pensare all’essere e al nulla come due opposti che si equivalgono, come farebbe una visione dialettica. Il nulla non è semplicemente il contrario dell’essere, ma è la sua negazione, la sua contraddizione. Per negare l’essere, bisogna prima presupporre che l’essere esista. L’essere non contiene in sé il nulla, anzi, è il contrario: il nulla deriva dall’essere e dipende da esso per esistere. L’essere è pieno e positivo, mentre il nulla è mancanza di essere, è vuoto. Quindi, l’essere viene prima e fonda il nulla. Il nulla non è qualcosa di separato dall’essere, ma si manifesta come una presenza costante ai margini dell’essere, come un’ombra che lo accompagna sempre.Ma è davvero scientificamente provato che il desiderio umano nasca da una “mancanza interiore” e sia orientato verso una “perfezione assoluta”, o si tratta di una speculazione filosofica non supportata da evidenze empiriche?
Il capitolo presenta una visione suggestiva del desiderio e del possesso, ma sembra mancare di un solido ancoraggio scientifico. Affermazioni come “il desiderio umano nasce da una sensazione di mancanza interiore” appaiono più come postulati filosofici che conclusioni derivate da ricerche psicologiche o antropologiche. Per comprendere meglio le radici del desiderio e la sua connessione con il possesso, sarebbe utile esplorare le teorie psicologiche sulla motivazione e il bisogno, approfondire le diverse scuole di pensiero filosofico che si sono occupate del desiderio, e considerare le prospettive antropologiche sul rapporto tra uomo e oggetti. Autori come Freud o studiosi della filosofia esistenzialista potrebbero offrire spunti di riflessione utili per contestualizzare e valutare criticamente le affermazioni del capitolo.18. L’Etica della Mancanza e la Psicanalisi Esistenziale
L’Etica Radicata nella Condizione Umana
L’ontologia descrive la realtà che ci circonda, ma non ci dice cosa è giusto o sbagliato. Nonostante questo, l’ontologia può aiutarci a capire un’etica che nasce direttamente dalla nostra esperienza umana concreta. In questa etica, il valore di qualcosa emerge dalla mancanza, che è una parte fondamentale di ciò che significa essere un “per-sé”, cioè un essere umano cosciente. Proprio perché esistiamo come “per-sé”, il valore diventa qualcosa diAutomaticamente legato al nostro essere.La Psicanalisi Esistenziale come Analisi Morale
La psicanalisi esistenziale può essere vista come un modo per analizzare la morale che si nasconde dietro ai diversi progetti che gli esseri umani cercano di realizzare. Tutti questi progetti sono diretti verso un obiettivo impossibile: unire completamente la coscienza e l’esistenza, un’unione che rappresenta il valore più alto. Questa visione dell’etica va oltre le spiegazioni che si basano solo sull’interesse personale o sulla psicologia spicciola. Ci fa capire che esistono significati ideali che vanno al di là del semplice egoismo o altruismo.L’Aspirazione Umana alla Divinizzazione di Sé
Ogni persona desidera diventare “causa sui”, un’espressione latina che significa “causa di sé stesso”. In altre parole, vorremmo essere come dei, capaci di crearci da soli. Anche se questo desiderio può sembrare egoista, in realtà ci porta a perdere noi stessi nel tentativo di raggiungere un ideale che non potremo mai afferrare completamente. La vita umana si presenta quindi come una passione, un impulso forte e irrazionale, e l’amor proprio diventa solo uno strumento per cercare di realizzare questa passione.Il Superamento dello Spirito di Serietà
Un punto cruciale della psicanalisi esistenziale è il superamento di quello che viene chiamato “spirito di serietà”. Questo spirito di serietà è un modo di pensare che attribuisce ai valori un’importanza assoluta, come se esistessero al di fuori e indipendentemente dagli esseri umani. Chi è dominato dallo spirito di serietà confonde ciò che desidera con la realtà materiale degli oggetti. In pratica, lo spirito di serietà, che è molto diffuso nel mondo, ci impedisce di vedere i valori simbolici che si nascondono dietro alle cose concrete. Ci fa percepire gli oggetti che desideriamo come qualcosa di opaco, di misterioso, e ci convince che siano desiderabili per loro stessa natura, senza che ci sia un vero motivo.L’Ipocrisia della Morale dello Spirito di Serietà
Questa morale dello spirito di serietà è fondamentalmente ipocrita. Nasconde i suoi veri scopi per evitare di farci provare angoscia, cioè quella sensazione di paura e incertezza che proviamo di fronte alla libertà di scegliere. L’essere umano cerca l’essere, cerca la pienezza e la completezza, ma lo fa in modo cieco, senza capire veramente cosa sta cercando. Si nasconde a sé stesso la libertà che è implicita in questa ricerca e percepisce gli oggetti del desiderio come se fossero loro a imporci di desiderarli, come se fossero delle esigenze silenziose che provengono dal mondo esterno. La psicanalisi esistenziale ci svela che il vero obiettivo di questa ricerca è in realtà l’essere inteso come unione perfetta tra “in-sé” e “per-sé”, cioè tra l’oggetto e la coscienza. Questa scoperta mette l’individuo di fronte alla sua vera passione, al suo desiderio più profondo.Libertà e Responsabilità
Quando finalmente comprendiamo che la libertà è l’origine di ogni valore, e lo facciamo attraverso l’esperienza dell’angoscia, allora riconosciamo anche la nostra responsabilità fondamentale. Capiamo di essere noi stessi il fondamento dell’esistenza del mondo e dei valori che ci guidano. A questo punto, la libertà si trova di fronte a una domanda cruciale: deve considerarsi il valore più importante in assoluto, oppure deve definirsi in relazione a valori che la superano, che sono più grandi di lei? La libertà che sceglie di riconoscere sé stessa come libertà vive in una condizione di continua tensione, di distanza da sé stessa, perché è sempre aperta alla possibilità di scegliere diversamente. Questi interrogativi etici, che richiedono una riflessione profonda e sincera, possono trovare risposta solo nel campo della morale, aprendo la strada a nuove e ulteriori ricerche.Se questa etica è radicata nella “mancanza” e si basa su concetti astratti come il “per-sé” e la “causa sui”, come può guidarci concretamente nelle scelte morali di ogni giorno?
Il capitolo presenta una visione affascinante dell’etica basata sull’ontologia e sulla psicanalisi esistenziale, ma la sua applicabilità pratica rimane nebulosa. Per comprendere meglio come tradurre questi concetti filosofici in azioni concrete, sarebbe utile esplorare il pensiero di filosofi esistenzialisti come Sartre, che ha affrontato direttamente il tema della responsabilità individuale e della scelta in situazioni reali. Approfondire l’etica applicata e la filosofia morale contemporanea potrebbe fornire strumenti utili per colmare questa lacuna.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]