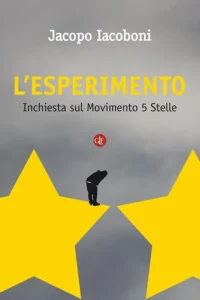1. Ingegneria del Consenso
Alla fine degli anni Novanta, un esperimento condotto da Gianroberto Casaleggio presso la società di ricerca informatica Webegg, tra Bologna, Torino e Milano, gettò le basi per nuove tecniche di formazione del consenso. Inizialmente, l’attenzione era rivolta all’uso delle intranet aziendali, ma presto emerse il potenziale delle “community organizzate dall’alto” per influenzare le opinioni. Attraverso la manipolazione delle discussioni nei forum aziendali, si creavano “valanghe di consenso” orchestrate. Questo approccio, definito ingegneria sociale, mirava a orientare le opinioni in modo strategico. L’esperimento di Webegg anticipò la nascita del Movimento 5 Stelle. Nel 2005, il primo meetup a Milano fu organizzato da un dipendente della Casaleggio Associati. L’incontro tra Casaleggio e Beppe Grillo nel 2004 fu determinante. La loro collaborazione unì l’azienda di consulenza a un progetto politico. Grillo divenne il portavoce, amplificando le idee di Casaleggio e trasformando la protesta in un movimento politico. La Casaleggio Associati, fondata nel 2004, divenne il fulcro organizzativo del Movimento. La gestione della comunicazione e della strategia politica del Movimento erano sotto il controllo dell’azienda. Il finanziamento si basava su donazioni, fondi parlamentari e pubblicità online. La rabbia popolare contro la “casta” e i media tradizionali, percepiti come lontani dalla realtà della rete, divenne il principale strumento di propaganda, veicolando il malcontento sociale.4. Lo Schermo Onnipresente: Ascesa e Caduta della TV nel Movimento 5 Stelle
Agli inizi del Movimento 5 Stelle, la televisione era vista come il simbolo di un sistema corrotto. Beppe Grillo consigliava di stare lontani dai talk show, considerati luoghi di manipolazione. Questa posizione nasceva anche dall’allontanamento di Grillo dalla televisione pubblica.Grillo, però, conosceva bene il mondo della televisione e i suoi vantaggi. Questa ambiguità si rifletteva nel Movimento, dove il divieto di andare in TV iniziò a vacillare quando alcuni leader vollero farsi conoscere.Il Movimento, pur criticando la televisione, cercò di controllarla. Iniziò a chiedere interviste senza contraddittorio e a scegliere i giornalisti, mostrando di voler usare la TV per la propria propaganda.L’immagine divenne fondamentale. La Casaleggio Associati, centro organizzativo del Movimento, iniziò a curare l’aspetto dei rappresentanti, usando anche un coach televisivo.Il Movimento si mostrava austero e contro i privilegi della politica. Tuttavia, alcuni suoi membri, una volta eletti, iniziarono a godere di stipendi alti e rimborsi, in contrasto con i principi dichiarati. Anche le regole finanziarie interne si rivelarono poco chiare.Le regole del Movimento, presentate come garanzia di purezza, divennero uno strumento per eliminare chi non era d’accordo. Espulsioni rapide, basate su accuse poco chiare, colpirono sia semplici attivisti che personaggi importanti. Le contestazioni legali a queste espulsioni mostrarono la mancanza di trasparenza nelle decisioni del Movimento.2. La Rete del Potere Digitale
Nel gennaio 2017, il Movimento 5 Stelle, guidato da Davide Casaleggio, si riavvicina a Nigel Farage, leader dell’Ukip, dopo una breve parentesi europeista. Breitbart, vicino a Steve Bannon e Donald Trump, riporta la notizia con entusiasmo, sottolineando l’ammirazione di Farage per Grillo. Si avvia così una campagna anti-establishment in Europa, che spinge il Movimento verso un populismo di destra. Nonostante le preferenze di alcuni per i Verdi, l’alleanza con l’Ukip viene scelta tramite un referendum online, considerato da molti poco trasparente. Questa scelta politica si lega alla visione di Gianroberto Casaleggio, che considerava i dati il nuovo “petrolio”. La raccolta e l’utilizzo strategico di informazioni, paragonabili a una risorsa preziosa, diventano il cuore del Movimento. La piattaforma Rousseau nasce proprio per questo: consultare e votare online, raccogliendo dati preziosi. La sicurezza di Rousseau, però, si rivela un punto debole. Alcuni hacker mostrano gravi falle nel sistema, esponendo i dati sensibili degli iscritti e mettendo in dubbio l’affidabilità delle votazioni. L’incidente solleva domande sulla capacità della Casaleggio di proteggere le informazioni personali, in un mondo in cui i dati hanno un valore economico e politico sempre più grande, come dimostrano le strategie di Facebook e Amazon. La struttura stessa del Movimento, con una sovrapposizione di associazioni, crea problemi legali. Alcuni attivisti espulsi fanno causa, mettendo in luce la fragilità delle regole interne e sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla democrazia delle decisioni. Il controllo e l’analisi dei dati rappresentano una leva fondamentale per l’esercizio del potere nell’era digitale, e il Movimento 5 Stelle ne è un chiaro esempio.5. Strategie di Potere: Vaticano, Roma, Torino e Russia
Il Movimento 5 Stelle ha intrapreso un percorso complesso per affermare la propria influenza, tessendo una rete di relazioni con diversi attori del potere. Inizialmente, il Movimento aveva promesso di tassare i beni ecclesiastici, ma ha poi cercato un dialogo con il Vaticano, culminato nell’incontro tra Virginia Raggi e Papa Francesco. Figure di spicco come Luigi Di Maio hanno coltivato rapporti con ambienti vaticani, segnando un cambio di rotta nella strategia del Movimento. Le vittorie di Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino nel 2016 sono state cruciali. Gianroberto Casaleggio considerava Roma una tappa fondamentale per arrivare al governo nazionale. L’amministrazione Raggi, però, ha dovuto affrontare scandali e difficoltà, come le nomine controverse di Raffaele Marra e Salvatore Romeo, e problemi nella gestione di rifiuti e trasporti. A Torino, Chiara Appendino ha avuto un inizio più positivo, ma anche lei ha incontrato ostacoli, come il disastro di Piazza San Carlo e le successive indagini. Appendino, a differenza di Raggi, ha cercato un’integrazione con il sistema di potere torinese, stabilendo legami con l’establishment economico e politico locale. Entrambe le amministrazioni hanno mostrato una distanza dalla base del Movimento, preferendo relazioni esterne. Parallelamente, il Movimento ha modificato la sua politica estera, avvicinandosi alla Russia di Vladimir Putin. Dopo le critiche iniziali di Beppe Grillo verso Putin, c’è stata una svolta, con incontri tra esponenti del Movimento e rappresentanti del partito Russia Unita. Questa nuova alleanza si è manifestata con una retorica filo-russa e la condivisione di posizioni su temi internazionali.6. Reti e Cyber Guerra
La campagna elettorale di Donald Trump ha segnato un punto di svolta nell’utilizzo dei social media per la propaganda politica. L’informazione è stata sostituita dalla manipolazione, in una strategia simile a una vera e propria insurrezione. Questa strategia, ideata dal generale Flynn e vicina al pensiero del filosofo russo Dugin, ha fatto ampio uso di troll e tecniche di disinformazione. Si tratta di un’evoluzione delle “active measures” sovietiche, adattate all’era digitale. Attraverso Project Alamo e Cambridge Analytica, la campagna di Trump ha sfruttato la psicometria, ovvero l’analisi dei dati psicologici, per inviare messaggi pubblicitari personalizzati a specifici profili di elettori. La comunicazione politica è stata trasformata in una forma di guerra.La costruzione di notizie false è diventata uno strumento paramilitare, parte di una più ampia “cyberguerriglia informativa”. Le falsità diffuse contro figure politiche come Hillary Clinton, ad esempio, non sono semplici bufale, ma vere e proprie aggressioni tecniche. L’anonimato e la diffusione capillare di queste falsità rendono difficile risalire direttamente alle campagne ufficiali, creando una sorta di sistema di “sicari dell’informazione”.In Italia, il Movimento 5 Stelle si è distinto per un uso innovativo dei social media a fini propagandistici. La società Web Side Story, collegata al Movimento, ha registrato una crescita notevole, sollevando interrogativi sulle strategie utilizzate. L’analisi delle reti social rivela una struttura complessa di pagine e account che sostengono il M5S, capaci di raggiungere milioni di utenti e diffondere contenuti forti e polarizzanti. Alcuni profili, come “Beatrice Di Maio” su Twitter, mostrano l’importanza di determinati nodi all’interno di queste reti e il possibile coordinamento di account “fantasma” per amplificare la propaganda.Il funzionamento del Movimento 5 Stelle può essere compreso attraverso la teoria delle reti, centrale nel pensiero di Gianroberto Casaleggio. Ispirandosi al modello dei formicai, Casaleggio considerava il Movimento come un sistema auto-organizzato di nodi (persone) e connessioni, che poteva essere indirizzato verso specifici obiettivi diffondendo messaggi chiave. Questo modello è efficace nella propaganda e nella manipolazione del consenso, ma presenta anche dei punti deboli. Tra questi, il rischio di divisioni interne e la vulnerabilità della piattaforma Rousseau, più volte attaccata da hacker. La limitata competenza tecnica nella gestione e protezione dei dati contrasta con la visione iniziale, mettendo in discussione la stabilità del sistema e il futuro del gruppo sociale che ha creato.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]