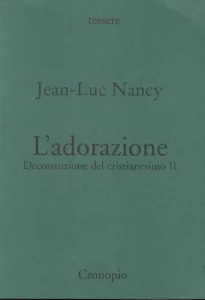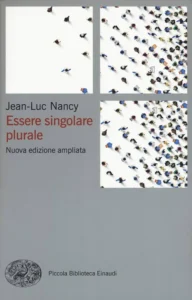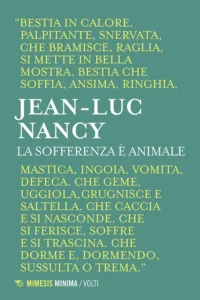1. La Catastrofe come Presente
Il pensiero filosofico ha spesso considerato la “fine di tutte le cose” come quel momento in cui ogni cambiamento si ferma. Questa prospettiva, per un essere umano legato al tempo, appare come un annientamento. Il filosofo Kant ha descritto questo istante in modo suggestivo come il “giorno più giovane”, un paradosso in cui il tempo e l’eterno sembrano coincidere. Questa idea di una fine che avviene nel tempo, tipica di una visione del mondo che va dalla Genesi all’Apocalisse, offre un senso morale diverso rispetto a un’idea di tempo ciclico, che si ripete all’infinito.La catastrofe nella politica moderna
Nel secolo scorso, il concetto di catastrofe è entrato prepotentemente nel campo della politica. Grandi eventi come guerre mondiali e rivoluzioni sono diventati esperienze fondamentali che hanno trasformato profondamente il destino non solo delle singole persone, ma dell’intera collettività. La pensatrice Hannah Arendt ha osservato che questi eventi non sono semplici momenti di purificazione o di normale continuazione della politica, ma immense catastrofi che spingono l’umanità verso un abisso. Nonostante ciò, è proprio all’interno della politica, intesa come spazio di azione comune tra esseri umani diversi, che può ancora nascere qualcosa di radicalmente nuovo, un inizio che non è imposto da una necessità esterna ma che scaturisce dalla libertà umana.Diverse visioni della “fine del mondo”
Il filosofo Jean-Luc Nancy invita a riflettere sulla “fine del mondo” non come un evento spettacolare e apocalittico, ma piuttosto come la scomparsa di un ordine cosmico stabilito. Secondo questa visione, non abitiamo più un mondo nel senso tradizionale del termine; il mondo si presenta piuttosto come un insieme frammentato e disperso, una realtà in cui vengono continuamente creati molteplici “mondi” diversi. Il mondo, in questa prospettiva, è il luogo stesso in cui avviene una condivisione tra le persone, uno spazio che risuona per chi lo abita. Il suo significato non viene da fuori, ma nasce dal modo in cui tiene insieme coloro che lo condividono nella loro comune condizione di esseri finiti.L’impatto sulla nostra esperienza
Questa “fine del mondo” si lega strettamente a quella che viene definita l’espropriazione dell’esperienza, un processo diventato evidente dopo eventi traumatici come la Prima Guerra Mondiale, dove la capacità delle persone di vivere e scambiare esperienze significative sembrava essersi sgretolata. Il filosofo Günther Anders ha descritto l’uomo moderno come “antiquato”, quasi estraneo al mondo tecnologico e complesso che egli stesso ha creato. Egli evidenzia un divario crescente tra la nostra capacità di produrre cose e situazioni e la nostra incapacità di immaginarne e comprenderne le conseguenze reali. Gli oggetti e le situazioni che creiamo sembrano esistere e agire prima ancora che noi riusciamo a capirne la portata completa. Anche Martin Heidegger ha parlato di uno “spaesamento”, un profondo sentirsi “fuori-da-casa” che si verifica quando il mondo, inteso come orizzonte di significato, ci viene sottratto.Catastrofe come condizione per la verità
Per una certa corrente del pensiero occidentale, la catastrofe sembra quasi essere la condizione necessaria per una rivelazione, per l’apparizione di una verità che può manifestarsi solo quando tutto il resto crolla. Il filosofo Peter Sloterdijk, ad esempio, collega l’epoca atomica alla stessa civiltà umana. Egli suggerisce che la costante vicinanza a un terrore diffuso e paralizzante (il terrore panico) rende paradossalmente possibile la vita umana in questa era. In questa prospettiva, la catastrofe acquisisce una funzione quasi pedagogica, come se dovesse insegnarci qualcosa di fondamentale sulla nostra esistenza.Dagli eventi storici al presente: Hiroshima e Fukushima
Eventi storici epocali come il bombardamento di Hiroshima nel 1945 e il disastro nucleare di Fukushima nel 2011 hanno reso l’idea della “fine del mondo” un’esperienza concreta e tangibile per intere generazioni. Fukushima, in particolare, rappresenta un caso emblematico: un disastro iniziato come naturale (terremoto e tsunami) si è rapidamente trasformato in una catastrofe tecnica, sociale e globale, capace di dissolvere i confini netti che eravamo abituati a tracciare tra natura e tecnologia.Il compito del pensiero oggi
Fare filosofia “dopo” Fukushima significa confrontarsi con una rottura profonda, un evento che rende inutili le vecchie consolazioni metafisiche e le spiegazioni preesistenti. Questo scenario impone di pensare il presente non più come un momento effimero destinato a passare, ma come uno spazio di “prossimità”, ciò che si presenta qui e ora alla nostra attenzione e richiede una risposta. Il compito urgente del pensiero oggi è una praxis, un’azione concreta che non si limita a osservare, ma che trasforma chi la compie. Questo significa affrontare il mondo così com’è, confrontarsi con le sfide attuali, come la lotta contro il potere del capitale, e farlo in un tempo la cui natura è profondamente cambiata, un tempo che non può più essere compreso e gestito con le vecchie categorie di “crisi” a cui eravamo abituati.Ma la “fine del mondo” filosofica impone davvero di combattere il potere del capitale?
Il capitolo descrive con efficacia la sensazione di un mondo frammentato e di un’esperienza perduta, legandola a eventi storici e a riflessioni filosofiche. Tuttavia, la conclusione che il compito urgente del pensiero oggi sia una “praxis” specificamente orientata alla lotta contro il potere del capitale introduce un’istanza politico-economica che, per quanto legittima, non appare come l’unica o l’inevitabile conseguenza della diagnosi precedente. Il capitolo non chiarisce sufficientemente perché proprio questa forma di “praxis” sia quella imposta dalla “rottura profonda” post-Fukushima, rispetto ad altre possibili risposte alla condizione di spaesamento o alla fine di un ordine stabilito. Per approfondire questo nesso e valutarne la solidità, è indispensabile confrontarsi con gli studi sulla critica del capitale, leggendo autori come Marx, ma anche esplorare le diverse interpretazioni della “praxis” nel pensiero contemporaneo, magari attraverso autori che propongono approcci differenti alla trasformazione sociale o esistenziale.2. La catastrofe dell’equivalenza generale
Le catastrofi di oggi, come l’evento di Fukushima, non sono semplici disastri naturali o guasti tecnici isolati. Sono piuttosto il risultato di una vasta rete di collegamenti tra sistemi diversi: tecnici, economici, sociali e politici. Al centro di questa complessa interdipendenza c’è un principio fondamentale che guida ogni cosa: l’equivalenza generale. Questo principio porta a effetti imprevedibili e incontrollabili quando si verificano eventi catastrofici. Un terremoto, ad esempio, si lega alla fragilità di un impianto nucleare e alla gestione politica ed economica, creando una catastrofe complessa che va oltre ogni possibilità di controllo. Non si parla più solo di catastrofi naturali, ma di una vera e propria catastrofe della civiltà stessa.Che cos’è l’equivalenza generale
Questo principio dell’equivalenza generale nasce dal sistema capitalistico e dal progresso tecnico. La sua logica profonda rende forze, prodotti e valori illimitatamente intercambiabili tra loro. Il denaro gioca un ruolo centrale in questo processo, funzionando come l’equivalente universale che riduce ogni aspetto della realtà a un valore che può essere misurato e scambiato. Questa mentalità basata sulla quantificazione e sullo scambio permea e influenza ogni ambito dell’esistenza umana, dalla produzione di beni alle relazioni sociali, fino alla percezione stessa del valore.Le conseguenze: catastrofi complesse e perdita di senso
L’energia atomica, usata sia per scopi militari che civili, è un esempio lampante di questa equivalenza e dell’incalcolabile che ne deriva. Le armi nucleari creano una sorta di equilibrio basato sulla paura e su una forza distruttiva assoluta, che sfugge a ogni calcolo razionale. Più in generale, le tecniche moderne, dalla medicina alla finanza, generano sistemi sempre più intricati e chiusi in sé stessi, dove diventa difficile distinguere chiaramente tra i fini che si vogliono raggiungere e i mezzi utilizzati per ottenerli. Questa condizione diffusa porta a una progressiva dissoluzione del senso tradizionale delle cose e dei valori che un tempo orientavano la società. La civiltà basata sull’idea di progresso e sul dominio sulla natura finisce per trasformarsi in una condizione in cui l’umanità è sempre più soggetta a vincoli e costrizioni crescenti, perdendo parte della sua libertà e capacità di autodeterminazione.Un’alternativa: pensare il presente e valorizzare il singolare
Per affrontare questa situazione complessa, il modo di pensare deve cambiare radicalmente. Non si può più basare il pensiero solo sull’analisi delle crisi attuali o sulla progettazione di futuri ideali. È invece fondamentale concentrarsi sul presente, inteso come un’apertura autentica alla prossimità e una capacità di dare valore a ciò che è unico e irripetibile, al singolare. Questo approccio richiede uno spostamento di attenzione dalla logica astratta e generale a quella concreta e specifica, riconoscendo l’importanza di ogni singolo elemento e relazione nel qui e ora.La stima contro l’equivalenza
Questa nuova prospettiva si concretizza nella pratica della stima. La stima si rivolge a ciò che è inestimabile, ovvero a tutto ciò che possiede un valore intrinseco così profondo da non poter essere ridotto a una semplice quotazione di mercato o a un freddo calcolo quantitativo. Questo modo di valorizzare si pone in netta contrapposizione con la logica dell’equivalenza generale, che tende invece a misurare e valutare ogni cosa esclusivamente in termini quantitativi, appiattendo le differenze e ignorando l’unicità.La vera uguaglianza
In questo contesto, l’uguaglianza autentica non consiste nel considerare gli individui semplicemente come equivalenti, intercambiabili e misurabili allo stesso modo. L’uguaglianza vera risiede piuttosto nel riconoscere e rispettare la dignità intrinseca di ogni essere umano in quanto individuo singolare e irriducibile, unico nella sua essenza. Affermare l’uguaglianza oggi significa quindi denunciare attivamente la logica catastrofica dell’equivalenza generale e, allo stesso tempo, riconoscere il valore incommensurabile e insostituibile di ogni esistente, umano e non umano.Ma è davvero praticabile, in una società complessa, basare tutto sulla “stima” del singolare, o si rischia di rimanere nel campo dell’ideale?
Il capitolo propone la “stima” come alternativa radicale all’equivalenza generale, ma non chiarisce sufficientemente come questo principio possa tradursi in pratiche sociali, economiche e politiche concrete su larga scala. Per comprendere meglio le sfide e le possibilità di un approccio basato sul valore intrinseco e irriducibile, è utile esplorare dibattiti filosofici sull’etica del valore, la filosofia politica che discute i fondamenti dell’uguaglianza e della giustizia oltre la mera intercambiabilità, e studi sociologici che analizzano forme di solidarietà e riconoscimento non basate sul mero calcolo. Autori come Martha Nussbaum, Axel Honneth o pensatori legati all’economia civile possono offrire prospettive diverse su come conciliare il riconoscimento del singolare con le esigenze della vita collettiva.3. Il senso oltre la produzione
La catastrofe di Fukushima, causata dal sisma e dallo tsunami del marzo 2011, ci spinge a riflettere sul presente. Questo evento drammatico solleva una domanda fondamentale: il pensiero deve sempre nascere da una crisi che lo mette in difficoltà, da qualcosa di così grande da sembrare fuori portata, ma che diventa il suo punto di partenza? L’idea è che lo stupore di fronte a una catastrofe così imponente richieda un nuovo inizio per il modo in cui pensiamo.Il significato del “fare” oggi
Ci si interroga sul senso profondo del “fare” nel mondo di oggi. L’idea che “fare” sia un progetto per costruire la vita insieme sembra aver perso la sua forza. La nostra civiltà appare piena di contraddizioni: costruisce mostrando la propria fragilità, crea regole inventandole continuamente, cerca di definire l’essere umano senza avere un modello di riferimento, accumula conoscenze scientifiche ma si scontra con una profonda mancanza di sapere su ciò che conta davvero. Il capitalismo, in particolare, sembra aver creato un mondo dove tutto è scambiabile, ma proprio per questo, nulla ha un valore autentico e duraturo.Oltre la semplice reazione: un nuovo modo di agire
Di fronte a questo scenario, ci si chiede come possiamo agire in modo da aprirci a un futuro che non abbiamo ancora immaginato. Come possiamo “fare presente” la nostra esistenza senza limitarci a reagire agli eventi dopo che sono accaduti? La risposta suggerisce che il significato stesso del “fare” deve cambiare radicalmente. Fino a poco tempo fa, “fare” significava principalmente “realizzare” nuove condizioni di vita, agendo con l’energia tipica della produzione, della conquista e del controllo, usando la tecnologia e il calcolo come strumenti principali.Dalla produzione all’attenzione per l’esistenza
Ora, l’attenzione deve spostarsi altrove. Ciò che produciamo diventa meno importante dell’attenzione che dedichiamo al semplice fatto che esistiamo. Questo fatto, la nostra esistenza, non ha più bisogno delle vecchie giustificazioni, come l’idea di progresso continuo o la creazione di un “uomo nuovo”. Richiede di essere compreso in un modo completamente diverso, senza partire dalla presunzione di sapere già cosa sia l’essere umano.L’uomo senza fine e il senso ritrovato
Dobbiamo accettare che l’uomo non sa tutto di sé e che l’obiettivo non è accumulare “sapere” fine a sé stesso. L’essere umano è costantemente superato dalla sua storia e dal suo continuo errare, è un essere “senza fine”. Tuttavia, essere senza fine non significa essere privi di senso, al contrario. Il senso profondo si trova proprio nell’essere aperti e esposti a questo “eccesso” che va oltre ogni scopo o obiettivo predefinito. È da qui che si propone di ricominciare a pensare.È sufficiente una generica “attenzione all’esistenza” per superare la crisi di senso di una civiltà definita dalla produzione e dallo scambio, o il capitolo elude il problema concreto del “fare” nel mondo reale?
Il capitolo identifica correttamente una crisi di senso nel “fare” contemporaneo, dominato dalla produzione e dallo scambio che svuota il valore. Tuttavia, il passaggio proposto verso una generica “attenzione all’esistenza” e l’abbraccio dell’essere “senza fine” rimane su un piano molto astratto. Non viene chiarito come questa attenzione si traduca in un nuovo modo di agire nel mondo che affronti concretamente i problemi sollevati, come la mancanza di valore autentico. Per esplorare come il pensiero possa informare un’azione significativa al di là della mera produzione, e come dare senso al “fare” in un contesto critico, sarebbe utile approfondire la filosofia dell’azione, ad esempio leggendo Hannah Arendt, o esplorare pensatori che hanno analizzato a fondo la crisi della modernità e del capitalismo da prospettive critiche, come i teorici della Scuola di Francoforte.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]