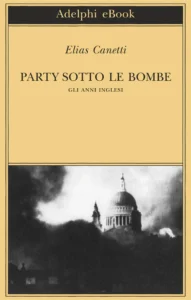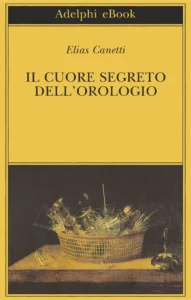1. Mercati e Destini Animali a Marrakech
La vita nella città include scene legate agli animali e al commercio tradizionale. Vicino alle mura, si osservano cammelli. Alcuni si presentano in condizioni di stress o feriti, destinati alla macellazione. Un cammello con una zampa legata mostra agitazione mentre viene spostato. Altri cammelli al mercato vengono sottomessi con forza, inserendo una corda nel naso, causando sanguinamento. Questo accade perché si ritiene che l’animale percepisca l’odore del macellaio e diventi irrequieto. I cammelli possono essere pericolosi, specialmente se malati, e si crede che abbiano un olfatto molto fine. Molti arrivano da viaggi lunghi, anche di venticinque giorni da luoghi come Gulimin, per essere venduti per la carne, che è molto consumata localmente. Nonostante l’immagine di carovane tranquille che riposano e mangiano, il loro destino finale è spesso il macello.L’esperienza dei suk
I suk della città offrono un’esperienza sensoriale ricca, con odori e colori distinti. Le merci sono esposte apertamente nelle botteghe, senza prezzi fissi o etichette. Negozi che vendono lo stesso tipo di articoli sono concentrati in aree specifiche. Spesso è possibile vedere gli artigiani al lavoro, creando gli oggetti venduti, come la lavorazione del cuoio o la tintura dei tessuti. Questa visibilità della produzione è una caratteristica del mercato. Il processo di acquisto si basa sulla contrattazione, considerata un’arte. Il prezzo iniziale non è predefinito e dipende da molteplici fattori, inclusi il cliente e il momento. La negoziazione richiede tempo, abilità e strategia da entrambe le parti. Il venditore ha un rapporto stretto con la sua merce e ne conosce il valore reale, che mantiene segreto. Comprare nei suk è un’interazione complessa che va oltre il semplice scambio di denaro.È davvero l’olfatto finissimo del cammello a giustificare metodi così brutali per controllarlo, o si tratta di una credenza che maschera la pura necessità di sottomissione?
Il capitolo descrive una credenza locale sull’olfatto dei cammelli come causa della loro agitazione vicino ai macellai, usata per giustificare pratiche di controllo invasive. Tuttavia, il testo non fornisce alcuna base scientifica per questa affermazione, lasciando il dubbio che si tratti più di una razionalizzazione culturale che di una realtà etologica. Per comprendere meglio il comportamento animale e le interazioni uomo-animale in contesti tradizionali, sarebbe utile approfondire gli studi di Etologia e Antropologia Culturale.2. Il Rituale delle Monete e le Grida
La comunicazione va oltre le semplici parole. Esiste un modo di capire il mondo che si basa su eventi, immagini e suoni. Questi elementi sono spesso più profondi e meno chiari del linguaggio parlato. Ascoltare suoni che non si capiscono, come grida in lingue straniere, permette di sentire la loro forza diretta, senza il filtro della traduzione.Le Voci di Marrakech
Nella città di Marrakech si incontrano molti mendicanti ciechi. Spesso si riuniscono in gruppi e ripetono continuamente una specie di canto rauco. In queste grida si sente spesso il nome di “Allah”, ripetuto migliaia di volte ogni giorno. Una volta che questo grido viene stabilito, non cambia più. Diventa come un disegno fatto di suoni che ruota intorno all’idea di Dio. Ripetere il nome divino in modo così insistente è visto quasi come un tentativo di superare un ostacolo, e rappresenta una fonte di forza e sostegno più importante dell’elemosina che ricevono.L’Identità nella Ripetizione
La persona che grida è definita proprio da questa ripetizione. Il grido diventa il suo limite e la sua identità in quel luogo. Chiede per un gruppo intero, raccogliendo i soldi per tutti. Questa vita, fatta solo dalla semplice ripetizione del luogo, del grido e di poche monete, trasforma i mendicanti ciechi in figure quasi sacre dedicate a questa pratica, come “santi della ripetizione”.Il Rituale delle Monete Masticate
Tra questi mendicanti, uno si distingue per un rituale particolare con le monete che riceve. Le prende e le mastica. Tiene le monete in bocca, masticandole con piacere, poi le sputa fuori con molta saliva prima di metterle via. Questa azione è legata alla figura del “marabutto”, che è un santone. La saliva di un marabutto è considerata sacra. Masticando le monete, il mendicante le benedice. In questo modo, aumenta il valore spirituale per chi gli ha fatto l’elemosina. Questo gesto rituale lo rende diverso dagli altri mendicanti e dona al suo viso un’espressione di pace speciale. Significa che anche lui ha qualcosa di prezioso da offrire in cambio dell’aiuto ricevuto: una benedizione.Come si può affermare con certezza che la ripetizione sonora definisca l’identità di una persona o che la masticazione delle monete conferisca un valore spirituale oggettivo?
Il capitolo presenta interpretazioni suggestive di pratiche culturali e religiose, attribuendo significati profondi (identità, sacralità, benedizione) a gesti e suoni osservati dall’esterno. Tuttavia, non chiarisce su quali basi si fondino queste attribuzioni di significato, rischiando di scambiare l’interpretazione dell’osservatore per la realtà vissuta dai soggetti. Per affrontare queste lacune e comprendere meglio le sfide dell’interpretazione culturale e religiosa, sarebbe utile approfondire gli studi di antropologia e sociologia delle religioni. Autori come Clifford Geertz hanno esplorato a fondo le problematiche legate alla comprensione dei simboli e dei rituali in contesti culturali diversi, sottolineando la necessità di andare oltre la descrizione superficiale per cogliere i significati “spessi” e contestualizzati.3. Il Rifugio Silenzioso e le Apparizioni Segrete
In una città straniera, le case fungono da rifugi essenziali per chi cerca tranquillità lontano dalla confusione. Questi edifici sono progettati per essere silenziosi e appartati all’interno, presentando poche aperture dirette sulla strada esterna. La vita quotidiana si svolge principalmente nei cortili interni, spazi privati che si aprono verso il cielo, offrendo un senso di protezione e intimità. Anche i tetti diventano parte di questo mondo privato; salire su di essi offre una vista unica della città, una distesa di terrazze con proprie regole sociali. Su queste terrazze, ad esempio, gli uomini non dovrebbero essere visti, poiché sono spazi riservati alle donne che li utilizzano per trovare un momento di pace. È inoltre considerato sconveniente e maleducato spiare nei cortili delle case vicine, rafforzando l’idea di questi spazi come mondi separati e privati.La strada e un incontro inatteso
In contrasto con la vita nascosta degli interni e dei tetti, la strada offre un’altra prospettiva, anche se le case appaiono spesso chiuse e le donne raramente visibili dalle finestre. Proprio in strada si verifica un incontro inusuale: una giovane donna è visibile dietro una grata al primo piano di una casa. Non indossa il velo e parla con una voce sommessa e delicata. La sua presenza è notevole per la sua visibilità e la sua voce sembra esprimere tenerezza, quasi una supplica a non allontanarsi. L’area intorno a questa casa non è deserta; donne velate passano, mostrando disapprovazione verso chi si ferma a guardare, e passano anche gruppi di scolari. Seguendo una donna velata, si raggiunge una piccola qubba, un sepolcro di santi, dove si osserva un rituale: una donna con un bambino bacia stracci su un anello della porta, un gesto poi imitato dai ragazzi presenti.Una rivelazione inattesa
Il mistero intorno alla giovane donna alla grata si chiarisce in parte interrogando uno dei ragazzi presenti. Quando gli si chiede di lei, il ragazzo risponde con una frase concisa ma significativa: è “molto malata, in testa”. Questa semplice rivelazione, pronunciata con una certa reticenza o consapevolezza, ha un effetto immediato e profondo sui bambini. Essi diventano improvvisamente seri e silenziosi, come se la verità sulla sua condizione li toccasse profondamente. Questo cambiamento repentino nel loro atteggiamento sottolinea il peso o la delicatezza di questa informazione nel loro mondo.Ma davvero un singolo asino che si muove dimostra la “voglia” universale nelle creature tormentate?
Il capitolo trae una conclusione molto ampia sulla “voglia” universale nelle creature tormentate basandosi sull’improvviso movimento di un asino. Questa generalizzazione da un singolo caso animale a un concetto universale, applicabile implicitamente anche agli esseri umani, presenta una lacuna argomentativa significativa. Per approfondire la complessità di concetti come “voglia”, “volontà” o “resilienza” e capire come interpretarli nel contesto della sofferenza, sarebbe utile esplorare la filosofia, in particolare le discussioni sulla volontà e il desiderio, la psicologia, che studia la motivazione e la resilienza umana, e l’etologia, per comprendere i limiti nell’interpretare il comportamento animale.7. Sotto la Superficie di Marrakech
Nella Medina di Marrakech, a pochi passi dalla vasta piazza Djema el Fna, si trova il bar “Shahrazad”, un piccolo locale di impronta francese che prende vita solo dopo il tramonto. Questo luogo diventa un punto di ritrovo per europei e arabi benestanti, creando un netto contrasto con la realtà degli uomini poveri che trascorrono la notte dormendo sulla piazza vicina. L’atmosfera all’interno è caratterizzata da musica europea e bevande dai prezzi elevati, un ambiente selezionato gestito da Madame Mignon. Di origini franco-cinesi, Madame Mignon non nasconde i suoi forti pregiudizi, riservando la sua tolleranza quasi esclusivamente a francesi e cinesi.La gestione del bar e le sue ombre
Il marito di Madame Mignon, un ex membro della Legione Straniera, frequenta abitualmente un bordello nelle vicinanze e ha l’abitudine di portarvi i clienti del bar. Madame Mignon si occupa personalmente di gestire i clienti che creano problemi, mostrando una particolare avversione per gli americani, che detesta profondamente. Per mantenere l’ordine e la sicurezza nel locale, non esita a tenere a portata di mano uno sfollagente, rivelando un lato più duro e pragmatico dietro l’apparente facciata di un ritrovo esclusivo.La storia di Ginette
Tra le persone che frequentano assiduamente il “Shahrazad” c’è Ginette, un’amica di Madame Mignon. Ginette è una giovane donna nata in Marocco da genitori europei, ma la sua vita è segnata da difficoltà e infelicità. È sposata con un giovane marocchino dall’aspetto delicato, la cui posizione e il cui sostentamento dipendono interamente dall’essere il favorito del figlio del Glaoui. Per riuscire a vivere, Ginette è costretta dal marito a concedersi sessualmente a ricchi arabi. Il marito la picchia violentemente se lei si rifiuta o se mostra interesse per qualcuno senza un tornaconto economico immediato. Ginette vive questa situazione con profonda sofferenza e il suo desiderio più grande è quello di poter lasciare definitivamente il Marocco. La sua condizione è complicata anche dalle dinamiche familiari: il padre del marito lo ha diseredato a causa del matrimonio con un’europea, mentre il padre di Ginette non approva affatto la sua unione con un arabo.Il contrasto sulla piazza
Lontano dall’ambiente del bar, sulla piazza Djema el Fna, specialmente al crepuscolo, si manifesta una presenza che incarna una realtà completamente diversa. Si tratta di una figura misteriosa, un fagotto scuro accovacciato a terra, con il volto completamente nascosto da un panno, quasi a voler annullare la propria identità. Questa figura emette un suono costante, un ronzio basso e profondo, che sembra provenire da un altro mondo. La figura non si muove mai e non si vede raccogliere le monete che a volte le vengono lanciate dai passanti. Questa presenza immobile e sonora sulla piazza rappresenta una condizione di estrema marginalità, anonimato e isolamento, offrendo un forte e toccante contrasto con la vita che si svolge nel bar “Shahrazad” e le storie personali che vi si intrecciano.Il capitolo descrive la tragica condizione di Ginette, ma quanto contesto fornisce per capire perché si trova in una situazione così disperata e legata a figure come il figlio del Glaoui?
Il capitolo presenta la storia di Ginette come un dramma personale, ma la sua dipendenza dal “favorito del figlio del Glaoui” e le dinamiche familiari (diseredazione, disapprovazione) suggeriscono un contesto socio-politico ed economico molto specifico e complesso. La narrazione, concentrandosi sul dramma individuale, rischia di non fornire sufficienti dettagli sulle strutture di potere, le tradizioni sociali e le pressioni economiche che rendono possibile e forse endemica una situazione del genere. Per comprendere appieno la profondità della sua disperazione e la mancanza di vie d’uscita, sarebbe utile approfondire la storia del Marocco nel periodo descritto, esplorando le figure politiche locali come il Glaoui e le loro reti di influenza, nonché le dinamiche sociali legate ai matrimoni misti e alle aspettative familiari. Discipline come la storia sociale e la sociologia possono offrire gli strumenti per analizzare queste strutture sottostanti. Autori che hanno studiato la storia del Marocco o le società nordafricane possono fornire il contesto necessario.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]