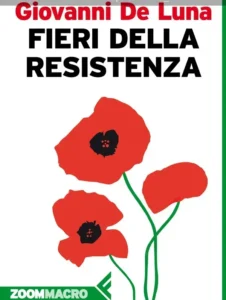Contenuti del libro
Informazioni
ti catapulta negli anni Settanta italiani, un decennio segnato da un conflitto sociale e politico fortissimo. Il libro esplora le vite e le lotte dei movimenti, della sinistra extraparlamentare, degli operai nelle fabbriche come la Fiat e degli studenti, che si scontrano con l’ombra dello Stato, la sua opacità e una giustizia spesso assente per le vittime di violenza politica e delle stragi. Racconta come il terrorismo abbia stravolto tutto e il percorso di gruppi come Lotta Continua. È la storia di una militanza intensa, ma anche di una sconfitta che porta al tramonto del protagonismo operaio e all’affermarsi dell’individualismo negli anni ’80. Soprattutto, è un viaggio nella memoria divisa di quel periodo, un ricordo fatto di dolore privato e richieste pubbliche di verità, perché la giustizia non è mai stata piena. Un libro essenziale per capire le ragioni profonde di un decennio ancora irrisolto nella memoria italiana.Riassunto Breve
Gli anni Settanta in Italia sono stati un periodo molto difficile, pieno di scontri e violenza. Tante persone, soprattutto giovani che facevano politica a sinistra ma non erano terroristi, sono state uccise. Per molte di queste morti, come quelle causate dalla polizia o da gruppi fascisti, la giustizia non è mai arrivata davvero. Le indagini erano complicate e spesso i colpevoli non venivano trovati o ricevevano pene leggere. Questo era diverso da come venivano trattati i casi di terrorismo, dove si usavano i pentiti per arrivare ai risultati. Anche per le grandi stragi, come quella di Piazza Fontana o alla stazione di Bologna, dove si pensa ci fossero di mezzo gruppi neofascisti e anche pezzi dello Stato, la verità completa non è mai venuta fuori. Sembra che quando le istituzioni sono coinvolte, diventa difficile capire tutto. C’è una parte nascosta dello Stato, dove non si capisce bene cosa sia legale e cosa no, e questo fa perdere fiducia nella democrazia.I movimenti nati dal Sessantotto si accorgono di questa mancanza di trasparenza e ingiustizia. Dopo Piazza Fontana, molti chiedono la verità, dicendo che “la verità è rivoluzionaria”. Ci sono scandali, come quello delle schedature illegali alla Fiat, che mostrano legami strani tra aziende e forze dell’ordine. Questi fatti e la sensazione che la giustizia non funzioni per tutti, come nel caso Pinelli-Calabresi, aumentano la sfiducia. L’instabilità dei governi di quel periodo viene vista dai movimenti come un segno che lo Stato è in crisi e potrebbe diventare più autoritario. Quando i partiti più grandi, DC e PCI, si mettono insieme nei governi di “solidarietà nazionale”, molti nei movimenti si sentono traditi e si allontanano dalla politica tradizionale. Questa delusione e la sensazione che il potere sia sempre lo stesso, anche se cambiano i governi, contribuiscono a far diminuire la forza dei movimenti e a far crescere la violenza armata.La violenza, che all’inizio era più usata dai gruppi di destra, si diffonde anche in alcuni settori dei movimenti di sinistra, soprattutto quando le grandi mobilitazioni di piazza diminuiscono dopo il 1975. All’inizio, i movimenti non cercano la violenza, ma la subiscono come risposta dello Stato alle loro proteste. Questa reazione dello Stato fa nascere l’idea che ci sia una “continuità dello Stato”, cioè che le istituzioni usino ancora metodi repressivi del passato. Questa idea porta alcuni a pensare che sia necessario rispondere con la forza per non lasciare allo Stato il monopolio della violenza. Alcuni gruppi scelgono così la lotta armata, ma il terrorismo si separa dalle lotte di massa, diventando un gruppo a parte che usa la violenza per colpire simbolicamente o per punire chi non è d’accordo al suo interno. La violenza, così, perde il suo legame con la politica e diventa fine a se stessa.I partiti politici tradizionali reagiscono in modo diverso. Il PartRiassunto Lungo
1. Memoria, Giustizia e l’Ombra dello Stato
Gli anni Settanta in Italia sono stati un periodo di grande tensione, segnato da episodi di violenza politica che hanno portato alla morte di molti militanti, in particolare di sinistra. Queste vittime non erano coinvolte nel terrorismo o nelle forze dell’ordine, ma rappresentavano una parte attiva dei movimenti sociali e politici dell’epoca. Eventi come l’uccisione di Tonino Miccichè nel 1975 e di Francesco Lorusso nel 1977 testimoniano un clima di forte conflitto, ma anche una progressiva perdita di coesione all’interno degli stessi movimenti.La difficile ricerca della giustizia
Per molte delle persone uccise in quel periodo, soprattutto quando le responsabilità ricadevano su forze dell’ordine o gruppi fascisti, ottenere giustizia è stato estremamente difficile o impossibile. Le indagini spesso non portavano a risultati concreti, e le sentenze, quando c’erano, raramente individuavano i colpevoli o prevedevano pene severe. Questa situazione contrasta nettamente con i successi ottenuti nelle indagini sul terrorismo, dove l’uso dei collaboratori di giustizia (i “pentiti”) ha spesso permesso di arrivare a verdetti.Le stragi e il ruolo dello Stato
La mancanza di verità giudiziaria si estende anche a episodi terribili come le stragi legate alla strategia della tensione, tra cui Piazza Fontana e la stazione di Bologna. In questi casi, le indagini hanno spesso indicato il coinvolgimento di gruppi neofascisti, ma anche di settori deviati degli apparati statali. Proprio l’implicazione di figure istituzionali sembra aver rappresentato un ostacolo fondamentale per l’accertamento completo e trasparente dei fatti, lasciando molte domande senza risposta.L’opacità delle istituzioni
Questa situazione mette in luce l’esistenza di una zona poco chiara nel funzionamento dello Stato, dove si mescolano azioni che rispettano la legge e azioni illegali. Questa ambiguità alimenta la sfiducia dei cittadini e rende le istituzioni poco trasparenti. Non si tratta del normale segreto di Stato, che in certi casi può essere necessario, ma di un’opacità dannosa per la democrazia, che impedisce ai cittadini di comprendere appieno ciò che accade e di fidarsi delle proprie istituzioni.Una memoria divisa
Di conseguenza, la memoria di queste vittime e delle stragi rimane frammentata e non condivisa. Lo Stato non è riuscito a garantire un percorso di giustizia credibile che potesse unire le diverse esperienze e ricordi in uno spazio pubblico comune. Spesso, gli unici luoghi dove queste storie vengono ricordate e onorate sono le lapidi e i monumenti voluti dai familiari e dai compagni, testimonianza di un dolore e di un lutto che non si sono mai pienamente risolti.Ma è davvero solo l’ombra dello Stato a spiegare perché la giustizia per alcune vittime degli anni Settanta è rimasta un miraggio?
Il capitolo dipinge un quadro fosco, in cui l’opacità istituzionale è il principale ostacolo alla verità e alla giustizia per chi non rientrava nelle categorie “protette” (terroristi o forze dell’ordine). Tuttavia, la narrazione degli anni Settanta è intessuta di molteplici fili: la natura stessa della violenza politica diffusa, le dinamiche interne ai movimenti, le difficoltà investigative intrinseche a certi contesti, il clima di scontro politico che influenzava ogni aspetto della vita pubblica. Per comprendere appieno perché alcuni percorsi giudiziari si sono arenati, mentre altri (come quelli sul terrorismo) hanno avuto maggior successo, è necessario allargare lo sguardo oltre la pur innegabile questione dell’opacità statale. Approfondire la storia sociale e politica del periodo, le specifiche vicende processuali e il ruolo dei diversi attori (non solo lo Stato, ma anche i movimenti, i partiti, i media) è fondamentale. Si potrebbero esplorare le analisi di storici come Miguel Gotor o le riflessioni sul sistema giudiziario in quegli anni.2. L’ombra del potere
I movimenti nati dal Sessantotto reagiscono con forza alla percezione di opacità e ingiustizia che sentono negli apparati dello Stato. Dopo la strage di piazza Fontana, la sinistra extraparlamentare lancia una campagna contro quella che definisce la “strage di Stato”. L’obiettivo è svelare i segreti del potere, usando strumenti come la stampa e la controinformazione. Un esempio chiaro di questa battaglia è lo scandalo delle schedature illegali scoperte alla Fiat nel 1971. Si scopre che l’azienda schedava illegalmente dipendenti e cittadini, pagando carabinieri e poliziotti per ottenere informazioni. Il processo su questo caso viene spostato da Torino e si conclude con la prescrizione, un esito che rafforza l’idea che certi poteri siano intoccabili. Lotta Continua denuncia apertamente questa collaborazione tra forze dell’ordine e interessi privati. Lo slogan “la verità è rivoluzionaria” diventa molto popolare, esprimendo la convinzione diffusa che i segreti di Stato mettano in pericolo la democrazia stessa. Il caso Pinelli-Calabresi e l’appello firmato da molti intellettuali e personaggi pubblici mostrano quanto stesse crescendo la sfiducia nella giustizia. L’omicidio del commissario Calabresi avviene in questo clima di tensione e sospetto. Anche Pier Paolo Pasolini esprime pubblicamente un forte senso di impotenza di fronte a poteri occulti e non dimostrabili con prove formali.
Il contesto politico e le sue conseguenze
Nei primi anni Settanta, l’Italia vive un periodo di forte instabilità politica, con governi che durano poco. I movimenti interpretano questa situazione come un segno che lo Stato borghese è in crisi e non riesce più a gestire i conflitti sociali con metodi democratici. Lotta Continua, in particolare, vede in questa debolezza una spinta verso soluzioni più autoritarie, che definisce “fanfascismo”. Le elezioni del 1976 cambiano il quadro politico: vincono la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, portando alla formazione dei governi di “solidarietà nazionale”. Questa alleanza politica, vista dai movimenti come un patto con il “nemico”, crea molta frustrazione sia nei movimenti stessi che tra chi li votava. Aumenta così la distanza tra i cittadini e i partiti politici tradizionali. La sensazione che dietro la facciata politica ci sia un potere democristiano che non cambia mai, unita all’opacità delle istituzioni, contribuisce a diffondere sfiducia e rassegnazione. Questi sentimenti giocano un ruolo importante nel declino dei movimenti e, al tempo stesso, favoriscono l’emergere della violenza armata. L’analisi che i movimenti fanno di questi eventi, pur cogliendo il disagio generale, non riesce però a comprendere pienamente i cambiamenti più profondi che stanno avvenendo nella società e nell’economia del paese.
Ma è sufficiente la frustrazione politica a spiegare il doppio esito del Settanta: il riflusso dei movimenti e l’esplosione della lotta armata?
Il capitolo collega la crisi dei movimenti e l’ascesa della violenza armata alla delusione per gli sviluppi politici. Tuttavia, questa spiegazione rischia di semplificare eccessivamente un quadro complesso. Il declino dei grandi movimenti di massa e la scelta della lotta armata da parte di gruppi minoritari sono fenomeni distinti, seppur interconnessi, influenzati da una pluralità di fattori che vanno oltre la sola frustrazione politica. Per approfondire, sarebbe utile esplorare le dinamiche interne ai movimenti, le specifiche ideologie dei gruppi armati, e le profonde trasformazioni sociali ed economiche dell’Italia di quegli anni. Lo studio di autori che hanno analizzato la storia sociale e politica del periodo, le teorie sui movimenti collettivi e le origini del terrorismo politico può aiutare a cogliere le sfumature di questo passaggio cruciale.3. L’eredità armata
La violenza nei movimenti di protesta politica di sinistra si diffonde in modo significativo soprattutto dopo il 1975, in una fase di calo della mobilitazione generale. Prima di questo periodo, tra il 1969 e il 1975, sono le violenze di destra a prevalere. All’inizio, il movimento studentesco affronta la violenza senza averla teorizzata. Le prime azioni di protesta sono pacifiche, caratterizzate da sit-in, resistenza passiva e manifestazioni che includono anche aspetti ludici. In questa fase iniziale, non c’è una teoria della violenza promossa da forze politiche esterne al movimento stesso. Le tensioni che emergono sono spesso gestite con ironia o tolleranza, cercando di non escalation.La reazione dello Stato e l’idea di “continuità”
La violenza viene presto interpretata come una diretta repressione da parte dello Stato. Episodi come i primi arresti a Torino nel marzo 1968 e gli scontri violenti a Valle Giulia a Roma mostrano chiaramente la reazione statale alle proteste. Questi eventi alimentano nel movimento la percezione che i problemi e le istanze portate avanti siano trattati dalle autorità unicamente come questioni di ordine pubblico, ignorando le motivazioni politiche e sociali. Si diffonde così l’idea di una “continuità dello Stato”, intesa come la persistenza di forme repressive e autoritarie ereditate dal passato, identificando lo Stato stesso con il suo “apparato della forza”.Dall’università alla “lunga marcia”
Questa visione della repressione statale porta il movimento a sentire la necessità di “uscire dall’università” e cercare un collegamento più stretto con il movimento operaio, considerato una forza sociale più ampia e radicata. Da questa esigenza si sviluppa la strategia della “lunga marcia attraverso le istituzioni”. L’obiettivo di questa strategia è trasformare la società agendo dall’interno delle sue strutture esistenti, piuttosto che attraverso un assalto diretto al potere statale. Questa linea politica affonda le sue radici nell’esperienza maturata in ambito universitario e si basa sul principio di “scavare dove si è”, ovvero agire e trasformare partendo dal proprio contesto immediato.La svolta dopo Piazza Fontana e il ritorno dell’antifascismo
Dopo la strage di Piazza Fontana, avvenuta nel dicembre 1969, la strategia della “lunga marcia” subisce un indebolimento. L’idea della “continuità dello Stato” diventa un elemento ancora più centrale nell’analisi politica del movimento, creando un legame forte tra le lotte presenti e la lotta partigiana della Resistenza. L’antifascismo militante riemerge con forza, focalizzandosi in particolare sulla “Resistenza rossa” e sugli aspetti più spontanei e insurrezionali di quel periodo storico. Questo cambiamento porta a un passaggio significativo nella percezione e nell’uso della violenza: da una visione prevalentemente difensiva, vista come reazione necessaria alla repressione statale, si passa a una visione offensiva. L’obiettivo diventa esplicitamente quello di contrastare e mettere in discussione il monopolio statale sull’uso della forza.L’emergere della lotta armata e il suo distacco
Questo capovolgimento strategico e ideologico spinge alcuni gruppi all’interno del movimento a scegliere la strada della lotta armata. Questi gruppi imitano modelli del passato, come i Gruppi di Azione Patriottica (GAP) della Resistenza. Tuttavia, il fenomeno del terrorismo si distacca progressivamente dalla lotta di massa e dai movimenti sociali più ampi. Si struttura come un apparato militare autonomo, concentrando le proprie azioni su omicidi simbolici e, tragicamente, anche su punizioni interne al proprio ambiente. La violenza, in questo contesto, perde il suo legame con un obiettivo politico condiviso e rischia di diventare fine a se stessa, come testimoniano le esperienze dolorose delle vittime. La sinistra nel suo complesso incontrerà grandi difficoltà nel fare i conti con questa complessa e pesante eredità violenta.La “perdita del legame con il passato” e l’equiparazione tra partigiani e fascisti sono solo sintomi di nuovi conflitti o il segno di una più profonda crisi storica e culturale non adeguatamente spiegata nel capitolo?
Il capitolo descrive efficacemente il passaggio dalla militanza del Sessantotto ai conflitti contemporanei, ma la spiegazione di come si arrivi a una presunta “perdita del legame con il passato” e a fenomeni come l’equiparazione tra partigiani e fascisti appare più come una constatazione che un’analisi approfondita delle cause. Per comprendere meglio questo complesso snodo storico e culturale, sarebbe utile esplorare le dinamiche della memoria collettiva e della sua manipolazione, le trasformazioni del discorso pubblico e il ruolo dei media nella costruzione del presente. Discipline come la storia contemporanea, la sociologia politica e gli studi culturali offrono strumenti essenziali. Autori come Paul Ginsborg, Ilvo Diamanti o Ernesto Galli della Loggia possono fornire prospettive diverse e stimolanti su questi temi cruciali per l’Italia contemporanea.8. Anni di Conflitto e Movimento
Gli anni Settanta sono stati un periodo di forte scontro sociale e politico in Italia. Questo decennio ha visto manifestazioni e mobilitazioni su diversi fronti, dalle fabbriche alle piazze, animate dalla volontà di ottenere migliori condizioni di vita e maggiori diritti. Le tensioni erano palpabili e hanno coinvolto ampie fasce della popolazione, portando a cambiamenti significativi nel tessuto sociale e politico del paese. È stato un periodo caratterizzato da una grande effervescenza e da una spinta al cambiamento che si è manifestata in molteplici forme di protesta e organizzazione.Le Lotte nelle Fabbriche
Nelle fabbriche, in particolare alla Fiat, il conflitto era una realtà quotidiana e diffusa. Ci furono scioperi molto importanti per il rinnovo dei contratti, come quelli del marzo 1973, che culminarono con l’occupazione dello stabilimento di Mirafiori e con imponenti cortei che uscirono dai cancelli della fabbrica per riversarsi in città. Altri scioperi generali dei metalmeccanici portarono a grandi manifestazioni nel centro cittadino, riempiendo via Roma e piazza San Carlo sia nel 1976 che nel 1979. La tensione era spesso altissima, con azioni dirette degli operai che arrivavano a bloccare strade o a occupare gli uffici dei dirigenti per far sentire la propria voce. Anche eventi politici di portata nazionale, come il rapimento di Aldo Moro nel 1978, ebbero un impatto sulla vita di fabbrica, con comizi ai cancelli segnati da un silenzio carico di significato. Verso la fine del decennio, si iniziò a notare una trasformazione, suggerita anche dai graffiti che comparivano sui muri, indicando un possibile passaggio del testimone o un cambiamento di protagonisti, dagli operai tradizionali a una nuova generazione, a volte identificata come “ragazzi di stadio”.La Battaglia per la Casa
La lotta per ottenere un alloggio dignitoso fu un altro fronte cruciale di questo periodo. La necessità urgente di abitazioni portò all’occupazione di edifici abbandonati o sottoutilizzati, un esempio significativo fu l’occupazione che ebbe luogo alla Falchera tra il 1974 e il 1975. Questa azione specifica vide la nascita di comitati di lotta dedicati e l’emergere di figure di riferimento che divennero punti cardinali per il movimento, come Tonino Miccichè. Le condizioni di vita estremamente difficili affrontate da molti, specialmente dagli operai immigrati dal Sud che spesso vivevano in situazioni precarie e sovraffollate come le soffitte, mettevano in luce in modo drammatico il bisogno impellente di soluzioni concrete alla crisi abitativa che affliggeva ampie fasce della popolazione.Diritti Civili e Solidarietà
Parallelamente ai conflitti nelle fabbriche e alla lotta per la casa, si combattevano altre importanti battaglie sul piano sociale e politico. Ci fu una forte opposizione al fascismo e un impegno costante nella difesa dei diritti civili e degli spazi democratici. Assemblee pubbliche si tenevano regolarmente, spesso con la partecipazione di figure note che offrivano il loro contributo e la loro visibilità alle diverse cause. Eventi storici come gli scioperi del 1943, caratterizzati da comizi unitari che dimostravano una forte coesione, venivano ricordati come fonte di ispirazione per le lotte presenti. La solidarietà si estendeva oltre i confini nazionali, con manifestazioni organizzate contro il regime franchista in Spagna e azioni di soldati di leva organizzati che intervennero in supporto dei movimenti in Portogallo. Sul fronte dei diritti civili interni, grandi cortei scesero in piazza per sostenere il “no” al referendum sul divorzio nel 1974 e per chiedere con forza la depenalizzazione dell’aborto nel 1975. La popolazione si mobilitò attivamente anche contro l’inquinamento industriale, denunciandone gli effetti nocivi, e contro leggi che prevedevano tagli ai finanziamenti per gli enti locali, mettendo a rischio i servizi pubblici e il benessere della comunità.È sufficiente un graffito per spiegare il presunto ‘passaggio di testimone’ dai ‘tradizionali operai’ a una non meglio identificata ‘nuova generazione’?
Il capitolo accenna a un cambiamento nei protagonisti delle lotte verso la fine del decennio, citando un graffito come indizio. Tuttavia, questa ‘nuova generazione’ o ‘ragazzi di stadio’ non viene definita né il suo ruolo spiegato, lasciando un vuoto nella comprensione di questa transizione. Per approfondire, è necessario studiare la storia sociale del periodo, analizzando la crisi delle identità operaie tradizionali e l’emergere di nuovi soggetti sociali (giovani, precari, ecc.). Si possono consultare autori che hanno studiato le trasformazioni sociali e politiche degli anni Settanta, come Guido Crainz, che offrono un quadro più articolato dei diversi attori in campo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]