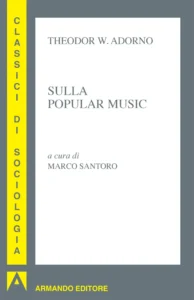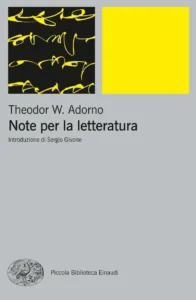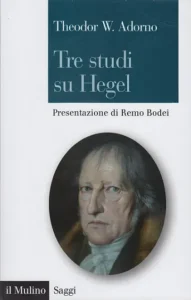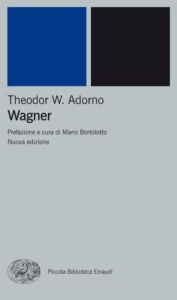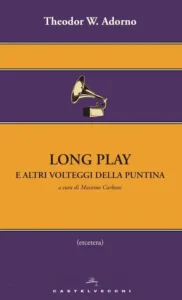1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“L’attualità della filosofia. Tesi all’origine del pensiero critico” di Theodor Adorno è un testo fondamentale per capire da dove nasce il suo pensiero. Immagina la filosofia che si trova un po’ persa, dopo che i grandi sistemi del passato sono crollati e la realtà sembra aver perso il suo senso unitario, apparendo solo come un insieme di frammenti. Adorno dice che la filosofia non deve arrendersi, ma cambiare gioco: non cercare più un senso nascosto, ma dedicarsi all’interpretazione, riordinando questi frammenti per far emergere la verità, un po’ come comporre una costellazione. Questo libro esplora idee cruciali come la “storia naturale”, che supera la vecchia divisione tra natura e storia, e soprattutto la “critica del linguaggio”. Adorno capisce che anche le parole sono state svuotate e frammentate dalla società, e il lavoro del filosofo diventa un’arte di comporre questi frammenti linguistici per esprimere la verità, riconoscendo che le parole stesse hanno una storia. È qui che si gettano le basi per concetti che svilupperà in opere come Minima Moralia o la Dialettica negativa, mostrando come il pensiero critico debba concentrarsi sul dettaglio e rifiutare le totalità astratte. Non aspettarti una storia con personaggi o luoghi specifici, ma un viaggio intenso nel paesaggio della filosofia contemporanea che affronta la crisi del senso e cerca nuove strade per la conoscenza, usando l’interpretazione filosofica e una profonda critica dell’ontologia tradizionale e del linguaggio. È un testo che ti fa capire perché il pensiero di Adorno è ancora così rilevante oggi.Riassunto Breve
La filosofia oggi si trova in difficoltà perché la realtà non sembra più avere un senso unico e completo, come pensavano i vecchi sistemi filosofici che sono falliti. Questo ha creato una separazione tra il pensiero e il mondo. Per essere ancora utile, la filosofia deve cambiare modo di lavorare. Non cerca più un significato nascosto, ma si dedica a interpretare quello che c’è. Interpretare significa mettere insieme gli elementi che abbiamo, un po’ come si fa con le stelle per formare una costellazione, per cercare di capire le cose senza dare risposte definitive. Questo modo di fare è diverso dalla scienza e ha qualcosa in comune con l’idea di cambiare la realtà dopo averla capita. Un altro concetto importante è l’idea di storia naturale, che supera l’opposizione tra natura e storia. Si capisce che la storia può diventare rigida e fissa come la natura, mentre la natura può apparire transitoria e cambiare come la storia. Questa visione critica chi cerca di trovare un principio fisso per spiegare la storia. Anche il linguaggio è cambiato. Le parole hanno perso la loro forza perché la società è divisa e frammentata. Il linguaggio della filosofia non ha parole piene di significato, ma solo pezzi. Per questo, la filosofia critica diventa una critica del linguaggio. Non si inventano parole nuove, ma si usano i frammenti che ci sono, mettendoli insieme per dire la verità, riconoscendo che le parole cambiano con la storia e la società. Questi concetti iniziali sono alla base del pensiero critico che si è sviluppato dopo. Anche opere più mature usano una forma frammentata per mostrare che non si crede più nelle totalità e ci si concentra sui dettagli. La dialettica negativa, che dice che i concetti non sono identici alle cose, continua l’idea di lavorare con la frammentazione e di superare l’opposizione tra natura e storia. La critica al linguaggio continua, per esempio, analizzando come vengono usate certe parole. La filosofia contemporanea non può più pensare di capire tutta la realtà solo con il pensiero. La realtà si presenta in modo difficile, offrendo solo pezzi. Sperare in una realtà perfetta grazie alla filosofia nasconde la situazione attuale. Chiedersi cos’è l’essere, che sembra una domanda profonda, in realtà non lo è più perché presuppone che l’essere sia qualcosa che possiamo capire, cosa che non è più vera. L’idea dell’essere è diventata debole, solo un principio formale. La storia recente della filosofia mostra questa crisi. L’idealismo non è riuscito a far derivare la realtà dalla ragione. Altri movimenti si sono chiusi in aspetti formali o hanno perso contatto con la realtà concreta. Le filosofie scientifiche si limitano ai fatti verificabili, ma non risolvono i problemi filosofici importanti. La fenomenologia ha cercato un ordine oggettivo usando strumenti idealisti, finendo per usare idee soggettive per qualcosa che dovrebbe essere oggettivo. I tentativi successivi sono falliti, ritirandosi in idee poco chiare o nella disperazione. Le categorie usate per descrivere l’esistenza non riescono a cogliere la vita nella sua pienezza. La filosofia non sa rispondere alla domanda sull’essere. L’importanza della filosofia oggi viene dalla storia dei suoi problemi. Dopo il fallimento dei grandi sistemi, ci si chiede se la filosofia sia ancora possibile. La scienza, in particolare la logica empirista, cerca di eliminare la filosofia riducendo la conoscenza a ciò che si può verificare con l’esperienza. Ma la scienza stessa si basa su idee filosofiche non risolte. La filosofia non diventa scienza, ma si occupa dei problemi che le scienze non possono risolvere da sole. La differenza tra scienza e filosofia non è che una è più generale o astratta, ma nel loro scopo: la scienza cerca risultati certi, la filosofia interpreta. L’obiettivo della filosofia è l’interpretazione. Questa non cerca un senso nascosto, ma riorganizza gli elementi della realtà, spesso presi dalle scienze sociali, in modi che rendono la realtà più chiara e fanno sparire la domanda iniziale. Questo processo è dinamico ed è legato all’azione, al cambiamento della realtà. Il compito attuale della filosofia richiede di lasciare perdere le vecchie domande sull’essere, i concetti generali che non cambiano e le idee astratte di totalità. Si concentra su situazioni storiche concrete, usando materiali dalla sociologia. Questo modo di fare è un’arte di inventare, che usa l’immaginazione in modo preciso per creare modelli dalla realtà. Questi modelli sono giusti solo quando la domanda che li ha generati scompare. Questo metodo, che accetta di provare senza avere garanzie, può essere visto come una forma di “saggismo” filosofico, che va nel dettaglio per risolvere i problemi della realtà. Si cerca di superare la vecchia divisione tra natura e storia. La natura qui non è quella studiata dalla scienza, ma l’aspetto immutabile, ciò che nella storia umana sembra un destino inevitabile. La storia è il movimento che crea cose nuove. L’obiettivo è trovare un punto in cui natura e storia non siano più separate. L’ontologia di oggi cerca un essere che sia al di là del soggetto, ma usa ancora la ragione soggettiva. Questo crea problemi nel capire il senso dell’essere e la realtà concreta. L’ontologia cerca di superare la divisione tra storia e mancanza di storia, ma finisce per definire l’essere usando l’idea astratta di storicità. Questo approccio non riesce a cogliere la concretezza dei fatti storici e mantiene caratteristiche idealiste, come l’idea di poter capire tutta la realtà in una struttura e dare più importanza a ciò che è possibile rispetto a ciò che è reale. Questo porta a descrizioni ripetitive, dove la storia viene spiegata usando la sua stessa definizione astratta. L’idea della storia naturale propone invece di capire la storia concreta come se fosse natura e la natura come se fosse storia. Questa idea viene dalla filosofia della storia. Si parla di “seconda natura” per descrivere il mondo sociale creato dagli uomini, che diventa strano e rigido, come una natura. Si vede la storia nella fragilità e nel decadimento delle cose naturali e la natura come storia che passa. L’allegoria diventa uno strumento per trovare significato in questi aspetti che cambiano e sono frammentati della storia, vista come un percorso di sofferenza. La storia non è continua, ma un mix tra l’aspetto immutabile del passato e il nuovo che appare. L’aspetto immutabile non è fermo, ma ha un suo movimento interno. Il nuovo nella storia può sembrare vecchio, come nella “parvenza”, che è un fenomeno storico-naturale. La parvenza, anche se sembra un’illusione, rivela qualcosa di reale e legato all’aspetto immutabile. La storia naturale è la trasformazione della storia concreta in una natura che cambia e viceversa. La distinzione tra forma e contenuto nel linguaggio filosofico non è fissa, ma nasce dal pensiero idealista. Questa visione pensa che concetti e parole siano solo etichette scelte a caso per descrivere caratteristiche diverse, la cui unità è creata dalla mente. Nell’idealismo, i nomi non hanno un legame profondo con le cose che indicano, visti come scelte libere della mente. Questa possibilità di scambiare i nomi mostra quanto sia casuale l’unità dei concetti costruita dalla mente. Il linguaggio filosofico che cerca la verità non usa segni scelti a caso. La storia è parte della verità ed entra nelle parole, dando loro il carattere di verità. La scelta delle parole dipende da questa unione di storia e verità. Il filosofo non solo spiega il pensiero, ma deve trovare le parole che, in certi momenti storici di verità, possono portare il significato voluto. L’idea che il linguaggio filosofico debba essere facile da capire e comunicabile a tutti è un’idea idealista. Presuppone che il linguaggio sia separato dall’oggetto e che lo stesso oggetto possa essere detto in modi diversi. Invece, gli oggetti appartengono al linguaggio e sono legati ad esso storicamente. La comprensibilità non viene dall’adattare il linguaggio alla società, ma dalla dignità oggettiva delle parole. In una società divisa, i linguaggi riflettono questa divisione; pretendere una comprensibilità astratta è un inganno. L’unica vera comprensibilità del linguaggio filosofico si basa sulla fedeltà alle cose che indica e sull’uso delle parole nella loro condizione storica di verità. Ogni tentativo di dare significato in modo astratto porta a criticare il linguaggio. Anche cercare di creare un nuovo linguaggio filosofico per evitare i problemi storici delle parole non va bene. La terminologia tradizionale, anche se frammentata, va conservata, e le parole nuove si formano trasformando le configurazioni storiche esistenti. Oggi il linguaggio filosofico è frammentato, fatto di pezzi di parole legati alla storia. La libertà del filosofo sta nel mettere insieme questi pezzi per dire la verità. Le parole non sono stabili e non se ne possono inventare di nuove. Il linguaggio filosofico deve essere dinamico. Le parole disponibili sono spesso inadeguate o vuote. Cercare di esprimere un contenuto nuovo con un linguaggio vecchio è idealistico e falsa il contenuto. Mettere insieme le parole intorno alla nuova verità è l’unica via, evitando di spiegare tutto in modo esplicito, cosa che presupporrebbe parole intatte. Questa configurazione è un terzo elemento che unisce concetto e cosa in modo inseparabile. La critica filosofica oggi è soprattutto critica del linguaggio, valutando la capacità storica delle parole di portare significato. Il criterio è la dignità estetica delle parole. Le parole senza forza sono quelle criticate dall’arte, che mantiene l’unità di parola e cosa. La critica estetica è fondamentale per la conoscenza. L’arte vera non è metafisica, ma mostra il contenuto reale dell’essere. La critica filosofica del linguaggio unisce arte e conoscenza. La struttura oggettiva di un’opera filosofica deve essere in tensione con la sua struttura linguistica. Un pensiero che usa strumenti logici astratti per analizzare l’essere è oggettivamente falso, perché i contenuti sull’essere non corrispondono a quella forma. L’inganno delle pretese sull’essere deve essere smascherato attraverso il linguaggio, mostrando che il linguaggio usato non è adatto alla conoscenza che si vuole esprimere.Riassunto Lungo
1. La filosofia dopo la perdita di senso
La filosofia si trova di fronte a una grande difficoltà: non riesce più a cogliere la realtà come un insieme completo e pieno di significato. Questo problema nasce dal fatto che i grandi sistemi filosofici del passato non sono riusciti a mantenere le loro promesse. La realtà, di conseguenza, appare svuotata di senso, e questa condizione si manifesta in una separazione netta tra il pensiero e il mondo esterno. Per poter rimanere importante e attuale, il pensiero filosofico deve perciò cambiare completamente il suo modo di procedere. Non cerca più un senso nascosto nelle cose, ma si dedica a un compito diverso: l’interpretazione.Il nuovo compito della filosofia: l’interpretazione
Interpretare significa riorganizzare gli elementi che abbiamo a disposizione. È un po’ come mettere insieme i pezzi di un mosaico o creare un’allegoria, combinando le parti per cercare di sciogliere un enigma. L’obiettivo è fare luce sulla situazione, ma senza mai dare una risposta definitiva o immutabile. Questo metodo si distingue dalla ricerca scientifica, che invece punta a spiegazioni certe. Tuttavia, trova un punto di contatto con l’idea di Marx, secondo cui la comprensione del mondo dovrebbe portare alla sua trasformazione.Storia naturale: superare l’opposizione
Un altro concetto fondamentale è l’idea di storia naturale. Questo pensiero supera la tradizionale divisione tra natura e storia, riconoscendo invece una relazione dinamica tra le due. In questa prospettiva, la storia può diventare rigida e fissa, mentre la natura appare mutevole e transitoria. Questa visione critica fortemente i tentativi di basare la comprensione storica su un principio immutabile e assoluto, come accade in alcune filosofie contemporanee. Suggerisce che la realtà è un processo continuo, non qualcosa di statico.La critica del linguaggio frammentato
La critica si estende anche al linguaggio. Le parole, a causa della frammentazione della società, hanno perso la loro forza e integrità originaria. Il linguaggio usato dalla filosofia, in questa situazione, non dispone più di termini che abbiano un significato pieno e completo, ma solo di frammenti sparsi. La filosofia critica diventa quindi, inevitabilmente, una critica del linguaggio stesso. Non si tratta di inventare parole nuove, ma di mettere insieme i frammenti esistenti per cercare di esprimere la verità, riconoscendo che le parole hanno una loro storia e sono influenzate dalla società.Le radici del pensiero critico successivo
Questi concetti elaborati in gioventù sono la base su cui si è poi sviluppato il pensiero critico successivo. Il modo in cui le opere mature sono esposte, spesso in forma frammentaria come in Minima Moralia, riflette proprio la critica all’idea di totalità e la necessità di concentrarsi sui dettagli. La dialettica negativa, che rifiuta l’identificazione perfetta tra un concetto e la cosa che rappresenta, è una diretta continuazione della logica della disgregazione e del superamento della vecchia contrapposizione tra natura e storia. La critica al linguaggio, infine, prosegue anche nelle analisi successive, per esempio nello studio di espressioni specifiche come il “gergo dell’autenticità”.È davvero così scontato che la realtà abbia “perso il senso”, o questa è solo una specifica prospettiva filosofica che andrebbe giustificata in modo più rigoroso?
Il capitolo parte da una premessa forte sulla “perdita di senso” della realtà, ma non chiarisce sufficientemente se questa condizione sia un dato oggettivo o il risultato di una particolare lettura della storia della filosofia e della società. La validità dell’intero impianto argomentativo dipende da questa assunzione iniziale, che meriterebbe un’analisi più approfondita e un confronto con visioni alternative. Per esplorare questo punto critico, potrebbe essere utile confrontarsi con approcci filosofici che non condividono questa diagnosi di “perdita di senso” o che offrono diverse spiegazioni della condizione contemporanea, leggendo autori come Edmund Husserl, Martin Heidegger (per la sua analisi della tecnica e dell’essere) o esponenti della filosofia analitica come Ludwig Wittgenstein, che hanno approcci radicalmente diversi al linguaggio e al significato.2. Filosofia tra Rovina e Interpretazione
La filosofia contemporanea non può più pensare di afferrare la realtà nella sua totalità. La realtà si presenta al pensiero in modo frammentato e contraddittorio, offrendo solo parti sparse. L’idea che la filosofia possa portare a una realtà giusta è un’illusione che nasconde la condizione attuale. La domanda sull’essere, considerata fondamentale, in realtà non lo è più, perché parte dal presupposto che l’essere sia accessibile al pensiero, cosa che non è più vera. L’idea tradizionale dell’essere ha perso la sua forza, diventando un principio vuoto.I Fallimenti della Filosofia Moderna
La storia recente della filosofia dimostra questa crisi della pretesa di totalità. L’idealismo ha fallito nel tentativo di derivare tutta la realtà dalla ragione. Movimenti successivi hanno mostrato i loro limiti: il neokantismo si è chiuso in aspetti puramente formali, il vitalismo non è riuscito a dare senso all’esperienza concreta, e la scuola del Baden ha usato concetti di valore ambigui. Anche le filosofie che si rifanno alla scienza rinunciano a costruire una visione completa della realtà, limitandosi a descrivere i dati empirici, ma non riescono a rispondere a domande filosofiche essenziali, come il significato della storia o l’esistenza degli altri.Il Caso della Fenomenologia
La fenomenologia, nata dopo il fallimento dell’idealismo, ha cercato di trovare un ordine oggettivo usando però strumenti che derivavano dall’idealismo stesso. Questo ha creato un paradosso: usare categorie legate al soggetto per descrivere un’oggettività che le supera. Husserl, con onestà intellettuale, è rimasto all’interno di un sistema idealista basato sulla coscienza. I tentativi di superare questo limite, passando a una “fenomenologia materiale” con Scheler o a una visione più soggettiva con Heidegger, non hanno avuto successo. Sono sfociati in un vitalismo poco chiaro o in una visione soggettiva piena di disperazione. Le categorie usate da Heidegger, come l’essere-gettato, l’angoscia o la morte, non colgono la ricchezza della vita. Di fronte alla domanda sull’essere, la filosofia appare impotente.Filosofia e Scienza
La vitalità attuale della filosofia deriva dalla sua capacità di confrontarsi con i problemi storici. Dopo il crollo delle grandi costruzioni filosofiche, ci si chiede se la filosofia abbia ancora un ruolo. La scienza, in particolare la logica basata sull’esperienza, ha provato a liquidare la filosofia, riducendo la conoscenza a ciò che può essere verificato. Tuttavia, la scienza stessa si basa su presupposti filosofici che non riesce a risolvere da sola. La filosofia non si trasforma in scienza, ma lascia alle scienze le questioni che possono risolvere, concentrandosi su quei problemi che rimangono aperti al di fuori delle singole discipline scientifiche.Il Nuovo Compito: L’Interpretazione
La differenza fondamentale tra scienza e filosofia non sta nel fatto che una sia più generale o astratta dell’altra, ma nel loro obiettivo principale. La scienza cerca risultati definitivi e certi, mentre la filosofia si dedica all’interpretazione. L’ideale della filosofia è proprio l’interpretazione. Questo non significa cercare significati nascosti o un mondo al di là di quello che vediamo, ma riorganizzare gli elementi della realtà, spesso forniti da altre discipline come la sociologia, in nuove configurazioni. Queste configurazioni rendono la realtà più comprensibile e, così facendo, dissolvono la domanda filosofica iniziale. Questo processo è dinamico e strettamente legato alla prassi, cioè alla possibilità di trasformare la realtà.Il Metodo dell’Interpretazione
Il compito attuale della filosofia richiede di abbandonare le domande tradizionali sull’essere, i concetti generali che pretendono di essere sempre validi e le idee astratte di totalità. La filosofia deve concentrarsi su situazioni storiche concrete e complesse, utilizzando i dati e i materiali che provengono, ad esempio, dalla sociologia. Questo approccio è una vera e propria “arte dell’invenzione” (ars inveniendi), che usa una “fantasia precisa” per creare modelli che descrivano la realtà. La validità di questi modelli si verifica solo nel momento in cui la domanda filosofica che li ha generati scompare, perché ha trovato una sua risposta nella nuova configurazione interpretativa. Questo metodo, che accetta il rischio e l’incertezza del tentativo, può essere visto come una forma di “saggismo” filosofico, capace di entrare nel dettaglio concreto per sciogliere i nodi che riguardano la realtà.Se la filosofia si limita a ‘riorganizzare’ dati altrui, non rischia di perdere la sua autonomia?
Il capitolo propone un compito per la filosofia che la vede lavorare con materiali forniti da altre discipline, come la sociologia. Questa impostazione solleva il dubbio su quale sia il contributo specifico e autonomo del pensiero filosofico, se il suo ruolo principale diventa quello di interpretare dati già elaborati altrove. Per approfondire, sarebbe utile confrontarsi con le discussioni sul rapporto tra filosofia e scienze sociali, esplorando autori che hanno dibattuto i confini e le intersezioni tra questi campi del sapere.3. Superare l’Antitesi: Storia Naturale e Critica Ontologica
Si cerca di superare la tradizionale opposizione tra natura e storia. La natura non è vista come la studiano le scienze, ma come un elemento che sentiamo come destino o qualcosa di immutabile nel cammino umano. La storia, invece, è il continuo cambiamento, il movimento che porta a cose nuove. L’obiettivo è trovare un modo per vedere natura e storia non più come due cose separate e opposte, ma unite in qualche modo. Questo superamento è fondamentale per capire a fondo la realtà.Un tentativo che non funziona del tutto
Un tentativo di superare la separazione viene dall’ontologia moderna, specialmente nella fenomenologia. Questa filosofia cerca di capire l’essere, cioè ciò che esiste veramente, andando oltre il modo in cui lo vediamo noi soggetti. Tuttavia, usa ancora il pensiero e la ragione del soggetto per farlo. Questo crea difficoltà nel capire il significato profondo dell’esistenza e la realtà vera e concreta delle cose. L’ontologia cerca di superare la divisione tra storia e ciò che non è storia, ma finisce per definire l’essere in modo astratto, usando concetti come la ‘storicità’. Questo modo di fare non riesce a cogliere i fatti storici nella loro concretezza. Mantiene idee tipiche dell’idealismo, come credere di poter racchiudere tutta la realtà in uno schema fisso o dare più importanza a ciò che potrebbe essere rispetto a ciò che è realmente. Il risultato sono spiegazioni che si ripetono, dove la storia viene descritta usando solo la sua definizione teorica e astratta, senza afferrare la sua vera essenza.L’idea di storia naturale
L’idea della storia naturale propone un modo diverso: vedere la storia concreta come se fosse natura e la natura come se fosse storia. Questa visione nasce dalla filosofia che riflette sul cammino umano, in particolare dai pensieri di Lukács e Benjamin. Lukács usa l’espressione ‘seconda natura’ per descrivere il mondo sociale che gli uomini costruiscono. Questo mondo, con le sue regole e strutture, può diventare qualcosa di esterno a noi, rigido e difficile da cambiare, quasi come una natura immutabile. Benjamin, invece, trova la storia guardando alla fragilità e al decadimento delle cose naturali, come se la natura stessa mostrasse il passare del tempo e la storia. Per lui, la natura è storia che si manifesta nel suo svanire. In questo contesto, l’allegoria diventa uno strumento utile per trovare un significato nascosto negli aspetti della storia che sono passeggeri e frammentati. La storia, vista attraverso l’allegoria, appare spesso come un percorso pieno di sofferenza.La storia non è un percorso dritto
Guardando la storia in questo modo, non appare come un percorso lineare e continuo. È piuttosto un insieme complesso dove si mescolano l’elemento mitico, che viene dal passato, e le novità che compaiono. L’elemento mitico non è statico o immutabile, ma ha una sua forza e un suo movimento interno. A volte, ciò che è nuovo nella storia può sembrare vecchio o già visto; questo fenomeno è chiamato ‘parvenza’. La parvenza è un esempio perfetto di come storia e natura si uniscano. Anche se all’inizio può sembrare solo un’illusione o qualcosa di superficiale, la parvenza in realtà svela qualcosa di profondo e vero, spesso legato proprio all’elemento mitico. L’essenza della storia naturale sta proprio in questa doppia trasformazione: la storia concreta si trasforma in una natura che cambia e si muove, e allo stesso tempo la natura si rivela come storia in continuo divenire.[/membership]Ma la ‘storia naturale’, con i suoi concetti di ‘seconda natura’, ‘parvenza’ ed ‘elemento mitico’, non rischia forse di cadere nello stesso astrattismo che rimprovera all’ontologia?
Il capitolo critica giustamente l’ontologia per aver definito l’essere in modo astratto, non riuscendo a cogliere i fatti storici nella loro concretezza. Tuttavia, la proposta di “storia naturale”, pur affascinante, introduce concetti che, se non adeguatamente contestualizzati o spiegati nel loro legame con la realtà empirica, possono apparire altrettanto distanti dalla concretezza storica. Per comprendere meglio come questi concetti si traducano in un’analisi concreta della storia e per valutare se superino effettivamente i limiti dell’ontologia criticata, sarebbe utile approfondire le opere di Walter Benjamin e Georg Lukács, i principali riferimenti citati, e confrontarsi con la critica che essi stessi muovono alla filosofia idealista e fenomenologica. Approfondire la filosofia della storia e l’ontologia moderna (ad esempio, studiando autori come Edmund Husserl o Martin Heidegger) può aiutare a cogliere le sfumature della critica mossa nel capitolo.4. La Verità Frantumata nel Linguaggio Storico
Nella visione idealista, il linguaggio filosofico distingue forma e contenuto. Questa idea nasce dal pensiero idealista stesso. Per questa visione, concetti e parole sono solo semplici etichette per molte caratteristiche diverse. L’unità di queste caratteristiche viene creata solo nella mente di chi pensa. Nell’idealismo, i nomi non hanno un legame profondo con le cose che indicano. Sono visti come scelte libere fatte dalla coscienza. Questa possibilità di scambiare i nomi mostra quanto sia casuale l’unione dei concetti, che è costruita solo dal pensiero della persona.Quando le Parole Incontrano la Storia e la Verità
Il linguaggio filosofico che cerca la verità non usa segni scelti a caso. La storia è una parte fondamentale della verità e ‘entra’ nelle parole, rendendole vere. Scegliere le parole giuste dipende da questo legame tra storia e verità. Il filosofo non solo spiega il suo pensiero, ma deve trovare le parole che, in certi momenti precisi della storia, riescono a esprimere il significato che vuole dare. L’idea che il linguaggio filosofico debba essere facile da capire e da usare nella società è un’idea che viene dall’idealismo. Questa idea pensa che il linguaggio sia separato dalle cose e che una cosa possa essere detta in tanti modi diversi. Invece, le cose stesse fanno parte del linguaggio e sono legate a esso dalla storia. Capire il linguaggio non dipende dal renderlo ‘facile’ per la società, ma dal valore intrinseco e reale delle parole. In una società non unita, anche le lingue sono divise. Chiedere che tutti capiscano tutto in modo generico è un errore. L’unico modo vero per capire il linguaggio filosofico è essere fedeli alle cose di cui si parla e usare le parole tenendo conto del loro significato vero nella storia. Cercare di dare un significato alle parole senza considerare la storia porta solo a criticare il linguaggio. Non si può nemmeno provare a inventare una nuova lingua filosofica per non affrontare i problemi legati alla storia delle parole. Le parole usate tradizionalmente, anche se sembrano spezzate, vanno mantenute. E le nuove parole nascono cambiando il modo in cui le parole storiche sono già messe insieme.Il Compito del Filosofo Oggi: Configurare i Frammenti
Oggi il linguaggio filosofico è come un insieme di pezzi sparsi, fatti di parole legate alla storia. La libertà del filosofo sta nel mettere insieme questi pezzi per riuscire a dire la verità. Le parole non sono fisse e non se ne possono creare di nuove dal nulla. Il linguaggio della filosofia deve essere ‘dialettico’, cioè capace di mostrare le tensioni e i cambiamenti. Spesso le parole che abbiamo a disposizione non bastano o hanno perso il loro significato. Provare a dire qualcosa di nuovo usando parole vecchie è un atteggiamento idealista e non rende giustizia a quello che si vuole dire. L’unica strada è mettere insieme le parole giuste attorno alla nuova verità. Non si può semplicemente ‘spiegare’ tutto in modo diretto, come se le parole fossero perfette e complete. Questo modo di ‘configurare’ le parole è come un terzo elemento che lega insieme l’idea e la cosa di cui si parla, in modo che non possano più essere separate.La Critica del Linguaggio e il Ruolo dell’Arte
Oggi, fare critica filosofica significa soprattutto criticare il linguaggio. Si valuta se le parole, nella loro storia, riescono ancora a portare un vero significato. Il punto di riferimento è la ‘dignità estetica’ delle parole, cioè la loro forza e bellezza. Le parole che non hanno forza sono quelle che l’arte critica. L’arte, infatti, riesce a mantenere unite la parola e la cosa che essa indica. Questa critica basata sull’estetica è essenziale per capire veramente le cose. L’arte vera non si perde in idee astratte, ma mostra la realtà delle cose come sono. Quindi, la critica filosofica del linguaggio unisce il mondo dell’arte e quello della conoscenza.Struttura Oggettiva e Struttura Linguistica
Il modo in cui un’opera filosofica è costruita (la sua ‘struttura oggettiva’) deve essere in contrasto, in ‘tensione’, con il modo in cui usa le parole (la sua ‘struttura linguistica’). Un pensiero che usa solo regole logiche astratte per parlare della realtà profonda delle cose (analisi ‘ontologiche’) non è vero. Questo accade perché la realtà profonda non si adatta a queste forme astratte. L’errore di chi pretende di descrivere la realtà profonda con strumenti astratti deve essere mostrato attraverso il linguaggio stesso. Si deve far vedere che le parole usate non sono adatte a esprimere la conoscenza che si vorrebbe raggiungere.Ma come si può stabilire, al di là di un giudizio soggettivo, la “dignità estetica” di una parola e usarla come criterio per la sua verità storica, come suggerisce il capitolo?
Il capitolo propone un legame stretto tra la critica filosofica del linguaggio, la sua “dignità estetica” e il ruolo dell’arte, ma non specifica i criteri oggettivi per valutare tale dignità o come l’arte possa fornire una validazione non soggettiva del legame tra parola e cosa. Per approfondire questo aspetto e comprendere meglio come l’estetica possa informare la verità filosofica del linguaggio, sarebbe utile esplorare le discipline dell’estetica, la filosofia del linguaggio e la filosofia dell’arte. Autori che hanno affrontato il rapporto tra arte, verità e linguaggio, come ad esempio Martin Heidegger, o che hanno criticato approcci puramente estetici o puramente logici al linguaggio, potrebbero offrire prospettive utili.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]