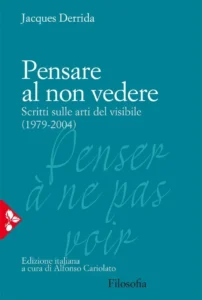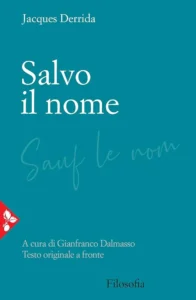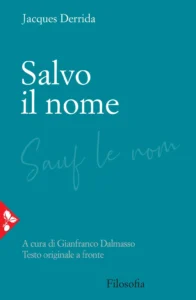1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La voce e il fenomeno” di Jacques Derrida è un libro che ti fa pensare un sacco su come funziona il linguaggio e il significato. Partendo dall’analisi della fenomenologia di Husserl, Derrida scava nella differenza tra due tipi di segno: l’indicazione, che rimanda a fatti empirici, e l’espressione, legata al voler-dire e a un significato ideale. Sembra semplice, ma Derrida mostra subito che nella vita vera, soprattutto nella comunicazione, espressione e indicazione sono sempre mescolate. Per capire l’espressione pura, si guarda al monologo, alla “vita solitaria dell’anima”, dove la voce sembra riferirsi direttamente a idealità senza bisogno di un altro. Ma il punto forte del libro è smontare questa purezza. Derrida introduce concetti come la ripetizione, il supplemento e soprattutto la differanza, per mostrare che la presenza stessa, anche nel pensiero più intimo, non è mai piena o immediata. Il linguaggio, la voce e la scrittura non sono solo strumenti per esprimere un senso che c’è già, ma sono fondamentali per la sua stessa costituzione, legati al tempo e all’assenza. È una sfida alla metafisica tradizionale che privilegia la presenza e l’intuizione, suggerendo che forse la traccia e l’assenza sono più originarie della verità stessa. Un viaggio complesso ma illuminante sul perché le parole significano e cosa significa “essere presenti”.Riassunto Breve
Il segno si presenta in modi diversi, i principali sono l’indice e l’espressione. L’indice punta a qualcosa, come il fumo indica il fuoco, ma non ha un “voler-dire” nel senso di un significato che si vuole comunicare. L’espressione, invece, è legata al linguaggio e porta con sé un “voler-dire”, cioè l’intenzione di comunicare un significato. Nella vita di tutti i giorni, espressione e indicazione sono spesso mescolate, soprattutto quando si parla per comunicare con altri. Per capire l’espressione nella sua forma più pura, si pensa al monologo interiore, dove non c’è bisogno di un interlocutore esterno e il linguaggio sembra riferirsi direttamente a significati ideali, non a cose concrete nel mondo. L’analisi cerca di separare l’espressione dall’indicazione, che viene vista come un fenomeno più esterno e legato ai fatti empirici. L’indicazione funziona come una spinta che porta il pensiero da una conoscenza a un’altra, legando fatti non evidenti e contingenti, a differenza della dimostrazione che lega verità ideali e necessarie. L’indicazione è legata a tutto ciò che nella realtà è messo da parte quando si cerca il significato puro. L’espressione pura, con il suo “voler-dire”, è vista come un’azione volontaria della coscienza che si manifesta in uno spazio interiore ideale, non nel mondo fisico. Tutto ciò che non è questa intenzione esplicita, come i gesti o l’aspetto della voce, rientra nell’indicazione. Nella comunicazione con altri, il linguaggio funziona spesso come indicazione perché il pensiero dell’altro non è presente direttamente ma viene intuito attraverso segni esterni. La pura espressione si trova nel monologo, dove le parole non indicano ma mostrano direttamente significati ideali alla coscienza. Tuttavia, la funzione pura dell’espressione non è comunicare nemmeno a sé stessi nel monologo, ma è legata alla rappresentazione. Un segno funziona solo se può essere ripetuto e riconosciuto come lo stesso, e questa ripetibilità è ideale e implica la rappresentazione. Questa struttura di ripetizione è fondamentale per il significato. L’idealità, intesa come ciò che permane e può essere ripetuto, non esiste nel mondo fisico ma dipende dagli atti di ripetizione. L’essere stesso è legato a questa ripetizione. La possibilità del segno è connessa al rapporto con la non-presenza. La distinzione tra linguaggio reale e immaginato diventa difficile perché ogni segno si basa sulla ripetizione e sulla rappresentazione. La presenza del momento presente non è un punto isolato, ma si lega al passato (ritenzione) e al futuro (protensione), includendo la non-presenza nella sua identità. Questa non-identità della presenza originaria mette in discussione l’idea che il segno sia inutile nel rapporto con sé stessi. La possibilità della ripetizione, come traccia o differenza, è più fondamentale della presenza e la rende possibile. La presenza è pensata a partire dalla ripetizione. La voce, che sembra pura perché si ascolta senza passare per lo spazio esterno, è legata al tempo. La temporalità stessa è un movimento interno che introduce una differenza nella presenza a sé. Il presente nasce differenziandosi da sé, aprendosi all’esterno. L’interiorità della voce non è chiusa ma include l’esterno. Indicazione ed espressione non sono semplicemente aggiunte al senso, ma il loro legame è originario. Sono un “supplemento” che compensa una mancanza di presenza originaria. La supplementarietà è una differenza che divide e ritarda la presenza, legata a una mancanza originale. Ogni segno sta “al posto di” qualcos’altro. La presenza a sé emerge come una sostituzione originale. Il significante non solo rappresenta il significato assente, ma si sostituisce ad altri significanti. L’espressione, nella sua struttura, non richiede la presenza piena dell’oggetto a cui si riferisce. L’assenza dell’oggetto non elimina il “voler-dire”. Un’espressione può avere senso anche senza un oggetto reale. L’originalità del “voler-dire” è proprio la sua capacità di funzionare anche in assenza di un oggetto dato all’intuizione. L’assenza totale di soggetto e oggetto non impedisce a un testo di avere significato; anzi, questa possibilità lo rende possibile. La scrittura, che funziona anche dopo la morte dell’autore, è legata a questa assenza. L’idealizzazione, la ripetizione e il significato sono possibili solo grazie a un’apertura legata alla morte. L’autonomia del “voler-dire” rispetto alla conoscenza intuitiva, la libertà del linguaggio, è legata alla scrittura e al rapporto con la morte. La scrittura non è un’aggiunta alla parola, ma la rende possibile. Tuttavia, il pensiero tradizionale tende a vedere la presenza piena e l’intuizione come il fine ultimo. La differenza tra intenzione e intuizione è vista come temporanea. Il vero “voler-dire” sarebbe il “voler dire-vero”, legato alla conoscenza e alla presenza piena. Ma l’idealità è sempre differita all’infinito. Questa differenza è tra idealità e non-idealità. Le distinzioni tra i tipi di segni sono basate su questo fine ideale e nella realtà non sono mai rispettate, mentre idealmente si annullano. La possibilità di queste distinzioni è sempre rimandata. La presenza stessa è una differenza infinita. La vita del presente è una differenza infinita. L’infinito è pensato come indefinito. L’apparire di questa differenza infinita è finito, legato a un rapporto con la morte. La differenza infinita è finita. Non si pensa più in opposizione tra finito e infinito, assenza e presenza. La storia del pensiero che vede l’essere come presenza e sapere assoluto è chiusa. Questa storia finisce quando l’assoluto si vede come la propria morte. Una voce senza differenza, senza scrittura, è viva e morta allo stesso tempo. Oltre il sapere tradizionale, servono pensieri nuovi. La differenza rimane un concetto vecchio finché si chiede se pensarla dalla presenza o prima di essa. Bisogna pensarla come un’apertura a una domanda che va oltre il sapere. Non si sa più se ciò che è stato considerato secondario, come il segno, la scrittura, la traccia, il supplemento, non sia in realtà più fondamentale della presenza, della verità, della storia, del senso, dell’intuizione originaria. Non si sa più se ciò che è stato visto come un caso particolare non abbia nascosto il legame tra verità e morte. La serie infinita di segni, che si legano l’uno all’altro senza un inizio o una fine chiara, non è un’esperienza eccezionale, ma forse la condizione di base. Non c’è mai stata una percezione pura e originale; la “presentazione” è sempre una rappresentazione di una rappresentazione. La situazione normale è come una galleria di quadri che rappresentano altri quadri all’infinito. Non si esce mai da questo labirinto. Si parla per compensare la mancanza di presenza. La voce è il fenomeno di questo labirinto. La cosa stessa si nasconde sempre. Lo sguardo non può fermarsi.Riassunto Lungo
1. La Doppia Natura del Segno: Indice e Voler-Dire
Il segno si manifesta in due modi principali: come semplice indice e come espressione. Un indice segnala qualcosa, come il fumo indica il fuoco, ma non porta con sé un significato o un senso nel modo in cui lo fa il linguaggio. L’espressione, invece, è legata al linguaggio parlato e porta un “voler-dire”, cioè ciò che chi parla o un discorso intende comunicare. Nella vita di tutti i giorni, l’espressione e l’indicazione sono spesso mescolate, specialmente quando comunichiamo. Tuttavia, questa unione pratica non cancella la differenza fondamentale tra i due. Per capire l’espressione nella sua forma più pura, libera dall’atto di indicare e dal bisogno di comunicare a un altro, possiamo pensare a quando parliamo a noi stessi, come in un monologo. In questo “parlare solitario dell’anima”, l’espressione si lega direttamente a un significato ideale e oggettivo, senza che ci sia un ascoltatore esterno necessario.Il Senso Profondo del Segno
Ci si potrebbe chiedere perché si comincia distinguendo subito l’indice dall’espressione, invece di studiare prima il concetto generale di segno. Questo approccio potrebbe far pensare che si eviti di affrontare la struttura base del “mostrare”, da cui derivano sia l’indicare che il mostrare legato all’espressione. Tuttavia, scegliere di analizzare il segno partendo da questa distinzione potrebbe servire a non intrappolare il segno in un modo di pensare tradizionale, dove il segno è visto solo come qualcosa che rimanda a una verità o a un’essenza che esiste già. Invece, il segno potrebbe essere proprio ciò che contribuisce a creare l’idea stessa di verità o a farci porre la domanda “che cos’è?”. Questo modo di vedere il segno si colloca in un ambito filosofico che esplora come la vita e i segni stessi costruiscono il significato, pur rimanendo aperto a confrontarsi con le idee filosofiche più antiche.Se il segno non si limita a indicare una verità preesistente, ma anzi la “crea”, non si rischia di smarrire ogni riferimento oggettivo, confinando il “senso profondo” in un solipsismo linguistico?
Il capitolo propone una visione del segno che, distaccandosi dall’idea di una semplice indicazione di una realtà o verità data, suggerisce che il segno stesso possa contribuire alla creazione del senso o addirittura della domanda “che cos’è?”. Questa prospettiva, pur stimolante, solleva il dubbio su come sia ancora possibile ancorare il significato a qualcosa di condiviso o “oggettivo”, specialmente quando si fa riferimento a un “parlare solitario dell’anima” che si legherebbe a un significato “ideale e oggettivo”. Se il segno è costitutivo della verità, su quali basi possiamo distinguere un senso “oggettivo” da una mera costruzione soggettiva o arbitraria? Per esplorare queste tensioni, è utile confrontarsi con le discipline della Semiotica e della Filosofia del Linguaggio, approfondendo autori come Saussure, Peirce, Eco, ma anche confrontandosi con le critiche post-strutturaliste (come quelle di Derrida) e le riflessioni sulla natura del significato e della verità in autori come Wittgenstein o Husserl.2. La Separazione dei Segni
Questo capitolo analizza da vicino come usiamo i segni, distinguendo in particolare tra “indicazione” ed “espressione”. L’espressione è considerata l’aspetto centrale, legata a ciò che vogliamo comunicare e a idee che esistono indipendentemente da noi. L’indicazione, invece, viene affrontata in modo più rapido all’inizio. Lo scopo è metterla da parte perché appare come qualcosa di esterno e basato sull’esperienza concreta. Tuttavia, questo tentativo di “ridurre” o accantonare l’indicazione si rivela complicato, dato che nella pratica, indicazione ed espressione sono strettamente connesse nel modo in cui comunichiamo e pensiamo.Come funziona l’indicazione
Un segno indicativo funziona come una “motivazione”. Spinge il nostro pensiero da una conoscenza che abbiamo ora verso qualcosa che non conosciamo ancora o a cui non stiamo pensando in quel momento. Questa spinta può essere una forte convinzione o anche solo una supposizione. È importante notare che questo tipo di motivazione si applica a cose o situazioni in generale, non solo a ciò che esiste fisicamente nel mondo reale in questo istante. Collega concetti o stati di cose, non solo oggetti concreti che possiamo toccare o vedere.Indicazione e Dimostrazione
C’è una differenza fondamentale tra indicare qualcosa e dimostrarla. Una dimostrazione collega verità che sono ideali, necessarie e chiaramente evidenti; sono verità che non dipendono dal contesto specifico o dalla situazione. L’indicazione, al contrario, collega fatti che sono solo possibili o basati sull’esperienza, e non sono necessariamente chiari o evidenti di per sé. Anche quando sembra che l’indicazione sia presente in una dimostrazione, riguarda solo i processi mentali coinvolti, il modo in cui pensiamo le cose, non il contenuto delle verità logiche fondamentali.Indicazione e Realtà
La nostra vita mentale, il modo in cui viviamo le esperienze e agiamo con la mente, crea solo collegamenti basati sull’indicazione, anche quando pensiamo a concetti ideali. Il segno indicativo, l'”indice”, rimane al di fuori del regno della verità ideale e della realtà oggettiva. Questa idea che l’indice sia esterno, derivante da semplici associazioni che facciamo basandoci sull’esperienza, suggerisce la possibilità di metodi filosofici futuri che mirano a concentrarsi puramente sulla coscienza, mettendo da parte il mondo esterno. Ciò che viene “messo tra parentesi” o “ridotto” da questo metodo è esattamente ciò che il significato basato sull’indicazione copre: se qualcosa è un fatto, se esiste nel mondo reale, se non è necessario, o se non è immediatamente chiaro.Il Problema della Riduzione
Le questioni centrali legate a questo metodo filosofico, incluse le differenze tra un semplice fatto e la sua natura essenziale, o tra la nostra coscienza interiore e il mondo esterno, sembrano basarsi su questa distinzione tra i due tipi di segni. Il rapporto tra la nostra pura vita mentale e la nostra coscienza più profonda e fondamentale potrebbe manifestarsi come un rapporto tra questi due modi di dare significato. Tuttavia, c’è uno sforzo per mantenere l’idea di significato separata dall’esperienza diretta di questa coscienza fondamentale. Un modo per capire questo è che il metodo filosofico potrebbe essere strettamente legato all’atto di parlare e di esprimerci, il che sembra contraddire l’idea che il significato esista prima del linguaggio. Anche se gran parte di ciò che diciamo ha un nucleo espressivo, è anche fortemente intrecciato con indicazioni.Data la loro ‘stretta connessione nella pratica’, non è la ‘separazione dei segni’ un’astrazione problematica?
Questa domanda mette in luce la tensione fondamentale del capitolo: come è possibile fondare un metodo filosofico sulla netta separazione o addirittura sulla “riduzione” dell’indicazione, se poi si ammette che questa è “strettamente connessa” all’espressione nella pratica del pensiero e della comunicazione? L’idea di mettere tra parentesi il mondo esterno e i fatti empirici (ciò che l’indicazione copre) per accedere a una pura coscienza o a verità ideali, pur essendo una mossa filosofica storicamente rilevante, appare qui indebolita dalla stessa constatazione dell’intima relazione tra i due tipi di segni. Per approfondire questa problematica e le sue implicazioni, è consigliabile studiare la fenomenologia, in particolare le opere di Husserl, per comprendere a fondo l’operazione di “riduzione” e le sue motivazioni, e confrontarsi con le critiche mosse a tale approccio da altre correnti filosofiche che enfatizzano l’inscindibilità di linguaggio, esperienza e mondo, come certe prospettive della filosofia analitica o della filosofia continentale post-fenomenologica.3. La Voce Interiore del Senso
L’espressione è un segno che possiede un “voler-dire”, un’intenzione precisa dietro le parole. Si distingue dall’indicazione perché non è un semplice fenomeno esterno o involontario, ma un atto consapevole e volontario che manifesta un senso. Questo processo avviene in uno spazio ideale dentro la coscienza, non nel mondo fisico che ci circonda. L’espressione anima una voce che può rimanere del tutto interiore e si riferisce a un’idealità, a qualcosa che esiste nel pensiero piuttosto che fisicamente. Tutto ciò che sfugge a questa intenzione pura, come gesti spontanei, espressioni facciali non cercate o il tono involontario del discorso, rientra nell’ambito dell’indicazione. Questi elementi non hanno un “voler-dire” nel senso stretto dell’espressione linguistica intenzionale. L’essenza del linguaggio, intesa come espressione pura, risiede nella coscienza volontaria che desidera comunicare qualcosa in modo esplicito e deliberato.Comunicazione come indicazione
Nella comunicazione tra le persone, il linguaggio funziona molto spesso come indicazione. Questo accade perché manifestare un vissuto interiore a un altro richiede necessariamente la mediazione fisica di un segno esterno. Il vissuto dell’altro non è presente in modo immediato e diretto alla nostra coscienza. Possiamo coglierlo solo dall’esterno, attraverso i segni che quella persona usa e che sembrano indicare la probabile esistenza del suo stato interiore. Questa non-presenza immediata del vissuto altrui rende la comunicazione, per sua stessa natura, un processo intrinsecamente indicativo, basato sull’interpretazione di segni esterni.La pura espressione interiore
La pura capacità espressiva emerge pienamente solo quando la comunicazione con altri è sospesa, nella “vita solitaria dell’anima” o nel monologo interiore. Qui, il linguaggio non ha bisogno di un corpo fisico o di esistere nel mondo esterno per manifestarsi. Le parole non vengono pronunciate ad alta voce, ma sono rappresentate o immaginate nella mente, e il loro significato è immediatamente presente alla coscienza stessa che le pensa. In questo contesto privato, le parole non servono a indicare l’esistenza di qualcosa nel mondo empirico. Al contrario, “mostrano” direttamente significati ideali, che appaiono certi e presenti all’intuizione interna. L’indicazione, legata all’esistenza nel mondo reale e alla non-presenza immediata delle cose, viene meno completamente in questa sfera di pura interiorità.Ma questa “differenza originaria” e questa “mancanza nella presenza” sono verità autoevidenti o dipendono da un particolare punto di vista filosofico?
Il capitolo presenta concetti affascinanti sulla natura del linguaggio, del tempo e dell’interiorità, ma le affermazioni sulla “mancanza originaria” della presenza a sé e sulla “differenza” intrinseca che fonda il tempo e lo spazio sono posizioni teoriche specifiche, non necessariamente universalmente accettate. Per valutare criticamente queste idee e comprendere il contesto da cui emergono, è fondamentale esplorare le correnti filosofiche che mettono in discussione la nozione di presenza pura e immediata. Approfondire la fenomenologia, in particolare il pensiero di Edmund Husserl sulla coscienza e la temporalità, e successivamente le critiche e le rielaborazioni proposte da autori come Martin Heidegger e Jacques Derrida, può fornire gli strumenti concettuali per comprendere le premesse e le implicazioni di queste argomentazioni, e per confrontarle con altre visioni sulla relazione tra pensiero, linguaggio e realtà.6. Il supplemento e l’assenza originaria
La supplementarietà è come una differenza che separa e ritarda la presenza di qualcosa, legandola a una divisione e a un limite iniziali. Questa differenza va intesa prima ancora di distinguere tra il differire come ritardo nel tempo e il differire come differenza attiva. La differenza supplementare prende il posto della presenza proprio perché questa presenza manca fin dall’inizio. Ogni segno funziona come un “al posto di” qualcosa. La presenza di qualcosa “in sé” nasce proprio da questo movimento di supplementarietà, come una sostituzione che c’è fin dall’origine. Essere “per sé” significa essere un “al posto di sé”.Il Segno e l’Assenza
Il significante, che agisce come un supplemento, non si limita a rappresentare un significato che è assente; si sostituisce anche a un altro significante, mantenendo comunque un legame con la presenza che manca. Ad esempio, un indice sostituisce ciò che indica (qualcosa che esiste) e anche il segno espressivo, il cui significato è un’idea. Nel linguaggio di tutti i giorni, l’espressione funziona come un indice perché l’esperienza vissuta da un’altra persona non è direttamente presente a noi.Espressione, Significato e Oggetto
La struttura stessa dell’espressione implica che non sia mai “piena”. L’atto di voler dire qualcosa crea un legame con l’oggetto di cui si parla, ma non è assolutamente necessario che ci sia un’intuizione immediata che “riempia” questo legame. L’espressione può benissimo fare a meno della presenza completa dell’oggetto che l’intuizione dovrebbe cogliere. L’assenza dell’oggetto non annulla l’intenzione di voler dire. L’intuizione che dovrebbe dare pienezza non è essenziale per l’espressione. Si distingue tra l’espressione, il significato (che è un’unità ideale) e l’oggetto. Espressioni identiche possono avere lo stesso significato ma riferirsi a oggetti diversi. Al contrario, espressioni diverse possono avere significati diversi ma puntare allo stesso oggetto, oppure avere lo stesso significato e lo stesso oggetto.Senso e Non-Senso
Nella logica pura, si distingue tra ciò che è contraddittorio o falso ma ha comunque un senso (come “cerchio quadrato”) e ciò che non ha proprio senso. Un’espressione può avere senso anche se non esiste un oggetto reale o possibile a cui si riferisce. L’assenza di un oggetto non significa che manchi l’intenzione di voler dire. Ciò che non ha senso è invece ciò che non segue le regole grammaticali.L’Originalità dell’Assenza
L’atto di voler dire non solo non richiede l’intuizione, ma la sua natura più profonda è proprio l’assenza di un oggetto dato all’intuizione. L’unione tra intuizione e intenzione non è sempre perfetta. L’assenza dell’intuizione e persino del soggetto che intuisce non è solo accettata dal linguaggio, ma è necessaria per la sua struttura. Anche se non ci sono né soggetto né oggetto presenti, un testo può comunque avere un significato; anzi, è proprio questa possibilità che lo rende possibile.Scrittura, Morte e Significato
La scrittura, che funziona anche quando il soggetto che ha scritto è assente (o morto), è parte integrante del movimento stesso del significato. L’idea di qualcosa che diventa ideale, che può essere ripetuto e che ha un significato, è pensabile solo grazie a un’apertura unica legata all’idea della morte. L’esempio del pronome “Io” mostra che il suo significato ideale funziona anche senza l’intuizione immediata della persona che parla. La possibilità che non ci sia un’intuizione immediata è ciò che rende normale il significato. La morte del soggetto è necessaria, a livello di struttura, perché si possa pronunciare l’io. L’anonimato dell’io scritto è la condizione normale. L’indipendenza dell’intenzione di voler dire rispetto alla conoscenza basata sull’intuizione, ovvero la libertà del linguaggio, trova la sua regola nella scrittura e nel legame con la morte. La scrittura non è qualcosa che si aggiunge alla parola, ma è la scrittura stessa che detta la parola. Questa idea nasce dalla distinzione tra l’intenzione di voler dire (che può funzionare anche “a vuoto”) e il suo eventuale “riempimento” da parte dell’intuizione.Oltre la Presenza: Una Critica
Nonostante queste considerazioni, il pensiero di Husserl tende comunque verso l’idea di una presenza completa e dà molta importanza all’intuizione. L’originalità dell’intenzione di voler dire è limitata dal suo scopo finale, che è la visione completa. La differenza tra intenzione e intuizione è vista come temporanea. Il vero voler dire è il voler dire la verità. La norma è considerata la conoscenza, l’intuizione perfetta, la presenza completa. La grammatica logica pura, nella sua formalità, ha dei limiti perché il concetto di senso è definito in base al suo rapporto con l’oggetto.La Differanza Infinita e la Storia della Metafisica
Concetti come senso, idealità, verità, intuizione e espressione sono tutti legati e radicati nell’idea dell’essere come presenza. Tuttavia, l’idealità viene sempre rinviata all’infinito. Questo rinvio, questa differenza infinita, è la differenza tra ciò che è ideale e ciò che non lo è. Le distinzioni fondamentali (come segno/non-segno, espressione/indicazione) sono definite solo in base a uno scopo finale e, nella pratica, non vengono mai rispettate; a livello ideale, si annullano a vicenda. La possibilità stessa di fare queste distinzioni viene rinviata all’infinito. La presenza è un rinvio all’infinito. La vita del presente che viviamo è un rinvio all’infinito. L’infinità è vista come un’idea senza limiti. L’apparire di questa differenza infinita richiede un legame con la morte. Questo apparire è limitato. La differenza infinita è limitata. Non si pensa più usando le opposizioni come finito/infinito o assenza/presenza. La storia dell’essere inteso come presenza, come sapere assoluto, è giunta al termine. La storia della metafisica è il desiderio di sentirsi parlare in modo assoluto. Questa storia finisce quando l’assoluto si manifesta a sé stesso come la propria morte. Una voce che non ha differenze, che non ha scrittura, è viva e morta allo stesso tempo.Il Labirinto dei Segni
Al di là del sapere assoluto, sono necessari pensieri completamente nuovi. La differenza rimane un vecchio concetto finché ci si chiede se pensarla partendo dalla presenza o prima di essa. Bisogna intenderla come l’apertura a una domanda che va oltre il sapere conosciuto. Non si sa più se ciò che è stato considerato solo un “segno”, una “scrittura”, una “traccia”, un “supplemento”, non sia in realtà più antico della presenza, della verità, della storia, del senso, dell’intuizione originale. Non si sa più se ciò che è stato visto come un elemento secondario non abbia invece nascosto il legame profondo tra verità e morte. La serie infinita di segni che si legano l’uno all’altro, senza un inizio né una fine, non è un caso particolare dell’esperienza, ma forse è la condizione che esiste da sempre. Non c’è mai stata una percezione originale; ciò che chiamiamo “presentazione” è in realtà una rappresentazione di una rappresentazione. La situazione normale è come una “galleria di quadri” che rappresentano altri quadri all’infinito. Non si esce mai da questo labirinto. Si parla per compensare l’assenza della presenza. La voce è il fenomeno di questo labirinto. La cosa in sé si sottrae sempre. Lo sguardo non può mai fermarsi.Se il significato è un labirinto infinito di rinvii e la “presenza” è un’illusione metafisica, come possiamo fondare la comunicazione, la conoscenza o persino la critica stessa senza ricadere nei concetti che si intendono decostruire?
Il capitolo presenta una visione radicale che mette in discussione le basi stesse del significato e della presenza, ma non chiarisce sufficientemente come sia possibile agire o pensare in un mondo dove queste categorie sono decostruite. Per esplorare queste problematiche e confrontare prospettive diverse, è utile approfondire la filosofia del linguaggio (in particolare gli approcci analitici e pragmatici), le teorie della comunicazione e l’epistemologia. Autori come Ludwig Wittgenstein, Charles Sanders Peirce, Jürgen Habermas e Richard Rorty offrono punti di vista alternativi o complementari su come il linguaggio e la conoscenza funzionino al di fuori di una metafisica della presenza.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]