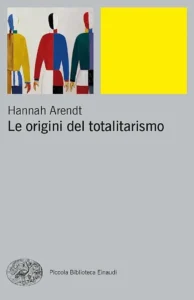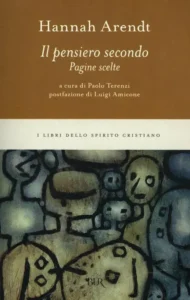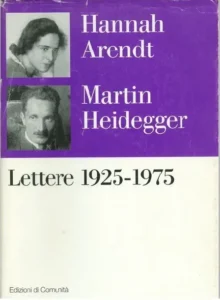Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “La vita della mente” di Hannah Arendt è un viaggio affascinante nel cuore del pensiero umano, esplorando come percepiamo il mondo e noi stessi. Il libro parte dall’idea che tutto ciò che esiste ci appare attraverso i sensi, e che la nostra realtà è legata a questo apparire, a questo essere visti dagli altri. Arendt ci porta a riflettere su come la vita stessa sia un continuo apparire e scomparire, un ciclo che riguarda ogni essere vivente, dall’animale all’uomo. Non si tratta solo di un’analisi del mondo esterno, ma anche di un’immersione profonda nelle attività interiori della mente: il pensare, il volere, il giudicare. Il testo ci mostra come il pensiero, pur essendo invisibile, sia fondamentale per la nostra esistenza, permettendoci di ritirarci dal mondo delle apparenze per riflettere, creando un dialogo interiore che ci definisce. La filosofia, in questo senso, diventa un modo per distanziarsi dalla frenesia quotidiana e cercare un significato più profondo. Arendt confronta il pensiero con la volontà, esplorando come entrambe le facoltà ci guidino nell’affrontare la realtà, una portando alla riflessione e alla serenità, l’altra all’azione e all’inquietudine del futuro. Il libro tocca anche temi di libertà, sia filosofica che politica, analizzando come la nostra capacità di iniziare qualcosa di nuovo, la nostra natalità, sia alla base della nostra libertà. È un’opera che invita a una profonda introspezione, mettendo in discussione le nostre certezze e aprendo nuove prospettive sulla natura della conoscenza e dell’esistenza umana.Riassunto Breve
Il mondo in cui viviamo è fatto di apparenze, di cose che si mostrano ai nostri sensi. Tutto ciò che esiste, per essere reale, ha bisogno di essere percepito da qualcuno. Anche noi stessi siamo apparenze, siamo ciò che gli altri vedono e riconoscono. La nostra stessa coscienza, il pensare di pensare, diventa reale solo quando viene espresso e qualcuno lo ascolta o lo legge. La vita stessa è un continuo apparire e scomparire, un ciclo che segna il tempo. Ogni essere vivente, in un certo senso, è un attore su un palcoscenico, che dipende dal mondo per mostrarsi e dagli altri per essere visto.Il pensiero, però, ci permette di fare un passo indietro da questo mondo di apparenze. Quando pensiamo, ci ritiriamo un po’ dal presente, elaborando ciò che i sensi ci hanno dato. Il pensiero trasforma le esperienze in immagini mentali, permettendoci di ricordare il passato e immaginare il futuro. Questo processo ci porta a vivere in un mondo interiore, un dialogo con noi stessi. La filosofia, in questo senso, è un’attività che si allontana dalle preoccupazioni quotidiane per dedicarsi alla riflessione. Il linguaggio, con le sue metafore, ci aiuta a esprimere questi pensieri astratti, anche se il pensiero più profondo rimane difficile da comunicare completamente.La volontà è un’altra facoltà importante che ci lega al futuro, a ciò che non è ancora. È come un progetto che si forma nella mente, ma che porta con sé incertezza e attesa. La filosofia ha cercato di capire come pensiero e volontà si relazionano. Alcuni pensano che la volontà sia solo un’illusione, mentre altri la vedono come la forza che ci spinge ad agire e a creare il nostro futuro. La storia, vista come un processo in cui l’uomo crea la realtà attraverso il pensiero, lega insieme il passato, il presente e il futuro.La volontà è anche al centro della libertà. La libertà politica, ad esempio, si basa sulla sicurezza e sulla possibilità di agire secondo le leggi, senza essere costretti a fare ciò che non si vuole. Questa libertà si manifesta nella collettività, nel “Noi” che si forma attraverso il consenso e la cooperazione. Le origini delle comunità umane sono spesso avvolte nel mistero, e le leggende di fondazione, come quelle romane o ebraiche, ci mostrano come la libertà sia un processo che richiede un inizio, una liberazione e la creazione di un nuovo ordine. La capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo, legata alla nostra nascita come esseri umani, è fondamentale per la libertà. La facoltà di giudizio ci aiuta a gestire questa libertà e la responsabilità che ne deriva.Riassunto Lungo
1. L’Essere e l’Apparire nel Mondo
La Realtà Fondata sull’Apparenza
Tutto ciò che esiste, sia in natura che come creazione umana, si manifesta ai nostri sensi, diventando così un’apparenza. Questa possibilità di apparire è legata alla presenza di esseri in grado di percepirla, suggerendo che l’esistenza e l’apparire siano strettamente connesse. Perché qualcosa esista nel mondo, è necessario che sia percepito da qualcuno.Gli Esseri Viventi: Soggetti e Oggetti di Apparenza
Anche gli esseri viventi sono parte di questo gioco di apparenze. Non sono solo chi percepisce, ma anche ciò che viene percepito. La loro esistenza è confermata dagli altri esseri che li osservano. Persino la consapevolezza di sé, il “pensare di pensare”, non basta da sola a garantire la realtà; il pensiero deve essere espresso per diventare manifesto, e questo richiede sempre qualcuno che lo ascolti o lo legga.Il Mondo come Palcoscenico di Apparenze
Il mondo è un’infinita successione di apparenze che attirano la nostra attenzione. Ogni specie animale vive nel proprio universo percettivo, ma tutte condividono il ciclo di apparire e scomparire, un processo che precede la nascita e continua oltre la morte. La vita stessa è scandita da questo continuo manifestarsi e ritirarsi.L’Impulso all’Autoesibizione e la Dipendenza dal Mondo
Gli esseri viventi mostrano un desiderio innato di mostrarsi, come attori su un palcoscenico. Ogni essere ha bisogno del mondo per poter apparire, dei suoi simili per interpretare il proprio ruolo e degli spettatori per essere riconosciuto. Questo ciclo di apparizione, crescita e scomparsa definisce l’esistenza.Il Ritiro nel Pensiero e il Legame con le Apparenze
Le attività legate allo spirito, come il pensiero, implicano un allontanamento dal mondo visibile e un ripiegamento verso l’interiorità. Tuttavia, anche in questi momenti, si rimane comunque parte del mondo delle apparenze. Il pensiero, per prendere forma, utilizza metafore che servono a collegare l’esperienza dei sensi con la sfera mentale.La Ricerca Oltre le Apparenze: Scienza e Filosofia
Spesso, filosofia e scienza hanno cercato di superare le apparenze, ipotizzando un’altra realtà, un “vero essere” nascosto dietro ciò che vediamo. Ma anche questa ricerca si basa sull’idea di un’altra forma di apparenza, di un fenomeno più profondo ma sempre di natura apparente. La scienza, con i suoi strumenti, cerca di scoprire ciò che si nasconde sotto la superficie, ma per farlo si affida comunque alle apparenze.Il Senso Comune e l’Accettazione delle Apparenze
Il senso comune, al contrario, accetta le apparenze per come si presentano, pur riconoscendo che possono esserci errori o illusioni. La scienza moderna, con la sua idea di un progresso senza fine, continua a muoversi all’interno dell’esperienza del senso comune, correggendo gli errori e le percezioni errate.La Biologia e l’Importanza delle Apparenze Esterne
La biologia, in particolare attraverso gli studi di Adolf Portmann, suggerisce che le manifestazioni esterne degli esseri viventi non servano solo al loro funzionamento, ma che sia il funzionamento a essere al servizio delle apparenze. L’impulso a mostrarsi, presente in molti animali, raggiunge il suo apice nell’essere umano, che sceglie attivamente come presentarsi al mondo.Verità e Significato: Due Percorsi Distinti
È fondamentale distinguere tra verità e significato. La conoscenza punta alla verità, basandosi su prove concrete e sul ragionamento logico. Il pensiero, invece, cerca il significato, ponendo domande a cui la scienza non può dare risposta. La ragione, come capacità di riflessione, è necessaria per la conoscenza, ma non è conoscenza essa stessa.La Comunità dei Sensi e il Riconoscimento Reciproco
La realtà, nel contesto delle apparenze, è assicurata dalla condivisione delle percezioni sensoriali, da un contesto comune e dal riconoscimento reciproco tra gli individui. Il senso comune agisce come un “sesto senso” che unisce le percezioni dei cinque sensi, facendoci sentire a nostro agio nel mondo.Il Pensiero e la Garanzia della Realtà
Il pensiero, pur essendo invisibile, è essenziale per la nostra esistenza. Tuttavia, non garantisce di per sé la realtà del mondo o la nostra. Il dubbio sollevato da Cartesio, partendo dalla riflessione sul pensiero, ha messo in discussione la realtà, ma è la condivisione e il riconoscimento tra le persone a confermarla.La Scienza, il Senso Comune e il Progresso Continuo
La scienza, anche quando smonta le apparenze che percepiamo, rimane legata al senso comune. Il suo progresso consiste in un continuo processo di correzione, un inseguimento di verità che sono sempre provvisorie. Il pensiero, invece, si dedica alla ricerca del significato, ponendo domande che vanno oltre la semplice conoscenza.La Ragione e la Ricerca del Significato
La ragione, nel suo interrogare il significato delle cose, è vitale per la civiltà, anche se le domande che pone non hanno risposte definitive. La sua funzione è quella di stimolare la riflessione e la comprensione più profonda.La Verità come Necessità e il Pensiero come Attività Autonoma
La verità è ciò che siamo obbligati ad accettare, sia per come funziona il nostro cervello sia per come percepiamo il mondo. Il pensiero, al contrario, è un’attività che si autoalimenta, senza produrre risultati concreti come la conoscenza. Distinguere tra verità e significato, tra il conoscere e il pensare, è fondamentale per capire la natura umana.Se l’esistenza è intrinsecamente legata alla percezione altrui, come possiamo affermare l’esistenza di concetti astratti o entità non direttamente percepibili dai sensi, e quale fondamento logico ha l’idea che il funzionamento sia al servizio delle apparenze, anziché il contrario?
Il capitolo sembra proporre una visione in cui la realtà è interamente mediata dall’apparenza e dalla percezione, sollevando interrogativi sulla natura di ciò che non è immediatamente sensoriale. L’affermazione che il funzionamento sia subordinato alle apparenze, citando la biologia e Adolf Portmann, potrebbe beneficiare di un’ulteriore contestualizzazione e di un’esplorazione più approfondita delle implicazioni evolutive e funzionali. Per approfondire la questione della percezione e della realtà, sarebbe utile consultare le opere di filosofi come Immanuel Kant, in particolare la sua “Critica della ragion pura”, per comprendere meglio i limiti della conoscenza sensoriale. Per quanto riguarda la relazione tra funzionamento e apparenza in biologia, un’analisi delle teorie sull’espressione genica e sull’evoluzione delle caratteristiche fenotipiche potrebbe fornire prospettive utili, magari esplorando il lavoro di biologi evoluzionisti che si sono occupati di ornamenti e segnali negli animali. La distinzione tra verità e significato, inoltre, potrebbe essere ulteriormente illuminata dalla lettura di testi sulla filosofia del linguaggio e sull’epistemologia.Il Ritiro della Mente dal Mondo delle Apparenze
Le attività della mente, come il pensare, il volere e il giudicare, sono autonome. Nascono da un “bisogno della ragione” che le fa esistere. Queste attività, pur essendo fondamentali, sono invisibili e si manifestano solo attraverso il pensiero. Il pensiero, per potersi realizzare pienamente, si ritira dal mondo delle apparenze. Questo ritiro non significa una fuga dalla realtà, ma un distacco dalla sua presenza immediata ai sensi. In questo modo, la mente può avere presente ciò che in realtà è assente.La Trasformazione della Realtà attraverso il Pensiero
Il pensiero agisce trasformando gli oggetti che riceviamo dai sensi in immagini mentali. In pratica, li “desensibilizza”, permettendo di maneggiarli anche quando non sono più percepibili direttamente. Questo processo, che inizia con l’immaginazione e la memoria, ci consente di costruire un passato e di anticipare un futuro, andando oltre la semplice percezione del momento presente. Il pensiero, quindi, non si accontenta della realtà così come ci viene data, ma la supera, trasformandola in un’esperienza in cui l’io si confronta con se stesso.La Natura Riflessiva e Continua del Pensiero
La vita della mente è caratterizzata dalla solitudine e dalla riflessione, un dialogo interiore che è ben diverso dalla desolazione. Questa natura riflessiva si ritrova in ogni atto spirituale, che in qualche modo si ripercuote su se stesso. Il pensiero, in particolare, è un’attività che non si esaurisce nel suo risultato finale, ma si rinnova continuamente, simile alla tela di Penelope che viene tessuta e disfacciuta.Filosofia e Senso Comune: Un Distacco Incompreso
La filosofia, in questo senso, è un’attività che si allontana dal mondo delle apparenze e dalle preoccupazioni quotidiane. Questo distacco, però, non è sempre facile da comprendere per il senso comune, che tende a interpretarlo come una forma di morte o di estraneità. La storia della filosofia mostra una costante tensione tra il pensiero speculativo e il senso comune. Questa “guerra intestina” spinge i filosofi a reinterpretare le proprie attività per renderle più accettabili agli occhi di tutti.Il Ruolo del Linguaggio nella Comunicazione del Pensiero
Il linguaggio, in questo contesto, assume un ruolo fondamentale. Essendo il mezzo attraverso cui le attività della mente si manifestano, è intrinsecamente metaforico. Le metafore, che derivano dai sensi, aiutano il pensiero a colmare la distanza tra ciò che è invisibile e il mondo delle apparenze. Questo rende possibile la comunicazione di concetti astratti. Tuttavia, il linguaggio stesso presenta dei limiti, perché il pensiero nella sua essenza rimane inesprimibile e sfugge a una completa espressione verbale.L’Eredità della Filosofia Greca e Romana
La filosofia greca ha posto le basi per questa comprensione del pensiero, identificandolo con la contemplazione e la ricerca dell’immortalità attraverso la vicinanza al divino. Questa prospettiva, però, è stata in parte modificata dall’eredità romana. I romani hanno spostato l’attenzione sulla filosofia come “scienza” e “medicina dell’anima”, con l’obiettivo di rendere l’uomo indifferente al mondo reale. In questa visione, il pensiero diventa uno strumento per sfuggire alla sofferenza e alla disgregazione della realtà, trovando rifugio in un mondo interiore fatto di impressioni e immagini.Se il pensiero si ritira dalle apparenze per “avere presente ciò che in realtà è assente”, non si configura questo come una forma di auto-inganno o di fuga dalla realtà concreta, piuttosto che un suo superamento?
Il capitolo descrive il ritiro della mente come un processo necessario per la trasformazione della realtà attraverso il pensiero, distinguendolo da una fuga. Tuttavia, l’affermazione che la mente possa “avere presente ciò che in realtà è assente” solleva interrogativi sulla validità e sulla natura di questa “presenza” mentale, soprattutto in relazione al mondo delle apparenze da cui si è ritirata. Per approfondire questa dicotomia tra ritiro e fuga, e per comprendere meglio la natura della “realtà” mentale rispetto a quella sensoriale, potrebbe essere utile esplorare le opere di filosofi che hanno indagato la natura della percezione e della coscienza, come ad esempio Platone con il suo mito della caverna, o autori che hanno analizzato i meccanismi della mente e della sua relazione con il mondo esterno, come Kant o Husserl.Il Pensiero e la Volontà: Due Modi di Affrontare la Realtà
Il Pensiero e il suo Distacco dalla Realtà
Il pensiero ci porta a riflettere su ciò che non è presente, allontanandoci dal mondo concreto e facendoci perdere il senso delle cose reali. Questa attività, svolgendosi “fuori dall’ordine” della vita quotidiana, ci isola e interrompe il nostro fluire naturale. Un esempio di questo isolamento è Socrate, che nel suo immergersi nei pensieri diventava completamente sordo a tutto ciò che lo circondava. Il pensiero agisce come un vento invisibile che muove le cose senza mostrarsi, portandoci a vivere in un “non-luogo”, quasi senza una patria, distaccandoci dal nostro corpo e da noi stessi.La Volontà e l’Inquietudine del Futuro
La volontà, al contrario, è orientata verso il futuro, verso ciò che ancora non esiste. Si manifesta come un progetto nella mente, privo di garanzie di realizzazione. Questo ci porta a vivere in uno stato di attesa, speranza e paura, generando un’inquietudine che ci allontana dalla serenità. La volontà è la forza che ci spinge ad agire e a plasmare il nostro futuro, rendendola fondamentale per dare forma alla nostra esistenza.La Filosofia e il Dibattito tra Pensiero e Volontà
La filosofia ha da sempre cercato di comprendere il legame tra pensiero e volontà. Alcuni pensatori, come Hobbes e Spinoza, hanno messo in dubbio la libertà della volontà, considerandola una semplice illusione. Altri, invece, hanno attribuito alla volontà un ruolo centrale, vedendola come il motore delle nostre azioni e della creazione del nostro futuro.La Prospettiva Hegeliana sul Tempo e la Volontà
Hegel, in particolare, ha considerato il futuro come la dimensione temporale più importante, quella che conferisce significato al passato e al presente. Per lui, l’essere umano è l’artefice del tempo, e la sua esistenza si configura come un continuo progetto di futuro. In questa visione, la volontà assume un’importanza cruciale nel definire il corso della nostra vita e il nostro destino.Se la volontà è intrinsecamente libera e capace di scegliere contro la ragione, come possiamo conciliare questa “contingenza” con la ricerca della felicità, sia essa intellettuale o esistenziale, senza cadere in un relativismo nichilista o in una paralisi decisionale?
Il capitolo presenta un’interessante evoluzione del concetto di volontà, ma la transizione da Tommaso d’Aquino a Nietzsche e Heidegger, pur evidenziando una crescente enfasi sulla libertà e sull’autodeterminazione della volontà, lascia aperte questioni cruciali. In particolare, la “libertà” attribuita alla volontà da Duns Scoto, che include la capacità di scegliere anche contro la ragione, solleva interrogativi sulla sua effettiva compatibilità con un ordine razionale o con la ricerca di un bene superiore. L’introduzione della “volontà di potenza” e della “volontà di non volontà” da parte di pensatori successivi complica ulteriormente il quadro, suggerendo dinamiche che possono essere sia creative che distruttive. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire le implicazioni etiche e psicologiche di una volontà disancorata dalla ragione, esplorando discipline come la psicologia morale e la filosofia esistenzialista. Letture specifiche di pensatori come Søren Kierkegaard, che affronta il tema dell’angoscia e della scelta in un contesto di incertezza, potrebbero offrire spunti preziosi per comprendere come gestire la libertà della volontà senza soccombere alla sua potenziale irrazionalità.Libertà: Filosofica e Politica, un Confronto
La Libertà come Volontà e Sicurezza
La libertà filosofica si fonda sull’esercizio della volontà, mentre la libertà politica si basa sulla sicurezza. Per garantire quest’ultima, è necessario un governo che impedisca ai cittadini di nuocersi a vicenda. La libertà filosofica, legata alla volontà del singolo, è più adatta a chi vive al di fuori della società. La libertà politica, invece, nasce e si mantiene all’interno delle comunità attraverso le leggi. Queste leggi, pur limitando la volontà individuale, lasciano comunque uno spazio di azione. In sostanza, la libertà politica si configura come la possibilità di agire secondo il proprio desiderio, senza essere costretti a fare ciò che non si vuole.Potere e Pluralità nella Libertà Politica
Per gli antichi e per pensatori come Montesquieu, “potere” e “libertà” erano quasi sinonimi, indicando la capacità di agire senza ostacoli. La libertà politica, a differenza di quella filosofica, è un attributo del cittadino e si manifesta nella pluralità umana, dove le interazioni sono regolate da leggi e consuetudini. La vera libertà politica non è un dialogo interiore, ma l’azione collettiva di un “Noi”. Questo “Noi” si forma attraverso il consenso e la cooperazione. Chi agisce da solo, per arroganza o disperazione, rischia di diventare un tiranno o un criminale, usando la violenza al posto del potere. Il potere politico, e di conseguenza la libertà politica, sono sempre limitati.Principi Fondanti e Mistero dell’Origine
Le diverse forme di governo si basano su principi ispiratori differenti, come la virtù nelle repubbliche o l’onore nelle monarchie. Tuttavia, la diversità umana rende queste classificazioni generali insufficienti. L’origine di ogni comunità umana è avvolta nel mistero, un “In principio” che le scoperte scientifiche non riescono a chiarire completamente. Di fronte a questa difficoltà, le leggende di fondazione, come quelle romane ed ebraiche, offrono un modello. Queste storie, pur nella loro diversità, mettono in risalto l’amore per la libertà come principio fondante. L’Esodo biblico e le peregrinazioni di Enea, iniziando con una liberazione, mirano a stabilire una nuova forma di libertà.Lo “Iato” tra Liberazione e Nuova Libertà
Queste leggende evidenziano uno “iato” tra la catastrofe e la salvezza, tra la liberazione e la nuova libertà. Questo dimostra che la libertà non è un risultato automatico. La storia americana, con la sua fondazione attraverso esuli diventati colonizzatori, riflette questo schema, trasformando il verso virgiliano “Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo” in “Novus Ordo Seclorum”. La ricerca di un “nuovo ordine” porta a ripensare le leggende di fondazione per risolvere il problema dell’inizio, riconoscendo la natura arbitraria di ogni nuovo inizio. L’uomo d’azione si trova di fronte all’abisso della libertà, consapevole che ogni scelta è definitiva.Soluzioni Ebraiche e Illuministe all’Inizio
La soluzione ebraica a questo problema si basa su un Dio Creatore che crea il tempo insieme all’universo, rimanendo al di fuori di esso. Questo concetto di eternità offre una spiegazione per l’inesplicabile. Molti pensatori illuministi, pur non credendo più in un Dio creatore, hanno utilizzato un linguaggio pseudoreligioso per spiegare la fondazione di un “nuovo ordine dei tempi”, in modo analogo al Dio che crea dal nulla. I Romani, pur senza un concetto di Dio Creatore, riconoscevano la necessità di un principio ultramondano per la fondazione delle comunità, considerando i fondatori come uomini divini. La tradizione romana, in particolare attraverso Virgilio, suggerisce che la fondazione di Roma non fu un inizio assoluto, ma una rinascita di Troia, un ciclo di rinascimenti che caratterizza la cultura occidentale.Illusioni di Fondazione e la Speranza di un “Nuovo Ordine”
La speranza di fondare una “nuova Roma” si rivela un’illusione; al massimo si può aspirare a rifondare “Roma di nuovo”. Ciò che precede questa fondazione si colloca fuori dalla storia, nella natura, la cui eternità ciclica offre un rifugio dal tempo storico. L’idea che il futuro possa riportare un’Età dell’Oro, come nella visione marxista del “regno della libertà”, ricorda il mito antico del regno di Saturno. La ricerca di un’idea di libertà immune dalle riflessioni dell’io si è scontrata con la tendenza occidentale a interpretare il nuovo come perfezionamento dell’antico. La vera libertà è sopravvissuta solo nelle promesse utopiche di un regno definitivo.La Natalità come Fondamento della Libertà
L’alternativa è stata la capacità umana di dare inizio a qualcosa di nuovo, radicata nella natalità, nel fatto che gli esseri umani appaiono sempre come novità nel mondo. La facoltà del giudizio diventa cruciale per gestire la libertà e la sua responsabilità.Se la libertà politica si fonda sulla sicurezza garantita da leggi che limitano la volontà individuale, e la libertà filosofica sulla volontà del singolo al di fuori della società, come si concilia l’idea di un “Noi” che agisce collettivamente per la libertà politica con la potenziale tirannia o criminalità di chi agisce da solo per “arroganza o disperazione”, quando entrambe le sfere sembrano derivare da un impulso individuale, seppur con esiti diversi?
Il capitolo presenta una distinzione netta tra libertà filosofica (volontà individuale) e libertà politica (sicurezza collettiva tramite leggi), ma la transizione tra queste due sfere, specialmente nel passaggio dal singolo al “Noi” e nella potenziale degenerazione dell’azione individuale in tirannia o criminalità, appare poco argomentata. Manca una spiegazione approfondita di come il singolo, agendo per volontà, possa evolvere in un membro di un “Noi” che opera per la sicurezza comune, o come la stessa volontà, se non incanalata correttamente, porti alla violenza invece che alla libertà. Per colmare queste lacune, sarebbe utile esplorare le teorie del contratto sociale e le riflessioni sulla natura umana e la sua socializzazione. Autori come Thomas Hobbes, con il suo Leviatano, e Jean-Jacques Rousseau, con il suo Contratto Sociale, offrono prospettive fondamentali per comprendere il passaggio dallo stato di natura alla società civile e le implicazioni per la libertà e la sicurezza. Inoltre, approfondire il pensiero di Hannah Arendt sulla natalità e l’azione politica potrebbe fornire ulteriori strumenti per analizzare la creazione del “Noi” e la responsabilità individuale nell’ambito politico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]