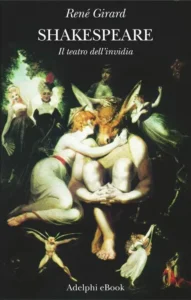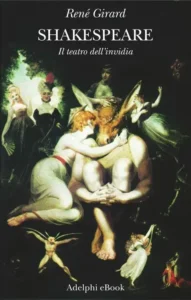1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La violenza e il sacro” di René Girard ti sbatte in faccia un’idea pazzesca: l’ordine sociale e persino il sacro nascono dalla violenza. Non è solo un problema, ma la radice di tutto. Girard spiega come il desiderio mimetico, cioè l’imitare gli altri, porti a una rivalità che può far esplodere una crisi sacrificale, dove le differenze si annullano e la violenza reciproca minaccia di distruggere la comunità. Ma c’è un meccanismo per fermarla: il capro espiatorio. La violenza diffusa si concentra su una vittima espiatoria, spesso un emarginato, e l’unanimità contro di lei ristabilisce la pace. Questo atto fondatore, questo sacrificio rituale originario, è l’origine dei miti, dei riti e delle prime forme di legge, creando l’ordine sociale. Analizzando tragedie greche come le Baccanti o il mito di Edipo, Girard mostra come la violenza mimetica e il meccanismo della vittima siano nascosti dietro le storie che pensavamo di conoscere. È un viaggio affascinante nelle origini violente della cultura umana, che ti fa vedere il sacro e l’ordine da una prospettiva completamente nuova, legata indissolubilmente alla gestione della violenza.Riassunto Breve
La violenza interna minaccia costantemente le comunità umane, soprattutto quando le normali differenze sociali e culturali si indeboliscono o si annullano, creando una “crisi delle differenze” caratterizzata da violenza reciproca e contagiosa. Questa situazione rischia di distruggere l’ordine sociale. Per contrastare questa minaccia, le società sviluppano meccanismi per gestire la violenza. Uno di questi è il sacrificio rituale, che devia la violenza interna verso una vittima designata, spesso marginale, che non può innescare una catena di vendette. Un meccanismo ancora più fondamentale è quello del “capro espiatorio”: quando la violenza reciproca raggiunge il culmine, la comunità si unisce contro un singolo individuo. Questa unanimità violenta contro la vittima designata pone fine al conflitto interno e ristabilisce l’ordine. La vittima, percepita inizialmente come la causa del caos, viene poi associata alla pace ritrovata e diventa il fondamento del sacro. Questo atto violento originario è all’origine dei miti, dei riti e delle prime forme di organizzazione sociale e culturale. I riti sacrificali, le feste e persino il sistema giudiziario, che monopolizza la rappresaglia per interrompere il ciclo della vendetta, ripetono o derivano da questa dinamica. Il desiderio umano è spesso mimetico, imita il desiderio degli altri, generando rivalità che possono sfociare in violenza e contribuire alla perdita delle differenze. Miti e riti tendono a mascherare questa origine violenta, attribuendola a forze esterne o divine, mentre la tragedia a volte la rivela più direttamente. L’ordine culturale, comprese le regole e i divieti come quelli sull’incesto, nasce da questa violenza collettiva che crea unità e distinzioni necessarie. Il pensiero moderno spesso non riconosce o evita di confrontarsi con questa origine violenta, ma il sacro conserva la memoria di questo evento fondamentale che ha reso possibile l’esistenza stessa della società e che richiede una gestione continua per evitare il ritorno del caos.Riassunto Lungo
1. Sacrificio e l’Ordine Contro la Violenza
Il sacrificio rituale appare con caratteristiche opposte: è visto sia come sacro che come proibito. Le spiegazioni tradizionali, come il concetto di ambivalenza o il ruolo della divinità, non chiariscono veramente la sua funzione profonda. Una prospettiva diversa suggerisce invece che il sacrificio sia un modo per controllare la violenza. La violenza, per sua natura, cerca sempre un bersaglio su cui sfogarsi e può facilmente spostarsi su altre vittime se l’obiettivo iniziale non è raggiungibile. Il rito del sacrificio sfrutta proprio questa tendenza, deviando la violenza che potrebbe colpire i membri della comunità verso una vittima “sacrificabile”. Questa vittima, che sia un animale o una persona ai margini della società, viene scelta perché non può essere vendicata. Nelle società dove manca un forte sistema di giustizia, la violenza interna, specialmente le faide familiari basate sulla vendetta, è una minaccia costante che rischia di distruggere l’intera comunità. Il sacrificio funziona quindi come una difesa, concentrando le tensioni e i conflitti interni sulla vittima designata. Offre uno sfogo parziale alla violenza, che però può essere ripetuto, aiutando così a mantenere l’armonia sociale.Il Sistema di Giustizia e la Crisi dell’Ordine
Anche il sistema giudiziario moderno ha una funzione simile a quella del sacrificio: blocca il ciclo infinito della vendetta. Lo fa prendendo per sé il diritto di punire e presentandosi come una giustizia imparziale. Sia il sacrificio che la giustizia tendono a nascondere il loro legame con la violenza e la vendetta. Creano una differenza netta tra una violenza considerata legittima (quella del rito o della legge) e una violenza illegittima. Quando questa differenza si perde o si indebolisce, si parla di “crisi sacrificale” o “crisi delle differenze”. In questa situazione, le distinzioni tra le persone e i gruppi sociali, che danno struttura alla comunità e identità agli individui, scompaiono nella violenza reciproca. Questa mancanza di differenze alimenta ancora di più la violenza. Fenomeni come l’impurità legata ai riti, i divieti legati al sangue (incluso quello mestruale) e la paura per i gemelli o per le somiglianze strette tra parenti mostrano il terrore profondo per questa violenza che non distingue più, che è contagiosa e che minaccia l’ordine della società.Ma davvero il sacrificio rituale, in ogni sua forma e tempo, si riduce a un mero meccanismo di controllo della violenza, e la giustizia moderna ne è solo una versione aggiornata?
Il capitolo presenta una tesi potente e suggestiva sulla funzione del sacrificio e del sistema giudiziario, ma la sua enfasi quasi esclusiva sul controllo della violenza come motore principale potrebbe apparire riduttiva. Esistono altre interpretazioni antropologiche del sacrificio che ne sottolineano le funzioni sociali, religiose o economiche, non sempre primariamente legate alla deviazione della violenza. Inoltre, l’analogia tra un rito arcaico e un complesso sistema legale moderno, pur illuminante, meriterebbe forse una maggiore contestualizzazione storica e filosofica. Per approfondire queste sfumature e confrontare diverse prospettive, sarebbe utile esplorare gli studi di antropologia del rito e della violenza, le teorie sociologiche sul diritto e l’ordine sociale, e confrontarsi con autori che hanno analizzato il sacrificio da angolazioni diverse, come ad esempio Durkheim o Mauss, oltre ovviamente a chi ha sviluppato la teoria presentata nel capitolo (come Girard).2. La Violenza Fondatrice e il Meccanismo del Capro Espiatorio
Miti e tragedie spesso raccontano di rivalità intense tra persone molto vicine, come i “fratelli nemici” o figure parenti in conflitto, tipo Edipo e Laio. Questa forte competizione segnala una “crisi sacrificale”, un momento in cui le differenze normali tra le persone scompaiono e la violenza si diffonde senza controllo. Mentre i miti tendono a nascondere questa violenza generale, le tragedie la mostrano in modo più diretto.La crisi di violenza e la perdita delle differenze
Prendiamo il mito di Edipo e la peste che colpisce Tebe. L’accusa che Edipo abbia ucciso suo padre e commesso incesto, o la peste che si diffonde ovunque, non sono la causa della crisi, ma sintomi evidenti di come la violenza abbia cancellato le normali distinzioni sociali e familiari. Le tragedie mettono in luce che la rabbia e la colpa non sono solo di Edipo, ma sono sentimenti reciproci che coinvolgono tutti i personaggi.Il meccanismo del capro espiatorio
Questa violenza reciproca raggiunge il suo culmine quando l’intera comunità si unisce contro una sola persona. Questo meccanismo, chiamato “del capro espiatorio”, serve a reindirizzare tutta la violenza diffusa su un’unica vittima. Il fatto che tutti si schierino contro la vittima mette fine alla violenza che si era diffusa tra tutti e ripristina l’ordine. La vittima, che prima era vista come la causa di tutti i mali, dopo essere stata allontanata o uccisa, viene associata al ritorno della pace e alla salvezza della comunità.Origine di miti e rituali
Questo meccanismo fondatore è alla base della nascita di miti e rituali. Molte pratiche sacrificali, che prevedono l’uccisione di esseri umani o animali (come il pharmakos greco o i sacrifici dei Dinka), e le feste che includono momenti di trasgressione seguiti da espulsioni, riproducono in qualche modo l’uccisione collettiva originaria. Anche alcune monarchie sacre africane, con i loro re accusati di incesto e i rituali che simboleggiano la loro morte, riflettono questo schema. In questi contesti, l’incesto non è il problema iniziale, ma un tema che emerge perché la vittima scelta per placare la crisi viene accusata di distruggere le distinzioni fondamentali all’interno della famiglia.La verità nascosta
La verità profonda che si nasconde dietro miti e rituali non è il desiderio sessuale, ma il grande terrore provocato da una violenza senza limiti e il modo in cui, concentrando questa violenza su una sola vittima, la società riesce a sopravvivere e a darsi un ordine. L’organizzazione della cultura e della società nasce da questa violenza unanime, un evento che poi viene dimenticato o trasformato in racconto o rito.Quanto è universalmente accettata questa spiegazione dell’origine della cultura?
Il capitolo presenta il meccanismo del capro espiatorio come la base fondante di miti, rituali e dell’organizzazione sociale. Tuttavia, questa prospettiva, sebbene influente, è oggetto di dibattito nel mondo accademico e non rappresenta l’unica teoria sull’origine della cultura e delle istituzioni sociali. Per comprendere meglio le diverse posizioni e i limiti di questo approccio, sarebbe utile esplorare le critiche mosse a questa teoria e confrontarla con altre spiegazioni proposte in ambiti come l’antropologia, la sociologia e gli studi religiosi. Approfondire il pensiero di autori che hanno studiato le origini sociali e culturali da prospettive diverse può fornire un quadro più completo.3. Il Segreto Violento del Rito
La violenza rituale, come si vede negli esorcismi, rappresenta l’atto finale di uno scontro violento tra persone. Dopo essersi affrontati, i partecipanti uniscono le forze contro un bersaglio comune, come se colpissero “nel vuoto”. Questo sistema, basato sulla figura della vittima espiatoria, crea un accordo generale che impedisce alla violenza di riaccendersi tra i membri del gruppo. Il rito serve a fissare e rafforzare questa unità contro una minaccia esterna, spesso identificata con “spiriti malvagi”. La religione celebra questo momento in cui la violenza viene risolta, considerandolo importante da ricordare e ripetere per evitare nuove esplosioni distruttive.Quando la festa diventa violenza
Quando le feste perdono i loro legami con i riti e non fanno più riferimento alla vittima espiatoria, smettono di essere un freno alla violenza. Anzi, possono trasformarsi in nuove crisi, tornando alle loro origini violente. Ad esempio, le feste dei Kaingang mostrano come le riunioni di gruppo possano degenerare in liti e omicidi, diventando in questo modo complici delle forze distruttive anziché contrastarle.L’esempio delle Baccanti di Euripide
La tragedia “Le Baccanti” di Euripide offre un chiaro esempio di questa dinamica. Il baccanale è una festa che inizia con l’idea di annullare le differenze tra le persone (sesso, età, ricchezza), ma finisce per trasformarsi in pura violenza. Questa crisi legata al dio Dioniso si diffonde rapidamente. Penteo, che si oppone a tutto questo, diventa il bersaglio della violenza di gruppo. Nelle “Baccanti”, le differenze spariscono: le donne agiscono con una violenza tipicamente maschile, si perde la distinzione tra esseri umani e animali (le Baccanti attaccano bestie e scambiano Penteo per un leone, Penteo attacca un toro pensando sia Dioniso), e si confonde anche la differenza tra uomo e dio (Dioniso e Penteo mostrano comportamenti simili, e la frenesia rende chi è posseduto quasi un dio).La morte di Penteo e la risoluzione della crisi
L’uccisione di Penteo rappresenta il momento culminante e la soluzione della crisi. Avviene tramite lo “sparagmos”, uno smembramento fatto a mani nude da tutti i presenti, senza l’uso di armi. Questo rito imita un evento violento originale, un linciaggio spontaneo, dove una folla fuori controllo si scaglia contro un individuo, la cui morte riporta la calma nel gruppo. La comunità, ripetendo questi gesti, cerca di ottenere lo stesso effetto pacificatore.L’interpretazione religiosa e il pericolo della verità
Dal punto di vista religioso, l’uccisione di Penteo è vista come un atto divino, la vendetta di Dioniso contro l’arroganza umana. Questa visione nasconde il fatto che la vittima è stata scelta in modo casuale e che la violenza collettiva è ciò che ha davvero ristabilito l’ordine. Rivelare che questa pace si basa su un atto violento e casuale, sul meccanismo dell’accordo generale contro una vittima, è considerato pericoloso perché toglie il freno alla violenza umana. Euripide, pur mostrando chiaramente la violenza reciproca, si ferma prima di svelare completamente questa verità fondamentale, riaffermando che certi limiti della conoscenza non vanno superati.Davvero ogni forma di sacro e di ordine sociale si riduce a un atto di violenza originaria, o questa visione rischia di essere riduttiva e parziale?
Il capitolo presenta una tesi forte e suggestiva sull’origine violenta del sacro e delle strutture culturali, ma non affronta in modo esplicito altre significative teorie che offrono spiegazioni diverse o complementari sulla nascita della religione, della società e dei rituali. Questo può lasciare il lettore con l’impressione che la prospettiva presentata sia l’unica o la più accreditata. Per esplorare la questione in modo più completo e valutare la robustezza dell’argomentazione del capitolo, è fondamentale confrontarla con altri approcci. Si possono approfondire discipline come l’antropologia, la sociologia della religione e la storia delle idee. Per avere un quadro più ampio, oltre all’autore a cui il capitolo sembra ispirarsi (René Girard), è utile conoscere le opere di pensatori come Émile Durkheim, che ha posto l’accento sulla funzione sociale del sacro e sull’effervescenza collettiva, o Claude Lévi-Strauss, per comprendere meglio lo strutturalismo criticato nel testo.7. La violenza originaria e le forme della cultura
Ogni forma culturale umana, dai racconti antichi ai riti, fino alle strutture sociali più complesse, nasce da un meccanismo fondamentale: un accordo violento e unanime che si rivolge contro una vittima. Questo processo non riguarda solo i sacrifici rituali, ma influenza ogni attività umana.Come nasce l’ordine sociale
Il sistema che regola la giustizia, per esempio, ha le sue radici in questa violenza iniziale. La condanna a morte, sia che appaia in forme legate alla religione (come eliminare una colpa o allontanare chi porta il male) sia in forme che sembrano non religiose (come cacciare gli stranieri), deriva dall’impulso spontaneo di una comunità di unirsi contro una persona considerata colpevole. Questa origine violenta rende la punizione in parte arbitraria, come si vede nelle antiche prove del giudizio.Anche chi detiene il potere centrale, come un re o un governo, nasce dalla figura della vittima. In molte società, l’autorità viene data a qualcuno che all’inizio potrebbe essere una vittima o che viene sostituito da una vittima sacrificale. I riti legati alla regalità, anche quelli che sembrano opposti come l’unione sacra tra parenti stretti, sono diversi modi di interpretare la stessa crisi violenta che viene risolta attraverso la vittima. Anche le feste riproducono questa crisi in cui avviene il sacrificio.Simboli e caso nella scelta della vittima
I riti e le strutture sociali, sia quelli sacri che quelli non religiosi, emergono da questa violenza iniziale. Il modo in cui gli esseri umani creano simboli è legato alla vittima, che appare come la fonte dell’unità e dell’ordine nella società. Luoghi importanti e carichi di significato, come il centro del mondo o il focolare di casa nell’antica Grecia, segnano il punto in cui la vittima è morta. Questi luoghi diventano i centri da cui nascono la religione, le pratiche di culto e l’organizzazione della società.Il ruolo del caso in molti riti, come i giochi d’azzardo o l’estrazione a sorte, mostra quanto fosse casuale la scelta della vittima per risolvere la crisi violenta. Storie antiche, come quella di Giona, raccontano come un sorteggio potesse indicare la persona da allontanare per salvare l’intera comunità.Comprendere oggi le origini della cultura
Le spiegazioni più recenti, come quelle proposte da studiosi come Frazer, spesso non riconoscono questo meccanismo fondamentale, considerando la figura del capro espiatorio solo una vecchia credenza. Non riconoscere questa violenza che sta all’origine è fondamentale per costruire la cultura, ma non considerarla nelle analisi moderne impedisce di capire a fondo da dove veniamo. La crisi che viviamo oggi, con il ritorno di questa violenza essenziale, offre un’occasione per comprendere finalmente il suo ruolo.Davvero ogni singola forma culturale umana nasce solo da un accordo violento contro una vittima?
Il capitolo propone un’origine unica e violenta per ogni forma culturale. Questo solleva interrogativi sulla complessità dello sviluppo umano e sull’influenza di altri fattori, come la cooperazione, l’adattamento ambientale o l’innovazione non legata a crisi violente. Per esplorare queste sfaccettature e confrontare diverse prospettive sull’origine e l’evoluzione delle società umane, è utile approfondire gli studi di antropologia culturale, sociologia e storia comparata. Considerare autori che analizzano la diversità delle forme sociali e le molteplici cause del cambiamento culturale può offrire un quadro più completo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]