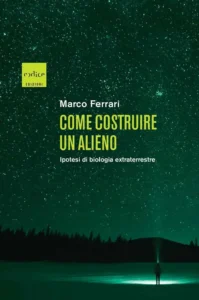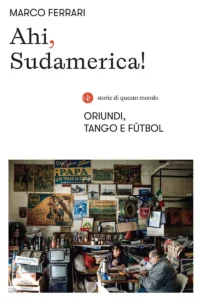Contenuti del libro
Informazioni
“La via incantata Nella natura, dove si basta a sè stessi” di Marco Ferrari è uno di quei libri che ti restano dentro. Non è la solita guida o una biografia noiosa, ma un viaggio che intreccia vite e luoghi in modo sorprendente. Al centro c’è Giacomo Bove, un esploratore italiano pazzesco di fine ‘800, uno che è stato nell’Artico, in Patagonia, in Terra del Fuoco, ma la cui storia finisce in modo super triste a Verona. Il libro lo lega a un posto incredibile qui da noi: il Sentiero Bove, nel Parco Nazionale Val Grande, che è tipo la wilderness più grande d’Italia, un posto dove la natura ha cancellato quasi tutte le tracce umane. Ferrari non si ferma qui, tira dentro personaggi come Emilio Salgari, che ha scritto romanzi ispirandosi a Bove senza mai viaggiare, o Mario Pavan, che ha lottato per proteggere aree come il Monte Pedum in Val Grande. È un racconto che ti fa riflettere sul perché cerchiamo l’avventura lontano quando la vera solitudine e la natura selvaggia sono spesso a un passo da casa, su come la memoria delle persone e dei luoghi cambia, e su cosa significa davvero bastare a sé stessi in mezzo a tutto questo. Se ti piacciono le storie di esploratori, i sentieri di montagna e i libri che ti fanno guardare il mondo (quello vicino e quello lontano) con occhi diversi, devi leggerlo. È un mix potente di storia, natura e introspezione.Riassunto Breve
Giacomo Bove, esploratore italiano, muore suicida a Verona nel 1887, a trentacinque anni, indebolito da una malattia contratta in Congo. Lascia lettere che spiegano il gesto come inevitabile e si spara sotto un gelso in campagna, un luogo che richiama la sua vita all’aria aperta. Il suo corpo viene ritrovato da un contadino e sul posto accorre anche Emilio Salgari, giornalista per “L’Arena”, che sarà profondamente influenzato dalla figura di Bove. Salgari, pur non viaggiando, ambienta i suoi romanzi nei luoghi esplorati da Bove e adotta l’immagine dell’avventuriero. Le vite dei due uomini presentano sorprendenti coincidenze, inclusa la morte per suicidio, un tema ricorrente anche tra le loro famiglie e conoscenti. Nonostante Bove fosse una celebrità internazionale, in Italia la sua memoria subisce una *damnatio memoriae*, forse legata alla condanna del suicidio da parte della Chiesa cattolica e a un generale disinteresse per l’esplorazione. La sua memoria è preservata dalla famiglia e da iniziative come la traslazione della salma nel suo paese natale. L’interesse per Bove rinasce anche grazie a un sentiero a lui dedicato in Val Grande. Questo sentiero, situato tra le creste montane, fu creato con i fondi raccolti per una spedizione antartica mai realizzata e divenne la prima via ferrata e alta via a tappe delle Alpi, un monumento percorribile che incarna lo spirito di avventura di Bove. La Val Grande è la più vasta area wilderness d’Italia, un territorio quasi interamente coperto da foreste, senza strade interne, dove la natura ha ripreso il sopravvento dopo l’abbandono umano. Un tempo abitata da centinaia di famiglie di alpigiani che vivevano di legname e allevamento in numerosi villaggi, la valle si è svuotata a partire dalla fine degli anni Cinquanta. La foresta ha inghiottito i sentieri e trasformato gli alpeggi in ruderi, testimonianza di una civiltà montanara scomparsa. La storia della valle è segnata da cicli di disboscamento e successiva riconquista da parte della natura. Bove, con la sua razionalità scientifica e le sue esplorazioni in luoghi lontani come l’Artico (spedizione Vega, sverno forzato nel ghiaccio) e la Terra del Fuoco (spedizione argentina, naufragio, mappatura), incarna la modernità e il positivismo, in contrasto con il mondo magico e isolato degli alpigiani della Val Grande. Le sue relazioni di viaggio, come quelle sulla Terra del Fuoco, diventano fonte per Salgari. Il Sentiero Bove, dopo un periodo di declino e atti di vandalismo, viene risistemato e richiede manutenzione, offrendo un percorso impegnativo in un ambiente selvaggio. L’esperienza di isolamento in natura, simile a quella vissuta da Bove bloccato dai ghiacci, porta a introspezione. La Val Grande è anche al centro di sforzi di conservazione, come l’istituzione della Riserva integrale del Monte Pedum, un’area chiusa all’uomo per preservare la sua selvaggità, sollevando interrogativi sul perché precludere l’accesso a tali luoghi. La natura selvaggia si manifesta sia come luogo fisico che come stato interiore. Il Sentiero Bove attraversa ambienti diversi, inclusa l’area della riserva integrale, dove il grado di solitudine è lo stesso anche fuori dai confini protetti. Qui si trovano i ruderi dell’antica civiltà alpina e la natura selvaggia, come le vipere, che un tempo generavano terrore negli alpigiani con la loro visione utilitaristica della natura. La vita millenaria degli alpigiani, basata sull’adattamento a un ambiente difficile, è scomparsa rapidamente. Oggi, luoghi lontani esplorati da Bove sono mete turistiche affollate, mentre la Val Grande, un tempo popolosa, è quasi deserta. Questo crea un paradosso: si cerca l’esotico lontano, mentre il vero mondo sconosciuto e solitario si trova spesso più vicino.Riassunto Lungo
1. Il sentiero e l’ultima passeggiata di Bove
Il Sentiero Bove si snoda tra le creste della Val Pogallo, raggiungendo circa duemila metri di altezza. Da qui si aprono panorami vasti sulle montagne vicine, come il maestoso Monte Rosa e le imponenti Grigne. Lo sguardo abbraccia anche il sistema della Val Grande, una distesa selvaggia e disabitata. Camminare lungo questo percorso, un tempo frequentato dagli alpigiani, fa sperimentare una profonda sensazione di solitudine. Abituarsi a questa dimensione di isolamento è un processo che si sviluppa gradualmente nei primi giorni del cammino.La storia di Giacomo Bove
Questo sentiero porta il nome di Giacomo Bove, un esploratore la cui vita si concluse tragicamente con un suicidio a soli trentacinque anni. La mattina del 9 agosto 1887, Bove lasciò il suo albergo a Verona. Era visibilmente provato da una malattia contratta in Congo, descritta come una “nevrosi”. Portava con sé una pistola e attraversò la città cercando un luogo isolato per compiere il suo gesto. Scartò l’idea di gettarsi nell’Adige per non rovinare le lettere che aveva in tasca e decise di trovare un posto all’aria aperta, più adatto al suo spirito di esploratore. Si diresse verso la campagna fuori Verona e scelse un gelso solitario tra i filari. Sotto l’albero, che forse gli ricordava i suoi viaggi o antiche simbologie, attese.
Gli ultimi momenti
Estrasse dalla tasca cinque lettere e due fotografie delle persone care, la moglie e la figlia adottiva. Dopo un istante di quiete, prese la rivoltella, sparò un colpo in aria e poi si tolse la vita sparandosi alla tempia destra. Il suo corpo fu trovato diverse ore dopo da un contadino. Sul posto arrivarono subito carabinieri, un medico, persone del luogo e curiosi. L’identità di Bove fu presto confermata. Nelle sue tasche trovarono le lettere e le fotografie. Una delle lettere, indirizzata alla Pubblica sicurezza di Verona, spiegava il suo atto come inevitabile a causa della malattia e chiedeva una sepoltura semplice. C’era anche un post scriptum con una nota ironica su un dialogo avuto con l’armaiolo. Tra i presenti al momento del ritrovamento c’era anche Emilio Salgari, inviato dal giornale “L’Arena”, che prendeva appunti sull’accaduto.
Ma davvero la “nevrosi” contratta in Congo basta a spiegare un gesto così estremo?
Il capitolo, nel descrivere la tragica fine di Bove, si affida in modo quasi esclusivo alla diagnosi di “nevrosi” come causa del suicidio. Questo, tuttavia, appare una semplificazione eccessiva di un atto che è quasi sempre il risultato di un concorso di fattori ben più complessi. Per gettare maggiore luce su questo punto, sarebbe indispensabile approfondire la storia della medicina e le conoscenze sulle malattie tropicali e le loro conseguenze psicologiche all’epoca di Bove. Parallelamente, un’analisi più sfaccettata della figura di Bove come esploratore e della sua vita al di fuori dell’episodio finale potrebbe fornire un contesto fondamentale per comprendere le sue motivazioni.2. L’Eredità Incrociata di Esploratori e Sognatori
Emilio Salgari viene profondamente influenzato dalla notizia della morte dell’esploratore Giacomo Bove, un evento che lo spinge a scrivere articoli su di lui. Salgari inizia ad adottare l’immagine del “Capitano” e del “Lupo di mare” nei suoi romanzi. Sceglie di ambientare molte delle sue storie avventurose nei luoghi esplorati da Bove, come il Borneo, l’Artico e la Patagonia. Questa scelta è significativa perché Salgari stesso non ha mai compiuto viaggi simili. L’immaginario di Bove diventa così una fonte inesauribile di ispirazione per le creazioni letterarie di Salgari.Coincidenze Sorprendenti nelle Loro Vite
Tra le vite di Emilio Salgari e Giacomo Bove si scoprono numerose e sorprendenti coincidenze che vanno oltre la semplice ispirazione letteraria. Ad esempio, Bove nasce in Piemonte e muore a Verona, mentre Salgari nasce a Verona e muore in Piemonte, quasi a completare un percorso inverso. Anche le date di nascita e morte dei due uomini presentano analogie curiose e opposte. Entrambi vivono per un periodo nella stessa zona di Sampierdarena, a Genova, in case che si trovano vicine l’una all’altra. Infine, entrambi scelgono di togliersi la vita fuori città, trovando la morte sotto degli alberi.Il Peso del Suicidio e l’Oblio
Il tema del suicidio rappresenta un legame tragico che unisce Bove e Salgari, estendendosi anche ad altre figure a loro connesse. Tra queste si contano i figli e il padre di Salgari, l’uomo che sposerà la vedova di Bove, e il figlio di Edmondo De Amicis. Nella società italiana dell’epoca, il suicidio è un atto severamente condannato dalla Chiesa cattolica, una visione che ha ripercussioni dirette sulla sepoltura e la memoria di Bove. A causa di questa condanna, gli viene rifiutato un funerale religioso e sorgono notevoli difficoltà per la sua sepoltura sia a Genova che ad Aqui Terme. Non gli viene nemmeno concessa una lapide sulla sua tomba, un segno tangibile del rifiuto sociale e religioso. Nonostante Bove sia stato una celebrità a livello nazionale e abbia ricevuto riconoscimenti internazionali, con luoghi che portano ancora oggi il suo nome, in Italia cade progressivamente in una damnatio memoriae. Questo oblio, questa quasi cancellazione dalla memoria collettiva, potrebbe essere in parte dovuto a un generale disinteresse che la nazione italiana mostrava all’epoca per la geografia e le grandi esplorazioni.La Memoria Preservata dalla Famiglia
La memoria di Giacomo Bove non scompare del tutto, ma viene preservata e custodita con cura dalla sua famiglia. Una figura centrale in questo è la prozia Franca Bove, che vive nel suo paese natale, Maranzana. Franca conserva gelosamente ricordi e testimonianze della vita dell’esploratore, contribuendo a mantenerne viva l’immagine. Descrive Bove come una vera “star” nazionale, molto amato dal pubblico per le sue doti oratorie e la sua capacità di affascinare chi lo ascoltava. Racconta anche della sua testardaggine fin da giovane e del suo percorso per entrare nell’Accademia Navale. Un gesto significativo compiuto da Franca Bove è l’organizzazione della traslazione della salma di Bove a Maranzana nel 1951, un’iniziativa che, a distanza di decenni, incontra ancora resistenze da parte del clero locale, a riprova del persistente giudizio negativo sul suicidio.Ma è davvero sufficiente un “generale disinteresse” per spiegare l’oblio di un eroe nazionale?
Il capitolo suggerisce che la damnatio memoriae di Bove possa essere dovuta, in parte, a un presunto “generale disinteresse” dell’Italia dell’epoca per la geografia e le grandi esplorazioni. Questa affermazione, significativa per comprendere il contesto culturale e politico, viene presentata senza un adeguato approfondimento o prove a supporto. Per valutare la fondatezza di tale tesi e comprendere meglio il clima culturale del tempo, sarebbe necessario esaminare la storia del colonialismo italiano, il ruolo delle società geografiche, la diffusione della letteratura di viaggio e l’attenzione mediatica verso le imprese esplorative in quel periodo. Approfondire autori che trattano la storia sociale e culturale dell’Italia post-unitaria o la storia delle esplorazioni potrebbe fornire il contesto mancante.3. Il sentiero, monumento dimenticato e ritrovato
Giacomo Bove si distingue non solo come esploratore solitario, ma anche per la sua abilità nel trovare finanziamenti e per un animo romantico, come rivelano le sue lettere alla moglie e il diario artico. È legato da amicizia a Edmondo De Amicis, una figura letteraria molto apprezzata, a differenza di Salgari che, pur ammirando Bove, riceve critiche dagli ambienti letterari. L’interesse per Bove nasce in modo inatteso, dall’incontro casuale con un sentiero a lui dedicato nella Val Grande. La sua figura incarna lo spirito positivista di fine Ottocento, un’epoca caratterizzata dalla fiducia nella possibilità di completare la conoscenza del mondo.Un sentiero come monumento
Dopo la sua morte, la memoria di Bove viene gestita in modo particolare. A Intra, sul Lago Maggiore, l’ambiente locale, influenzato da una borghesia svizzera di idee liberali e da una comunità evangelica, non condanna il suicidio, considerandolo un atto di libertà di coscienza. I fondi raccolti per una spedizione in Antartide che non si realizzò mai vengono impiegati per creare un memoriale speciale: un sentiero tracciato sulle creste montane. Questo percorso, attrezzato con funi e corrimano, diventa la prima via ferrata e la prima alta via a tappe delle Alpi, un vero e proprio monumento che si può percorrere, capace di rappresentare lo spirito di avventura di Bove.Caratteristiche e storia del percorso
Il sentiero, situato nella Val Grande, è un percorso che richiede impegno fisico, estendendosi per circa cinquanta chilometri e mantenendosi intorno ai duemila metri di quota. Offre panorami vasti e suggestivi, ma presenta la difficoltà della mancanza d’acqua ed è esposto ai cambiamenti improvvisi del tempo. È un’area dal carattere selvaggio, tanto da essere considerata un “santuario della wilderness”. Il sentiero fu costruito inizialmente dalla guida Antonio Garoni e godette di popolarità nei primi anni del Novecento. Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cadde in disuso, ritenuto troppo impegnativo per gli escursionisti comuni e non abbastanza tecnico per i nuovi alpinisti. Le attrezzature installate lungo il percorso si deteriorarono progressivamente. Verso la fine degli anni Settanta, un lavoro definito di “archeologia alpinistica” permise di ritrovare e ricostruire il tracciato originale del sentiero. Successivamente, venne effettuata una nuova sistemazione con attrezzature moderne, ma poco tempo dopo le catene vennero tagliate e l’opera distrutta.Era davvero così “misteriosa e sconosciuta” la malattia che stroncò Giacomo Bove in Congo?
Il capitolo descrive la malattia che colpì Bove come “misteriosa e sconosciuta”. Questa definizione, pur potendo riflettere la percezione dell’epoca da parte dei non addetti ai lavori o la difficoltà diagnostica sul campo, rischia di semplificare eccessivamente il contesto medico e scientifico del tardo Ottocento. Per comprendere meglio le sfide sanitarie affrontate dagli esploratori in ambienti tropicali come il Congo, e per valutare quanto fosse effettivamente “sconosciuta” quella malattia nel panorama medico dell’epoca, sarebbe utile approfondire la storia della medicina tropicale e le conoscenze sulle patologie endemiche in Africa centrale in quel periodo. Autori come Patrick Manson o Ronald Ross, pionieri nello studio delle malattie tropicali, potrebbero offrire spunti per contestualizzare meglio questa affermazione e capire se si trattasse di una patologia già studiata o effettivamente ignota alla scienza medica del tempo.11. Il paradosso del selvaggio vicino
Entrando in un’area protetta della Val Grande, la Riserva integrale del Pedum, si cammina in un luogo considerato il più selvaggio delle Alpi. L’accesso umano qui è vietato da quasi cinquant’anni. Eppure, il senso di solitudine e selvaggità non cambia molto anche uscendo da questo confine, che appare quasi artificiale. Addentrandosi nel bosco di faggi, si scoprono i ruderi di un’antica civiltà, segni di un tempo in cui queste aree erano abitate. Camminando tra questi resti, la natura sembra aver ripreso il suo spazio, creando un’atmosfera di quiete profonda.Paura e Utilità: La Vecchia Visione della Natura
In questi luoghi, si può incontrare la vipera (Vipera aspis). La paura dei serpenti è un sentimento molto antico e diffuso, spesso legato a vecchie credenze popolari e a un modo di vedere la natura che risale a tempi lontani. Per gli antichi abitanti delle montagne, animali come vipere, topi o lupi erano visti con terrore. Non li consideravano utili per la loro vita o il loro lavoro, e per questo li giudicavano ‘cattivi’. Questa visione divideva la natura in ciò che era utile, visto come ‘bene’, e ciò che era inutile, visto come ‘male’. Anche paesaggi che oggi troviamo bellissimi, come i ghiacciai o i dirupi, un tempo erano considerati semplicemente inutili e quindi poco apprezzati.
L’Uomo e la Montagna: Un Legame Millenario
La presenza umana sulle Alpi risale a oltre diecimila anni fa. Ci sono voluti circa cinquemila anni perché le persone si stabilissero in modo permanente e imparassero ad adattarsi a un ambiente così difficile. Hanno imparato a usare le risorse fondamentali che la montagna offriva: pietra, legno, bestiame e ferro. La vita era strettamente legata a queste risorse limitate, il che imponeva di essere molto attenti e di controllare quante persone vivevano in un’area, a volte spostandosi o sposandosi più tardi. Questo modo di vivere è rimasto quasi uguale per migliaia di anni. Poi, negli ultimi cinquant’anni, è cambiato tutto molto velocemente ed è quasi scomparso.
Il Paradosso della Distanza e della Vicinanza
Oggi, molte persone viaggiano in terre lontane, come la Patagonia o la Terra del Fuoco, luoghi che un tempo esploratori come Giacomo Bove cercavano per la loro esoticità. Paradossalmente, questi posti sono diventati mete turistiche molto frequentate e affollate. Nello stesso tempo, aree come la Val Grande, che un tempo erano piene di vita, sono quasi completamente deserte. Prendiamo Cicogna, un paese che ospitava centinaia di persone e dove oggi ne vivono solo sette. Questo crea una situazione strana e contraddittoria: cerchiamo l’ignoto e il selvaggio in luoghi lontanissimi, quando spesso il vero mondo sconosciuto e solitario si trova molto più vicino a noi.
Davvero il paradosso del ‘selvaggio vicino’ si spiega solo con la ricerca dell’esotico lontano, o il capitolo ignora le forze che hanno svuotato le nostre montagne?
Il capitolo presenta un contrasto affascinante, ma non scava a fondo nelle ragioni del rapidissimo cambiamento degli ultimi cinquant’anni. Per comprendere perché le aree montane, abitate per millenni, si siano svuotate mentre luoghi lontani si affollano, è necessario guardare oltre la semplice ricerca dell’esotico. Bisogna esplorare le profonde trasformazioni socio-economiche del secondo dopoguerra: l’industrializzazione, l’urbanizzazione, il declino dell’agricoltura tradizionale, le nuove forme di mobilità e di consumo del territorio. Approfondire la storia economica e sociale, la sociologia rurale e la geografia umana può fornire le chiavi per capire queste dinamiche. Si possono cercare autori che hanno analizzato la modernizzazione e i suoi effetti sul paesaggio e sulle comunità locali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]