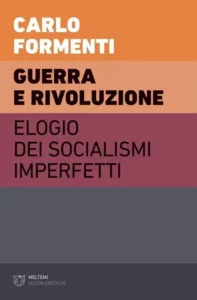Contenuti del libro
Informazioni
“La variante populista. Lotta di classe nel neoliberismo” di Carlo Formenti è un libro che ti sbatte in faccia come il capitalismo è cambiato un sacco, diventando sempre più finanziario e digitale, fregandosene della produzione vera per fare soldi con la finanza. Questa roba, unita alle politiche neoliberiste che smantellano lo stato sociale, ha messo in crisi la sinistra tradizionale, che non riesce più a difendere i lavoratori e si è persa per strada, concentrandosi su altre cose. Però, proprio da questa crisi e dalla rabbia che monta, spunta fuori il populismo, che il libro analizza come una possibile crepa nel sistema, anche se è complicato e può andare a destra o a sinistra. La vera lotta, secondo Formenti, non è più quella vecchia, ma una specie di guerra tra il mondo “immateriale” dei flussi globali – finanza, dati, élite – e il mondo “materiale” dei luoghi, dove la gente vive davvero e ha bisogno di cose concrete. Il libro cerca di capire come si può combattere questo sistema partendo dal basso, dai territori e dalle comunità, provando a riconquistare un po’ di sovranità contro il dominio dei flussi. È un viaggio tosto nell’analisi della lotta di classe oggi, in un mondo super connesso ma anche super diviso.Riassunto Breve
Il capitalismo affronta le sue crisi spostando l’attenzione dalla produzione alla finanza, cercando profitto nella rendita finanziaria. Questo significa che le aziende pensano più al valore delle azioni che a fare cose, usando la tecnologia digitale per muovere soldi velocemente in tutto il mondo. Questa tecnologia, con algoritmi e reti, doveva rendere tutto più efficiente ma ha finito per aumentare la speculazione e creare debiti enormi. Dietro a tutto questo ci sono scelte politiche precise fatte dagli anni ’80, che hanno tolto regole e tagliato la spesa pubblica, indebolendo i diritti dei lavoratori e i servizi per tutti. Questa idea si chiama ordoliberalismo e vuole che la società funzioni come un grande mercato dove tutti competono. La digitalizzazione peggiora le cose per i lavoratori, con nuovi modi di controllare il lavoro e la “sharing economy” che rende tutto più incerto. I media digitali poi ci controllano in modo capillare, usando i nostri dati per profitto e controllo sociale, creando un sistema dove chi ha soldi e potere comanda senza trasparenza. La socialdemocrazia, che una volta difendeva i lavoratori e riduceva le disuguaglianze, ha perso forza perché è finita la competizione con il blocco socialista e il capitalismo è cambiato, diventando più globale e finanziario. I partiti socialdemocratici sono diventati più moderati, pensando più ai diritti individuali che a quelli economici e sociali. Anche i sindacati hanno avuto problemi. Movimenti importanti come il femminismo e l’ecologismo, pur portando avanti idee giuste, sono stati in parte assorbiti dal sistema, senza riuscire a cambiarlo davvero nelle sue basi economiche. L’idea di concentrarsi solo sui diritti individuali, tipica di una certa sinistra, fa dimenticare i diritti di tutti e non mette in discussione il sistema economico. Anche iniziative come il commercio equo rischiano di non cambiare le cose in profondità. Sembra difficile cambiare il sistema restandoci dentro. Il capitalismo continua a crescere prendendo quello che è fuori da lui, come risorse naturali e modi di vivere diversi. Oggi questo si vede come una lotta tra lo spazio dei flussi (finanza, merci, élite) e lo spazio dei luoghi (persone, comunità, bisogni concreti). Per combattere il capitalismo bisogna partire dal basso, da chi è meno integrato nel sistema, valorizzando modi di vivere diversi. Il populismo è un fenomeno politico importante in questo scontro, perché mette contro il popolo e le élite. Può essere usato in modi diversi, ma spinge a parlare di sovranità popolare e comunità. Esperienze in America Latina mostrano che il populismo di sinistra può portare a cambiamenti, ma con difficoltà. In Europa, movimenti populisti criticano il sistema ma spesso restano su posizioni moderate. La vera sfida per il populismo di sinistra è staccarsi dal mercato globale per creare qualcosa di veramente diverso. È importante capire chi comanda dentro questi movimenti populisti: i lavoratori o le classi medie? Da questo dipende se il populismo può diventare uno strumento per cambiare davvero le cose. La lotta di oggi è tra due mondi diversi: quello dei flussi, immateriale, e quello dei luoghi, materiale, dove le persone hanno bisogni veri come cibo e casa. La sinistra ha guardato troppo ai flussi, dimenticando i luoghi. Per vincere, bisogna costruire e rafforzare i territori e le comunità, unendo chi lavora e chi si occupa degli altri. Bisogna organizzare chi è escluso per riprendere il potere e creare partiti nuovi che sappiano opporsi al sistema europeo attuale e chiedere indietro la sovranità nazionale.Riassunto Lungo
1. La Morsa Digitale del Capitalismo
La Finanziarizzazione dell’Economia come Strategia del Capitalismo
La finanziarizzazione dell’economia è un modo in cui il capitalismo reagisce alle crisi di profitto che si presentano ciclicamente. Invece di concentrarsi sulla produzione di beni, il sistema economico sposta il suo interesse verso i guadagni finanziari. Questo cambiamento si nota nel fatto che si dà più importanza al valore delle azioni rispetto alla produzione di cose concrete. Le aziende, quindi, preferiscono dedicarsi a operazioni finanziarie complesse, chiamate “financial engineering”, per abbassare i costi e aumentare al massimo i profitti per chi possiede le azioni. Spesso, però, questo avviene a discapito degli investimenti nel lavoro e nello sviluppo di nuove attività.Il Ruolo della Tecnologia Digitale nell’Accelerare la Finanziarizzazione
La tecnologia digitale ha un ruolo molto importante in questo processo. Essa accelera la globalizzazione finanziaria, rendendo possibili operazioni economiche in tutto il mondo in tempo reale. Gli algoritmi e le reti informatiche, che in teoria dovrebbero rendere tutto più razionale e sicuro, in realtà hanno favorito la speculazione e l’instabilità nel mondo della finanza. Hanno creato nuove forme di denaro virtuale e aumentato la dipendenza dai debiti, sia per i governi che per i privati.Le Scelte Politiche a Supporto del Sistema Finanziario
Questo sistema economico è sostenuto da precise decisioni politiche. A partire dagli anni ’80, i governi hanno promosso la deregulation, cioè la riduzione delle regole, e hanno tagliato la spesa pubblica. In questo modo, hanno indebolito il sistema di protezione sociale e i diritti dei lavoratori. L’ordoliberalismo, che è l’idea politica che guida queste scelte, non vuole semplicemente lasciare fare al mercato. Il suo obiettivo è costruire attivamente un sistema sociale ed economico basato sulla competizione generale. In questo sistema, lo Stato ha il compito di formare le persone e la società secondo le logiche del mercato.Intensificazione dello Sfruttamento del Lavoro e Sorveglianza Digitale
La digitalizzazione rende ancora più intenso lo sfruttamento del lavoro. Si diffondono nuove forme di organizzazione del lavoro basate sul modello di Taylor, ma applicate al digitale. La cosiddetta “sharing economy”, o economia della condivisione, rende il lavoro più precario e aumenta il controllo sui lavoratori attraverso piattaforme online e algoritmi. Inoltre, i nuovi mezzi di comunicazione creano nuove forme di sorveglianza che controllano ogni aspetto della vita delle persone. I dati personali diventano una merce e uno strumento per controllare la società. Si delinea così un sistema che sembra andare oltre la democrazia, in cui i gruppi più ricchi e potenti esercitano un potere sempre maggiore, ma in modo meno chiaro e trasparente.Ma se la finanziarizzazione e la digitalizzazione sono forze intrinsecamente negative del capitalismo, come si spiegano i periodi di crescita economica e progresso sociale che si sono verificati parallelamente a questi fenomeni?
Il capitolo sembra presentare una visione eccessivamente deterministica e unidimensionale del rapporto tra capitalismo, finanza e tecnologia digitale. L’argomentazione, pur evidenziando aspetti critici reali, rischia di trascurare la complessità storica e le contraddizioni intrinseche a questi processi. Per una comprensione più articolata, sarebbe utile integrare l’analisi con studi di storia economica e sociologia del lavoro, approfondendo autori come Schumpeter, per comprendere il ruolo della “distruzione creativa” nel capitalismo, o Castells, per analizzare le dinamiche ambivalenti della società in rete.2. Il Labirinto della Riforma
Le radici e il successo della socialdemocrazia
La socialdemocrazia è nata nel Nord Europa e si è sviluppata come progetto storico basato su quattro principi fondamentali. Tra questi, spiccavano un ruolo attivo dello Stato nell’economia, politiche fiscali volte a ridurre le differenze di ricchezza, un sistema di contrattazione sindacale forte e meccanismi di redistribuzione della ricchezza. Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, questo modello ha avuto successo grazie a un contesto favorevole ai lavoratori e alla competizione con i paesi socialisti.La fine della competizione con il blocco socialista e la svolta liberale
La caduta dell’Unione Sovietica ha segnato la fine di questa competizione. Senza più l’alternativa del blocco socialista, il capitalismo ha potuto evolversi in direzione liberale. La crescita della finanza e l’apertura dei mercati globali hanno indebolito la classe operaia. Di conseguenza, i partiti socialdemocratici tradizionali hanno perso la loro base di riferimento e sono diventati obsoleti. Invece di opporsi a questo cambiamento, questi partiti si sono trasformati in forze politiche di centro. Hanno accettato le riforme liberiste e si sono concentrati maggiormente sui diritti civili, trascurando la giustizia sociale ed economica. Anche in Italia si è verificato un processo simile: il Partito Comunista Italiano, dopo la caduta del Muro di Berlino, si è spostato verso posizioni liberali.Il declino dei sindacati
Anche i sindacati hanno perso importanza. Questo è avvenuto sia a causa di attacchi esterni, che hanno cercato di indebolirli, sia per scelte sbagliate fatte al loro interno. Queste scelte li hanno portati ad allontanarsi dalla difesa degli interessi concreti dei lavoratori. Nonostante ciò, movimenti politici come quelli di Sanders e Corbyn avevano riacceso la speranza in una rinascita della socialdemocrazia. Tuttavia, questa speranza si scontra con i profondi cambiamenti del capitalismo contemporaneo e con il dominio delle idee liberiste.L’integrazione dei movimenti del ’68 nel sistema capitalistico
I movimenti nati dalle contestazioni del 1968, come il femminismo e l’ecologismo, hanno portato importanti richieste di cambiamento. Nonostante questo, il sistema capitalistico è riuscito ad assorbire e integrare anche queste istanze. In particolare, il femminismo rischia di diventare utile al sistemaCapitalistico, promuovendo un’uguaglianza solo formale. Questa uguaglianza non interviene sulle disuguaglianze economiche e sociali più profonde. Allo stesso modo, l’ecologismo spesso si limita a chiedere piccoli cambiamenti individuali, senza affrontare le cause strutturali della crisi ambientale che sono legate al funzionamento del capitalismo.La retorica dei diritti individuali e i limiti delle riforme
La retorica sui diritti individuali, sostenuta da una certa sinistra che ha abbandonato le ideologie tradizionali, sposta l’attenzione dai diritti sociali e collettivi. Si finisce così per dare importanza a molti diritti diversi, ma nessuno di questi mette in discussione il sistema economico esistente. Anche iniziative positive come il commercio equo e solidale rischiano di essere assorbite dalle logiche del mercato. In questo modo, non riescono a produrre un cambiamento profondo nel sistema economico. Le proposte che valorizzano il territorio e la comunità locale, pur essendo interessanti, hanno difficoltà a confrontarsi con la forza dell’economia globale e dei movimenti di denaro del capitalismo. In conclusione, sembra sempre più difficile pensare di poter cambiare il sistema economico attraverso riforme dall’interno.Se la socialdemocrazia ha avuto successo solo grazie alla competizione con il blocco sovietico, come mai è nata e si è sviluppata nel Nord Europa prima di tale competizione?
Il capitolo sembra suggerire un legame causale troppo diretto tra la competizione con il blocco sovietico e il successo della socialdemocrazia, trascurando altri fattori interni e specifici dei paesi del Nord Europa che potrebbero aver giocato un ruolo cruciale. Per rispondere a questa domanda, è utile approfondire la storia della socialdemocrazia e le dinamiche politiche ed economiche del Nord Europa nel periodo precedente e successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Autori come Barrington Moore Jr. potrebbero offrire spunti utili per comprendere le radici storiche dei diversi modelli politici.3. La Guerra dei Luoghi
Capitalismo e conflitto spaziale
Il capitalismo si espande continuamente attraverso l’appropriazione di ciò che percepisce come esterno ai propri confini. Questa appropriazione riguarda sia le risorse naturali, sia le diverse forme di vita sociali e culturali. Questa dinamica di inclusione ed esclusione si manifesta oggi come un conflitto tra due dimensioni spaziali distinte: lo spazio dei flussi e lo spazio dei luoghi.La lotta dal basso e il populismo
La resistenza al capitalismo deve nascere dal basso, coinvolgendo gli strati sociali marginalizzati e le comunità che non sono pienamente integrate nel sistema capitalista. È fondamentale valorizzare e sostenere quelle forme di vita che esistono al di fuori o contro il capitalismo. In questo contesto emerge il populismo come fenomeno politico di rilievo. Il populismo rappresenta una potenziale rottura con l’ordine liberale democratico, poiché si fonda su una divisione netta tra il popolo e le élite. Questa divisione viene mobilitata attraverso un linguaggio politico che, pur essendo spesso ambiguo, riesce a essere efficace nel catturare il consenso.Populismo: tecnica politica e contenuti politici
Sebbene il populismo possa essere considerato semplicemente una tecnica politica trasversale, la sua adozione ha un impatto profondo sui contenuti politici. Anche movimenti politici di sinistra, adottando una retorica populista, finiscono per integrare nei loro programmi temi come la sovranità popolare e il comunitarismo.Esperienze populiste in America Latina, Europa e Stati Uniti
Le esperienze populiste in America Latina, come le rivoluzioni bolivariane, dimostrano la capacità del populismo di sinistra di generare trasformazioni sociali significative. Tuttavia, queste esperienze rimangono spesso instabili e dipendenti da modelli economici basati sullo sfruttamento delle risorse naturali. In Europa, movimenti come il M5s e Podemos rappresentano forme di populismo che, pur criticando il sistema esistente, tendono a rimanere nell’ambito di un approccio riformista. Negli Stati Uniti, le figure di Sanders e Trump mettono in luce la complessità del populismo, mostrando come convergenze retoriche e programmatiche possano emergere in un contesto di profonda crisi politica e sociale.La sfida del “delinking” e la questione dell’egemonia
Per i movimenti populisti di sinistra, la vera sfida è andare oltre una logica di semplici riforme e adottare una strategia di “sganciamento” (in inglese, “delinking”) dal mercato globale. Solo attraverso questo “sganciamento” è possibile costruire un’alternativa realmente anti-capitalista. Un interrogativo cruciale per il futuro del populismo riguarda chi detiene il potere all’interno del blocco sociale populista. In altre parole, l’egemonia è esercitata dalle classi subordinate o dalle classi medie? La risposta a questa domanda è fondamentale, perché da essa dipende la possibilità di trasformare il populismo in uno strumento efficace per la lotta di classe e per un cambiamento radicale del sistema economico e sociale.[/membership]Ma è davvero auspicabile e praticabile una strategia di “sganciamento” dal mercato globale, o rischia di isolare ulteriormente le realtà locali?
Il capitolo presenta lo “sganciamento” come una sfida cruciale per il populismo di sinistra, ma non chiarisce in modo sufficiente le implicazioni concrete di tale strategia. Non vengono infatti discussi i potenziali rischi di isolamento economico e culturale che potrebbero derivare da una chiusura rispetto al mercato globale. Per una comprensione più completa, sarebbe utile approfondire le dinamiche dell’economia internazionale e le teorie della dipendenza economica, studiando autori come Immanuel Wallerstein e Samir Amin.4. La Guerra tra Mondi
La guerra di classe del capitale e le sue conseguenze
Negli ultimi decenni, il capitale ha condotto una guerra di classe che ha cambiato profondamente la società, in particolare le classi medio-alte subordinate. Le forze politiche di sinistra, inclusi i movimenti radicali e quelli più recenti, non solo si sono adattate a questa offensiva del capitale, ma vi partecipano in modo attivo.Il successo del capitale ha avuto però delle conseguenze negative importanti. Si notano resistenze alla globalizzazione, un aumento dei conflitti distruttivi, migrazioni difficili da gestire e l’emergere di populismi. Questi populismi ripropongono la lotta di classe tra chi sta in alto e chi sta in basso nella società.
Il conflitto tra mondo immateriale e mondo materiale
Per capire meglio questa situazione e reagire, è utile analizzare il conflitto sociale con le idee di Gramsci. Oggi, il conflitto principale è tra due mondi che non possono convivere: un mondo “immateriale” fatto di movimenti rapidi di denaro, merci, notizie e persone ricche, e un mondo “materiale” fatto di luoghi concreti, dove vivono persone con bisogni reali come mangiare, avere una casa e un lavoro.La sinistra, affascinata dalle idee borghesi di modernità e progresso, ha dato più importanza al mondo dei movimenti rapidi, trascurando i luoghi e le persone che ci vivono.
Costruire comunità per superare la divisione
Per superare questa divisione, è fondamentale concentrarsi sulla creazione di territori e comunità forti. Esistono tre tipi principali di comunità:- Comunità del rancore: formata da chi è escluso e si sente arrabbiato.
- Comunità di cura: legata ai servizi sociali e all’assistenza.
- Comunità operosa: orientata all’innovazione e al lavoro produttivo.
Un progetto politico valido deve unire la comunità operosa e quella di cura. L’obiettivo è creare territori autonomi, capaci di proteggersi dai cambiamenti globali troppo veloci e di usare questi cambiamenti per ottenere risorse utili.
La strategia dal basso per riconquistare la sovranità
Per contrastare il potere dei movimenti rapidi, la strategia deve partire dalle persone comuni. Bisogna organizzare le comunità del rancore per riprendere il controllo della società e costruire partiti politici nuovi e uniti. Questi partiti devono essere in grado di opporsi al sistema europeo attuale e chiedere il ritorno alla sovranità nazionale.È davvero auspicabile costruire un progetto politico basato sulle “comunità del rancore”, e non rischia di esacerbare le divisioni sociali che si intendono superare?
Il capitolo propone una strategia che appare rischiosa e poco chiara. L’idea di organizzare le “comunità del rancore” per “riprendere il controllo della società” solleva interrogativi sulla natura di questo controllo e sui metodi per raggiungerlo. Un approccio politico basato sul rancore potrebbe facilmente sfociare in dinamiche divisive e conflittuali, minando la coesione sociale. Per comprendere meglio le dinamiche dei movimenti sociali e le teorie politiche alternative, è utile approfondire il pensiero di autori come Hannah Arendt, che ha analizzato i pericoli della politica basata sulle emozioni negative e sull’identificazione del nemico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]