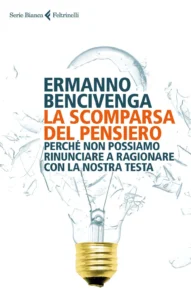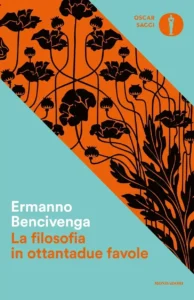Contenuti del libro
Informazioni
“La stupidità del male. Storie di uomini molto cattivi” di Ermanno Bencivenga è un libro che scava a fondo per capire cosa sia davvero il male, esplorando diverse facce di questa realtà oscura. Non si ferma a una sola idea, ma analizza come il male possa essere visto in modi diversi: dalla logica strumentale del male, quella che usa violenza e propaganda per scopi terribili come la conquista di spazio vitale, un po’ come si è visto nel Nazismo, fino al piacere crudele cercato da figure come il Marchese de Sade, che vedeva nella trasgressione e nelle sensazioni estreme l’unico vero motore. Il libro però mostra i limiti di queste visioni, spiegando che il male non ha una sua logica interna o un principio organizzato; è più che altro distruzione, una sorta di ombra che divora la luce, come si vede in personaggi estremi tipo Maldoror. Viene esplorata anche l’idea di una necessità del male, sia fisica che basata su regole o vendetta, ma anche qui si conclude che questa non definisce l’essenza malvagia. Alla fine, Bencivenga arriva a dire che il male non ha una sua forma, non è un ideale alternativo al bene, ma è concettualmente vuoto, dipende dal bene per esistere come sua negazione. È un’assenza, una mancanza di forma, e la sua presunta libertà o profondità è solo un’illusione. È un viaggio filosofico e morale che ti fa riflettere sulla vera natura del male e sulla sua fondamentale “stupidità”.Riassunto Breve
La stabilità di uno Stato si considera dipendere dall’unità del popolo basata su razza o etnia, non su teorie economiche. L’unico scopo politico è la conservazione e l’aumento della razza, che richiede giovani sani, riproduzione e l’eliminazione dei non sani. L’educazione fisica è fondamentale per un esercito forte, fattore unificante. La lotta per la sopravvivenza tra popoli è costante; chi non combatte soccombe. Il diritto si fonda sull’efficacia e la forza. Per un popolo, è necessario riunirsi in un unico Stato e conquistare territorio, specialmente a est, per ottenere spazio vitale; la forza conferisce il diritto. La propaganda è uno strumento cruciale, si rivolge al sentimento, ripete pochi punti e presenta il nemico come terribile. Violenza e terrore sono armi pragmatiche. Questa visione del male è strumentale: si fa il male perché serve a un fine, negando i giudizi morali e considerando l’efficienza l’unico parametro. Questa logica porta a orrori su vasta scala e si manifesta anche nei piccoli mali quotidiani. La filosofia del Marchese de Sade nega la morale tradizionale, sostenendo che la natura è indifferente e le distinzioni morali sono relative, basate su opinioni o geografia; queste idee presentano errori logici perché il piano morale è distinto da quello naturale e la varietà di opinioni non nega l’esistenza di qualcosa. La ricerca del piacere intenso è il motore delle azioni, richiedendo sensazioni sempre più forti, anche orrori, per stimolare i sensi. Regole sociali e morali sono viste come ostacoli. L’egoismo è considerato legge naturale, giustificando l’indifferenza alla sofferenza altrui. La crudeltà offre piaceri intensi per il dolore della vittima e la violazione di divieti. Tuttavia, il piacere è soggettivo e non definisce la natura specifica del male; dire che il male è ciò che piace non distingue le azioni malvagie da altre piacevoli. La preferenza per piaceri intensi non è universale, e l’idea di una natura umana aggressiva repressa dalle norme è un’opinione. Il male non possiede un principio organizzato o un piano intellegibile. Figure come Maldoror rappresentano un male estremo, una volontà di devastazione universale. In una prima analisi, il male appare come semplice negazione del bene, una contrapposizione senza contenuto proprio. Una comprensione più profonda mostra che il male, inteso come distruzione, dipende concettualmente dal bene, inteso come costruzione. Costruire implica progetto e scopo; distruggere è semplice, aumenta il disordine, non ha un piano intrinseco. La distruzione necessita di qualcosa di costruito. L’affinità tra arte e distruzione, come nel “teatro della crudeltà”, si lega a un’estetica basata sulle sensazioni intense. Un giudizio estetico basato solo sull’intensità sensoriale non distingue tra esperienze violente prive di significato e opere che elaborano il male concettualmente. Il valore artistico non deriva dalla mera violenza delle sensazioni, ma dalla loro elaborazione. La rappresentazione del male non rivela una sua logica profonda, ma la ricerca di esperienze emotive forti. Il comportamento considerato malvagio è spesso motivato da una forma di necessità, naturale (dipendenza) o normativa (principi religiosi/morali, vendetta). La dipendenza è un fenomeno generale, non definisce il male. La necessità normativa può motivare azioni buone o malvagie; la motivazione è neutra. Concetti come “vitalità” o “egoismo” sono neutrali rispetto al bene o al male. Il male non possiede una logica o un contenuto proprio; non è definibile o comprensibile isolatamente. Si stabilisce che un’azione è malvagia solo in relazione a una teoria del bene. Il male è la negazione o la contraddizione del bene. Si identifica il male osservando comportamenti che violano i principi del bene. Il male è concettualmente vuoto e dipende interamente dalla nozione di bene per la sua definizione. L’idea che il male riveli una verità più profonda o offra libertà è fuorviante. Gli atti malvagi sono eventi reali, spiegabili scientificamente, ma questa realtà è ordinaria. L’idea che il male smascheri l’ipocrisia è riduzionismo; distruggere non rende la realtà più autentica del costruire. Non tutte le convenzioni sociali sono ipocrite. Smascherare non è di per sé buono o rivelatore di verità. La libertà associata al male (assenza di vincoli) è illusoria; eliminare vincoli esterni può portare al controllo da impulsi interni. La libertà positiva richiede disciplina e costruzione. Il male non ha legame intrinseco con la libertà; la sua presunta funzione liberatoria consiste nel liberare dalle regole del bene. Alcuni attribuiscono nobiltà o coraggio a chi commette il male senza scrupoli, ma questo uso è metaforico. Azioni intrinsecamente malvagie non sono virtù morali. L’apprezzamento personale o estetico per atti malvagi non stabilisce una base morale per il male. Il male, a differenza del bene, non possiede una logica o una forma coerente. Non è un ideale alternativo. Esiste come ciò che accade, spiegabile causalmente, ma rappresenta la semplice logica della distruzione, priva di significato profondo o struttura propria. È simile al sudiciume o alle macerie, che sono assenza di forma, non una forma in sé.Riassunto Lungo
1. La logica strumentale del male
La stabilità di uno Stato si basa sull’unità del suo popolo, inteso come razza o etnia. Non sono le teorie economiche o commerciali a garantire questa solidità, ma l’organizzazione di una comunità forte e unita, sia fisicamente che spiritualmente, con l’obiettivo primario di conservare la specie. La mescolanza di sangue e la diminuzione del livello razziale sono viste come le cause principali della fine delle culture esistenti. Per questo motivo, la conservazione e l’aumento della razza e del popolo diventano l’unico e fondamentale scopo politico.Garantire la salute e la forza del popolo
Per raggiungere lo scopo della conservazione e del potenziamento della razza, è fondamentale che i giovani siano sani e capaci di riprodursi. Il matrimonio è considerato uno strumento essenziale per la conservazione e il potenziamento della razza stessa. Chi non possiede una salute robusta viene visto come un elemento da eliminare per permettere il risanamento complessivo del popolo. L’educazione fisica assume un ruolo di primaria importanza, non solo per la salute individuale, ma anche per formare un esercito forte, che è considerato il fattore unificante per eccellenza della nazione. Di conseguenza, le attività intellettuali ritenute non strettamente necessarie vanno ridotte per dare maggiore spazio e priorità all’educazione fisica.La lotta per la sopravvivenza
La lotta tra popoli per la sopravvivenza è vista come una condizione costante e ineluttabile della vita. In questo scenario, una razza più forte è inevitabilmente destinata a prevalere e a scacciare quella più debole. Si sostiene che chi non è disposto a combattere attivamente per la propria esistenza non merita di continuare a vivere. Rimandare lo scontro significa solo doverlo affrontare in un momento successivo e in condizioni peggiori. In assenza di un principio morale indipendente che stabilisca cosa sia giusto, il concetto di diritto si basa unicamente sull’efficacia pratica e sulla forza dimostrata sul campo. Un popolo che rinuncia a lottare per la propria esistenza è destinato a soccombere.L’espansione territoriale e lo spazio vitale
Per garantire la sopravvivenza e la crescita del popolo tedesco, si ritiene necessario compiere due passi fondamentali. Il primo consiste nel riunire tutti i tedeschi sparsi in Europa all’interno di un unico grande Stato nazionale. Il secondo, e cruciale per il futuro, è la conquista di nuovi territori, in particolare verso est, come la Russia, per assicurarsi il necessario “spazio vitale”. Questa conquista di terre non è considerata un’offesa a presunti diritti umani universali. Si afferma che i confini tra i popoli sono creazioni umane, mutevoli nel tempo, e che solo la forza possiede il potere di conferire un legittimo diritto su un territorio.Gli strumenti del controllo: propaganda e violenza
La propaganda è considerata uno strumento di importanza cruciale per influenzare e guidare la volontà popolare. Essa si rivolge direttamente alle grandi masse, puntando in modo deciso sul sentimento e sulle emozioni piuttosto che sulla ragione o sull’analisi critica. Per essere efficace, la propaganda deve limitarsi a pochi concetti chiave, semplici e potenti, e ripeterli continuamente senza sosta. È fondamentale non sminuire mai la figura del nemico, ma al contrario, presentarlo sempre come una minaccia terribile e potente. La violenza e il terrore sono visti come armi concrete e pratiche, strumenti pragmatici indispensabili per controllare e sottomettere gli avversari interni ed esterni.La natura strumentale del male
Questa intera visione del mondo si fonda su una logica che definisce il male come puramente strumentale. Le azioni considerate malvagie vengono compiute non per un piacere intrinseco nel fare il male, ma perché ritenute mezzi necessari e utili per raggiungere un determinato fine prestabilito. Questa prospettiva nega la validità di qualsiasi giudizio morale intrinseco alle azioni stesse, considerando l’efficienza e l’utilità pratica come unico parametro di valutazione valido. Una tale logica, portata alle sue estreme conseguenze, conduce inevitabilmente a orrori su vasta scala e a crimini contro l’umanità. Tuttavia, la stessa mentalità si manifesta, sebbene in forme diverse, anche nei piccoli mali che si incontrano nella vita quotidiana. È fondamentale saper distinguere l’abilità tecnica di scegliere i mezzi più efficaci per raggiungere un obiettivo dalla saggezza morale necessaria per scegliere quali obiettivi siano giusti e degni di essere perseguiti.Su quali basi scientifiche si fonda l’idea che la stabilità di uno Stato dipenda dalla purezza razziale e che la mescolanza di sangue porti alla fine delle culture?
Il capitolo poggia la sua intera argomentazione sulla premessa che l’unità e la forza di un popolo siano determinate dalla sua omogeneità razziale e che la “mescolanza di sangue” ne causi il declino. Questa visione è radicalmente smentita dalle moderne scienze. La genetica ha dimostrato l’assenza di basi biologiche per la definizione di “razze” umane distinte e gerarchicamente superiori, mentre l’antropologia e la sociologia evidenziano come la stabilità e la vitalità delle società dipendano da fattori ben più complessi della presunta purezza etnica. Per approfondire la confutazione scientifica e sociale di queste teorie, è consigliabile leggere autori che si sono occupati di genetica delle popolazioni, come Luigi Luca Cavalli-Sforza, e di studi sulla costruzione sociale del concetto di razza e sulle dinamiche sociali, come Émile Durkheim o Franz Boas.2. Il piacere crudele e i suoi limiti logici
La filosofia del Marchese de Sade si basa sulla negazione della morale tradizionale. Sostiene che la natura è indifferente al bene e al male, e che le distinzioni morali sono quindi prive di senso. Questa idea si fonda sull’osservazione che tutto ritorna alla materia naturale senza distinzione di condotta e che gli istinti guidano le azioni umane. Un secondo punto è che le nozioni di vizio e virtù cambiano molto tra culture diverse.Critica alle basi della morale sadiana
Queste argomentazioni presentano errori logici. Il piano morale è distinto da quello naturale o empirico; ciò che accade in natura non stabilisce ciò che è giusto o sbagliato. Inoltre, la varietà delle opinioni su qualcosa tra culture diverse non ne dimostra l’inesistenza o l’assurdità. Le differenze culturali sulle norme morali non annullano l’esistenza di un piano morale distinto dalla semplice descrizione dei comportamenti.Il piacere come motore principale
La ricerca del piacere è il motore principale delle azioni, secondo Sade. Questo piacere non è la quiete, ma l’eccitazione intensa ottenuta dalla gratificazione sfrenata dei desideri. Poiché ci si abitua ai piaceri comuni, è necessario cercare sensazioni sempre più forti, ricorrendo agli orrori per stimolare i sensi. Le regole sociali e morali sono viste come ostacoli a questa ricerca. L’egoismo è considerato la legge fondamentale della natura, giustificando l’indifferenza verso la sofferenza altrui. Questo perché le sensazioni fisiche, come il dolore, sono considerate più autentiche di quelle morali.La crudeltà e la definizione del male
La crudeltà, secondo Sade, offre piaceri più intensi della benevolenza. Questo deriva sia dall’intensità del dolore provato dalla vittima, che si trasmette all’aguzzino, sia dal piacere derivante dalla violazione di divieti e dall’umiliazione altrui. Tuttavia, questa enfasi sul piacere intenso non spiega la natura specifica del male. Il piacere è soggettivo e si trova in molte attività diverse, non solo in quelle considerate malvagie. Dire che il male è ciò che piace non distingue le azioni malvagie da altre attività piacevoli in modo logico.La preferenza per i piaceri crudeli e le sue implicazioni
Un’altra questione riguarda la preferenza tra piaceri. Anche se i piaceri legati alla crudeltà sono intensi, non è detto che tutti li preferiscano a piaceri meno intensi come ascoltare musica o fare carità. Sade suggerisce che le norme sociali distorcono le preferenze naturali. L’idea che la natura umana sia intrinsecamente aggressiva e che le norme sociali la reprimano è un’opinione, non un fatto dimostrato. Questa posizione non fornisce una logica del male, ma solo l’affermazione che il male è ciò che alcuni individui preferiscono, senza spiegare perché questa preferenza debba essere considerata l’essenza del male stesso.Se la logica di Sade è fallace, cosa ci dice davvero la sua ossessione per la crudeltà sulla natura del male?
Il capitolo smonta efficacemente le basi logiche del pensiero sadiano, ma si ferma sulla soglia di un’indagine più profonda: se il male non è solo “ciò che piace intensamente” come suggerisce Sade, qual è la sua vera natura? Il capitolo non esplora a fondo le diverse prospettive filosofiche e psicologiche sul male, lasciando il lettore senza strumenti per comprendere perché la crudeltà eserciti un fascino così perverso, al di là delle giustificazioni logiche fallaci. Per colmare questa lacuna, sarebbe utile esplorare la filosofia morale (Kant, Arendt), la psicologia del male (Zimbardo) e la letteratura che affronta la sua complessità (Dostoevskij).3. L’ombra che divora la luce
Il male non segue un principio organizzato e non ha un piano che si possa capire. Figure come Maldoror, protagonista de I canti di Maldoror, mostrano un male estremo. Questo male è capace di azioni di grande crudeltà, come fare del male a una bambina o provare piacere di fronte a un naufragio. Questa malvagità va oltre la figura tradizionale di Satana. Si manifesta in un desiderio di distruzione totale, puntando a eliminare l’umanità.
Il male come negazione e la sua dipendenza dalla costruzione
A volte, si pensa che il male sia semplicemente il contrario del bene, una specie di specchio senza una propria sostanza. Questa idea di opposizione può far sembrare che bene e male si scambino i ruoli, quasi fossero equivalenti. Ma guardando più a fondo, si capisce che il male, inteso come distruzione, ha bisogno del bene, inteso come costruzione, per esistere. Costruire significa avere un progetto, usare materiali e voler raggiungere un obiettivo. Distruggere, invece, è un’azione di per sé semplice, che aumenta il caos senza bisogno di un piano complicato per l’atto stesso. Anche quando si pianifica un atto distruttivo, come un assassinio, questi piani sono esterni all’idea di distruzione; servono solo a realizzarla. La distruzione ha sempre bisogno di qualcosa che è stato costruito per potersi manifestare, come accadde quando Erostrato diede fuoco al tempio di Artemide.Arte, distruzione e il valore delle sensazioni
Il legame tra arte e distruzione, che si vede in tante opere, fa riflettere su cosa sia il valore estetico. Alcuni artisti, come Antonin Artaud con il suo “teatro della crudeltà”, mettono in risalto sensazioni forti e violente. Lo fanno per scuotere chi guarda dalla noia. Questa visione porta a un’idea di bellezza basata solo sulle sensazioni provate. Però, se il giudizio estetico si basa solo sull’intensità delle sensazioni, si rischia di non distinguere tra esperienze violente ma vuote e opere che, pur mostrando il male, lo elaborano con l’intelligenza. Queste ultime offrono nuove prospettive sulla condizione umana. Il vero valore artistico non viene dalla sola violenza delle sensazioni, ma da come queste vengono pensate ed elaborate. La rappresentazione del male, anche se sconvolgente o capace di suscitare emozioni intense, non mostra una logica nascosta del male in sé. È piuttosto un cercare esperienze emotive molto forti.Se il male è solo un’assenza o una negazione del bene, come spieghiamo la sua forza apparentemente autonoma e la sua capacità di generare sofferenza attiva, non solo per mancanza di bene?
Il capitolo propone una visione del male come “vuoto” concettuale, definito unicamente in relazione al bene. Tuttavia, questa prospettiva rischia di non cogliere la dimensione attiva e generativa del male, la sua capacità di manifestarsi non solo come mancanza, ma come forza distruttiva autonoma. Per approfondire questo dibattito, si possono esplorare diverse correnti filosofiche e psicologiche che hanno cercato di dare al male una maggiore consistenza ontologica o psicologica. Utile è confrontarsi con autori come Hannah Arendt, che ha indagato la “banalità del male”, o con le riflessioni di Immanuel Kant sul male radicale. Anche le prospettive teologiche (come quella agostiniana del male come privazione) e gli studi psicologici sulla psicopatia e l’aggressività possono offrire spunti cruciali per comprendere se il male sia davvero solo un’ombra del bene o possieda una sua oscura vitalità.5. Il Male: Assenza di Forma e Illusione di Libertà
Molti pensano che il male possa mostrare una verità nascosta o dare una specie di libertà. Le azioni malvagie sono fatti veri, che si possono studiare con la psicologia o la sociologia, ma la loro realtà è semplice, come quella di ogni altro evento. Credere che il male smascheri l’ipocrisia e mostri la vera essenza delle persone è un modo di semplificare troppo le cose. Distruggere qualcosa non la rende più vera di quando è stata costruita. Entrambi gli stati sono ugualmente reali. Non tutte le regole della società sono finte; alcune sono utili e buone. Rivelare i difetti non è sempre un bene o una scoperta della verità.Il Male e l’Illusione della Libertà
Si parla di libertà in due modi: come assenza di ostacoli (libertà negativa) e come capacità di agire e decidere (libertà positiva). La libertà negativa, che a volte si lega al male, è in realtà un’illusione. Togliere i limiti esterni può farci finire sotto il controllo di desideri interiori o di forze nascoste. La vera libertà, quella positiva, chiede invece impegno e lo sviluppo delle proprie capacità. Il male non è legato alla libertà in modo profondo; la sua idea di liberazione serve solo a rompere le regole del bene.Il Male, il Coraggio e la Virtù
A volte si pensa che chi fa il male senza esitare abbia qualità positive come il coraggio. Si crede che affrontare le conseguenze o rompere le regole richieda una forza d’animo ammirevole. Tuttavia, l’uso del termine “coraggio” in questo contesto è puramente metaforico e non descrive una vera virtù. Le azioni considerate malvagie nella loro essenza, come l’omicidio, non rientrano nella definizione di virtù morale comunemente accettata. L’ammirazione personale o un giudizio estetico verso atti malvagi non possono in alcun modo stabilire una base morale che giustifichi il male.La Natura Senza Forma del Male
A differenza del bene, il male non possiede una logica interna o una forma coerente che lo definisca. Non si presenta come un ideale alternativo valido al bene. Esiste semplicemente come un insieme di eventi che accadono, spiegabili attraverso relazioni di causa ed effetto, ma la sua essenza è la pura logica della distruzione. È privo di un significato più profondo o di una struttura propria, apparendo come l’assenza di forma. Si può paragonare al sudiciume o alle macerie, che non sono una forma definita, ma piuttosto ciò che resta quando la forma viene distrutta.Questa definizione di male come “assenza” è l’unica possibile, o ignora prospettive che lo vedono come una forza attiva o una complessa realtà psicologica?
Il capitolo definisce il male principalmente per negazione, come pura distruzione e assenza di forma, paragonandolo a macerie o sudiciume. Questa visione, pur legittima e radicata in certe tradizioni filosofiche, non affronta a sufficienza le interpretazioni che considerano il male non solo come privazione, ma anche come una forza attiva, una scelta deliberata, o un fenomeno con radici psicologiche e sociali complesse che possono manifestarsi in forme strutturate (si pensi al male organizzato o ideologico). Per esplorare queste lacune, sarebbe utile approfondire la filosofia (in particolare l’etica e la metafisica del male), la psicologia (per le motivazioni individuali e collettive) e la sociologia (per le manifestazioni strutturate del male nella società). Autori come Sant’Agostino (per la visione del male come privazione), Immanuel Kant (per il concetto di male radicale), Hannah Arendt (sulla banalità del male) o Erich Fromm (sulla distruttività) offrono prospettive diverse e complementari che possono aiutare a comprendere la complessità del fenomeno al di là della semplice assenza.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]