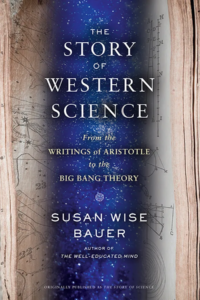1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La storia del mondo antico, Susan Wise Bauer” di Susan Wise Bauer ti porta in un viaggio incredibile attraverso le prime grandi civiltà. Dalla nascita della regalità in Mesopotamia e Egitto, con i faraoni che sfidavano la morte costruendo piramidi e re come Gilgamesh che cercavano l’immortalità, scopri come sono nati i primi governi e le prime città. Il libro esplora l’ascesa e la caduta di imperi potenti come quello accadico, babilonese con Hammurabi e assiro, mostrando come le lotte per il potere, le invasioni e persino i problemi ambientali potessero distruggere tutto. Viaggi anche in Egitto, dalla gloria dell’Antico Regno al caos del Secondo Periodo Intermedio, e in Cina, con le dinastie Xia e Shang che seguono cicli di virtù e corruzione. Vedrai emergere nuove identità, come quella degli Ebrei con Abramo, e scontrarsi grandi potenze come Ittiti, Mitanni ed Egizi. La storia greca, dalle città micenee alle guerre persiane e del peloponneso, e l’ascesa di Roma, dalla repubblica all’impero con figure come Cesare e Augusto, mostrano come le città-stato e le repubbliche si trasformino in dominatori del mondo. È un racconto affascinante di re, battaglie, riforme e come le civiltà affrontano le sfide, dalla fragilità di fronte alla natura al potere trasformativo delle idee e delle religioni.Riassunto Breve
La necessità di organizzare le prime città in Mesopotamia porta alla nascita della figura del re, inizialmente visto come un dono divino per garantire giustizia, ma con il rischio di trasformarsi in tiranno, come mostra l’epopea di Gilgamesh, che affronta anche il limite della mortalità. In Egitto, i faraoni cercano di superare la morte con le piramidi, simboli del loro potere eterno. Le prime civiltà mesopotamiche, come quelle sumere, rimangono spesso divise e deboli, vulnerabili a conflitti interni e invasioni, mentre figure come Sargon di Akkad creano imperi unificati, seppur instabili. Parallelamente, la civiltà Harappa lungo l’Indo sviluppa città pianificate ma scompare misteriosamente. Gli imperi antichi affrontano sfide interne, come il declino del potere faraonico in Egitto dovuto a malcontento e frammentazione, o il crollo dell’impero accadico per invasioni e caos. Fattori ambientali come la salinizzazione del suolo in Mesopotamia o le siccità in Egitto contribuiscono al declino. In questo contesto di instabilità, emergono nuove identità, come quella degli Ebrei con Abramo e il loro Dio unico. La storia mostra un ciclo continuo di ascesa e caduta di imperi e regni. Dopo la caduta di Ur, la Mesopotamia si divide, con città-stato in lotta, fino all’ascesa di Hammurabi di Babilonia che crea un vasto impero basato su un codice di leggi, ma che si disintegra rapidamente dopo la sua morte. In Cina, le dinastie come gli Xia e gli Shang seguono cicli di virtù e corruzione, portando a cambi di potere. Il Medio Regno egizio termina con l’instabilità e l’arrivo degli Hyksos. A Creta, la civiltà minoica, con i suoi palazzi e sacrifici, declina dopo un’eruzione vulcanica. Nuove potenze emergono, come gli Ittiti in Asia Minore e l’Egitto riunificato nel Nuovo Regno, che si scontrano per il controllo della regione. I Mitanni si affermano in Mesopotamia, ma vengono indeboliti da Hittiti ed Egizi. La successione al potere è spesso causa di conflitti e violenza in molte culture. Le città greche iniziano a prosperare, mentre la civiltà minoica declina, e i Micenei prendono il sopravvento. In Egitto, Amenhotep IV introduce una religione monoteista, causando disordini interni e influenzando le relazioni esterne. La battaglia di Kadesh tra Egizi e Ittiti mostra la fragilità del potere basato sulla reputazione. L’impero ittita e l’Egitto affrontano crisi interne ed esterne, mentre l’Assiria emerge come nuova potenza. La fine del Nuovo Regno egizio è segnata da divisioni e l’ascesa dei sacerdoti. L’età oscura colpisce diverse regioni, con invasioni e crolli. In Cina, la dinastia Zhou introduce il concetto del Mandato del Cielo per legittimare il potere, ma affronta la frammentazione. In India, le tribù ariane si espandono, sviluppando una società complessa e affrontando conflitti interni. I Filistei e gli Ebrei si scontrano in Canaan, portando all’elezione del primo re e alla creazione del regno unificato di Israele, che si divide dopo Salomone. L’Assiria si espande con re crudeli, entrando in conflitto con Israele. Le città greche si sviluppano e colonizzano il Mediterraneo, mentre a Roma si passa dalla monarchia alla repubblica. L’impero assiro raggiunge l’apice ma crolla sotto i colpi di Babilonesi e Medi. Nabucodonosor II ricostruisce Babilonia, ma il suo impero cade sotto Ciro il Grande di Persia, che governa con tolleranza. In Cina, leggende parlano di re saggi scelti per virtù. Le guerre persiane vedono le città-stato greche resistere all’impero persiano, ma poi si scontrano tra loro nella guerra del Peloponneso. Roma affronta conflitti interni tra patrizi e plebei e viene saccheggiata dai Galli. In Cina, lo stato di Ch’in si rafforza con riforme militari. Filippo II di Macedonia unifica la Grecia, e suo figlio Alessandro Magno conquista un vasto impero che si frammenta dopo la sua morte. Roma si espande in Italia e poi nel Mediterraneo, scontrandosi con Cartagine nelle guerre puniche, emergendo come potenza dominante. L’impero di Asoka in India cerca l’unità nella virtù ma si disgrega. La dinastia Ch’in unifica la Cina ma crolla rapidamente, seguita dalla dinastia Han. Roma affronta tensioni sociali e guerre civili, portando alla fine della repubblica e all’ascesa di Augusto come primo imperatore. La dinastia Han e l’impero romano affrontano periodi di instabilità, successioni difficili e minacce interne ed esterne. La figura dell’imperatore romano diventa sempre più potente, mentre in Cina si assiste a cicli dinastici e all’influenza di eunuchi. La diffusione del cristianesimo e dello Zoroastrismo mostra il ruolo crescente della religione nell’organizzazione statale. La storia degli imperi è un susseguirsi di ascese, apogei e declini, con il potere che si sposta tra diverse regioni e forme di governo, segnando un ciclo continuo di creazione e distruzione.Riassunto Lungo
1. Nascita della Regalità e Sfida alla Morte
In Mesopotamia, i Sumeri furono i primi a sviluppare il concetto di città, intendendole come centri di civiltà e di progresso. La necessità di organizzare la vita sociale e di gestire le risorse all’interno di queste nuove realtà urbane, protette da imponenti mura, portò all’emergere della figura del re. Questo ruolo, percepito come un dono divino, aveva il compito di garantire la cooperazione e l’amministrazione della giustizia, segnando una netta distinzione con lo stile di vita nomade precedente.L’ambivalenza del potere regale
La figura del re, sebbene essenziale per il mantenimento dell’ordine, poteva facilmente degenerare in tirannia, evidenziando la necessità di un equilibrio nel suo esercizio del potere. L’epopea di Gilgamesh, re di Uruk, incarna perfettamente questa dualità. Da un lato, Gilgamesh è celebrato come un eroe che sfida la morte, un tema centrale nella sua leggendaria ricerca dell’immortalità; dall’altro, la sua storia mette in guardia contro i rischi del potere assoluto. Il viaggio di Gilgamesh si conclude con la consapevolezza e l’accettazione della mortalità, un limite invalicabile anche per i sovrani più potenti. Questo racconto sottolinea come il potere, sebbene indispensabile, debba essere sempre accompagnato dalla giustizia e dalla saggezza.Le piramidi: un’affermazione di immortalità
Parallelamente, in Egitto, i faraoni intrapresero un’altra via per confrontarsi con il tema della morte, erigendo le piramidi come simboli tangibili della loro aspirazione all’immortalità. Il faraone Djoser diede inizio a questa tradizione con la costruzione della prima piramide a gradoni, concepita non come un mero passaggio verso l’aldilà, ma come una dimora eterna per lo spirito del sovrano. Questa visione fu ulteriormente sviluppata dai suoi successori, tra cui Snefru, che si impegnò nella realizzazione di piramidi a facce lisce, e Khufu, sotto il cui regno fu eretta la Grande Piramide. Questi monumenti non erano semplici tombe, ma potenti simboli del potere faraonico e della sua perenne presenza tra il popolo. Le piramidi, quindi, incarnano la ferma volontà dei faraoni di trascendere la morte, affermando la loro esistenza eterna attraverso queste imponenti strutture, testimonianza della determinazione egizia a non soccombere di fronte al potere della morte.Se la regalità in Mesopotamia era vista come un dono divino per garantire cooperazione e giustizia, come si concilia questa visione con la contemporanea aspirazione dei faraoni egizi all’immortalità attraverso la costruzione di piramidi, un atto che sembra più focalizzato sull’auto-esaltazione che sul benessere collettivo?
Il capitolo presenta la nascita della regalità come un fenomeno legato alla necessità di organizzazione e giustizia nelle nascenti città sumere, per poi passare all’analisi delle piramidi egizie come espressione del desiderio di immortalità dei faraoni. Tuttavia, non viene esplorato a fondo il possibile conflitto tra la funzione sociale e comunitaria del re, inteso come amministratore e garante della giustizia, e l’aspirazione individuale all’eternità, che potrebbe essere interpretata come una forma di autocelebrazione. Per approfondire questa apparente contraddizione, sarebbe utile studiare le dinamiche del potere e della religione nelle società antiche, con particolare attenzione all’antropologia culturale e alla sociologia delle religioni. Autori come Mircea Eliade, per quanto riguarda lo studio comparato delle religioni, o Émile Durkheim, per l’analisi sociologica dei fenomeni religiosi, potrebbero fornire spunti interessanti per comprendere meglio il rapporto tra potere, religione e società nell’antichità.2. Ascesa e Caduta di Imperi e Città Antiche
Le città sumere erano caratterizzate da una forte indipendenza. A differenza dei faraoni egizi, i re sumeri non godevano dello stesso potere assoluto. Dopo il regno di Gilgamesh, i regni sumeri rimasero deboli e divisi, segnati da continue lotte intestine tra le città e dalle incursioni degli Elamiti. Lugulannemundu di Adab riuscì a respingere temporaneamente gli Elamiti, ma il suo regno si dissolse rapidamente. Le dispute di confine tra Lagash e Umma portarono a conflitti, e figure come Eannatum di Lagash si distinsero per la loro abilità militare.Le riforme di Urukagina e la conquista di Lugalzaggesi
Urukagina di Lagash tentò di implementare riforme sociali per ridurre la corruzione e la povertà. Queste riforme, tuttavia, lo resero impopolare tra i ricchi e il clero. Il suo regno terminò con la conquista di Lagash da parte di Lugalzaggesi di Umma.L’impero di Sargon di Akkad
Contemporaneamente, Sargon di Akkad, un coppiere di Kish, costruì un vasto impero. La sua storia è avvolta nel mistero, ma è noto che conquistò Sumer, unificando le città in un impero con una nuova capitale, Agade. Sargon sostituì i funzionari sumeri con quelli accadici e creò un esercito permanente. Il suo impero si estese oltre la Mesopotamia, ma fu segnato da continue ribellioni.La civiltà Harappa
Lungo il fiume Indo si sviluppò la civiltà Harappa, con città pianificate e uniformi. Queste città, come Harappa e Mohenjo-Daro, avevano sistemi di drenaggio avanzati e citadelle fortificate. I mercanti di Harappa commerciavano con la Mesopotamia, come testimoniano i ritrovamenti archeologici.Uniformità e mistero della civiltà Harappa
Le città di Harappa mostrano una notevole uniformità nella pianificazione e nella costruzione, suggerendo un controllo centralizzato. Nonostante l’avanzamento tecnologico e l’organizzazione sociale, la civiltà Harappa rimane avvolta nel mistero, senza figure individuali che emergano dalla collettività e senza testi scritti che ne chiariscano la storia e la cultura.Se le riforme di Urukagina erano volte a ridurre la corruzione e la povertà, perché lo resero impopolare tra i ricchi e il clero, portando alla caduta del suo regno? Non è forse una contraddizione?
Il capitolo menziona le riforme di Urukagina come un fattore che contribuì alla sua impopolarità e alla successiva conquista di Lagash. Tuttavia, non viene approfondito il nesso causale tra le riforme, che miravano al benessere sociale, e la reazione negativa dei ceti più abbienti. Per comprendere appieno questa dinamica, sarebbe utile approfondire le discipline della sociologia e della storia economica, con un focus sulle strutture di potere e sulla distribuzione delle ricchezze nelle società antiche. In particolare, si potrebbe esaminare il lavoro di studiosi come Karl Polanyi, che ha analizzato le trasformazioni economiche e sociali nelle civiltà pre-industriali, o di Moses Finley, che ha studiato l’economia e la società del mondo antico. Un’analisi più dettagliata del contesto socio-economico di Lagash e delle specifiche riforme implementate da Urukagina potrebbe chiarire le ragioni della sua caduta.3. Nascita di nuove identità e declino di imperi
In Egitto, i faraoni della IV dinastia, tra cui Khufu e Khafre, edificarono imponenti piramidi, impiegando ingenti risorse e sfruttando il lavoro della popolazione. Questo generò un crescente malcontento che, infine, portò alla caduta del loro potere. Menkaure, figlio di Khafre, tentò di porre rimedio alla situazione, ma il potere dei faraoni era ormai in declino. Con la successiva V dinastia, si assistette a un cambiamento: i faraoni si identificarono sempre più con il dio sole Ra, mentre i sacerdoti acquisirono maggiore influenza. La VI dinastia, caratterizzata da faraoni che sposavano persone comuni, non riuscì a fermare la frammentazione del regno, che si divise in piccoli stati ereditari. La siccità e altri problemi contribuirono al crollo dell’Antico Regno.L’Impero Accadico e la III dinastia di Ur
L’impero accadico, sotto la guida di Naram-Sin, si espanse notevolmente, ma dovette affrontare l’invasione dei Gutiani, considerati barbari e distruttori. Questa invasione portò caos e distruzione, culminando con la caduta di Agade e la fine dell’impero accadico. Dopo decenni di dominio Gutiano, le città sumere si ribellarono. Gudea di Lagash e Utuhegal di Uruk liberarono le città e, successivamente, Ur-Nammu fondò la III dinastia di Ur, un nuovo impero sumero basato su leggi e trattati. Mentre Shulgi, successore di Ur-Nammu, consolidava il suo impero, anch’esso basato su leggi e trattati e sulla sua figura scelta dagli dei, le città di Canaan erano in conflitto tra loro.La storia di Abramo
In questo periodo, Abramo lasciò la città di Ur per seguire un nuovo Dio, YHWH, che gli promise una grande nazione, separandolo dagli altri Semiti. Abramo si diresse verso Canaan, una terra priva di un’identità politica o razziale definita, abitata da Semiti occidentali. A causa di una carestia, la sua famiglia si trasferì in Egitto, dove Abramo presentò sua moglie Sarai come sua sorella. Dopo essere tornati a Canaan, Abramo ebbe un figlio con la serva Agar, ma la promessa di Dio si compì con la nascita di Isacco da Sarai. La famiglia di Abramo, costretta a comprare un terreno per seppellire Sara a causa dei conflitti tra le città di Canaan, si distinse dagli altri popoli. La circoncisione divenne un segno di questa separazione e della nascita di una nuova identità, basata sulla promessa di un unico Dio.Se la promessa di un unico Dio, YHWH, ad Abramo, e la conseguente circoncisione, segnano la nascita di una nuova identità, come si concilia questo con la precedente menzione di faraoni che si identificano con il dio sole Ra, e la fondazione di un impero sumero “basato su leggi e trattati e sulla sua figura scelta dagli dei” da parte di Shulgi? Non si tratta forse anche in questi casi di identità basate sulla figura di un unico dio o di un prescelto?
Il capitolo, pur delineando la nascita di nuove identità e il declino di imperi, sembra porre un’enfasi particolare sulla vicenda di Abramo e la promessa di YHWH come momento fondante di una nuova identità. Tuttavia, la narrazione precedente menziona già la tendenza dei faraoni a identificarsi con il dio sole Ra e la figura di Shulgi come prescelto dagli dei. Questo solleva un interrogativo sulla reale unicità dell’esperienza abramitica. Per approfondire la questione, sarebbe utile analizzare più a fondo il concetto di identità nelle civiltà antiche, con particolare attenzione al rapporto tra religione, potere e organizzazione sociale. Si consiglia di consultare studi di antropologia religiosa e di storia delle religioni, con un focus sul Vicino Oriente antico. Autori come Mircea Eliade, per un’analisi comparata dei fenomeni religiosi, o Jan Assmann, per le sue ricerche sulla religione egizia e il concetto di “distinzione mosaica”, potrebbero offrire spunti interessanti. Inoltre, un approfondimento sulla figura di Shulgi e sul contesto socio-politico della III dinastia di Ur, attraverso lo studio di specialisti di sumerologia come Piotr Michalowski, potrebbe chiarire le specificità di questa identità “scelta dagli dei”.Capitolo 4: La Fragilità della Civiltà e il Potere dell’Acqua
Le antiche civiltà sono segnate da storie di grandi inondazioni. I racconti di un diluvio universale sono presenti in diverse culture, dalla Mesopotamia all’Egitto, fino alle Americhe. Queste storie suggeriscono un’antica paura dell’acqua, vista sia come fonte di vita che come forza distruttiva. Le inondazioni, reali o mitologiche, hanno plasmato la storia e la cultura umana, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.Il crollo dell’impero sumero
L’impero sumero, un tempo prospero, crolla a causa di problemi ambientali e conflitti interni. L’irrigazione, essenziale per l’agricoltura, porta alla salinizzazione del suolo, rendendo la terra sterile. La scarsità di cibo indebolisce l’impero, che diventa vulnerabile agli attacchi esterni. La situazione peggiora quando un comandante di nome Ishbi-Erra si ribella, prendendo il controllo di importanti città. Infine, gli Elamiti distruggono Ur, segnando la fine della civiltà sumera.La riunificazione dell’Egitto
Contemporaneamente, in Egitto, un periodo di disordini e divisioni precede l’ascesa di Mentuhotep I, che riunifica il paese. Dopo anni di conflitti, Mentuhotep riesce a ristabilire l’ordine, dando inizio al Medio Regno. La successione al trono diventa meno legata alla discendenza divina, con Amenemhet I, un uomo di umili origini, che fonda una nuova capitale e si pone come un nuovo unificatore. La sua storia è segnata da una profezia che lo descrive come un salvatore, e da un assassinio che porta al potere suo figlio, Senusret I. Le civiltà, nonostante i loro sforzi, rimangono vulnerabili di fronte alle forze della natura.Se la concessione della cittadinanza romana a tutti gli uomini liberi dell’impero da parte di Caracalla fu dettata da esigenze fiscali, come mai il capitolo la presenta come un evento che segna la perdita di significato dell’identità romana? Non si tratta forse di una forzatura ideologica, volta a demonizzare l’estensione dei diritti?
Il capitolo sembra suggerire una correlazione tra l’estensione della cittadinanza romana e la perdita di identità, senza però approfondire le motivazioni di tale declino. Si limita a menzionare le “esigenze fiscali” di Caracalla, tralasciando di analizzare le complesse dinamiche sociali e culturali che portarono alla trasformazione dell’identità romana. Per comprendere appieno questo passaggio cruciale, sarebbe utile approfondire discipline come la sociologia delle migrazioni e la storia delle istituzioni politiche, con particolare attenzione agli studi di autori come Edward Gibbon, per un’analisi più classica, o di Peter Brown, per una prospettiva più antropologica.29. Imperi e Dei: Ascesa e Caduta del Potere
L’Egitto e la Divinizzazione del Potere
Nell’antico Egitto, la prima dinastia vede l’ascesa dei faraoni, elevati a figure divine. Il loro potere è sottolineato da sacrifici umani, che ne rafforzano lo status ultraterreno. La teologia egizia associa il faraone al dio Horus, il re dei vivi, e dopo la morte a Osiride, re dell’oltretomba. Il titolo di “nesu-bit” indica il faraone come detentore del potere divino e mortale, unendo così il cielo e la terra sotto un’unica figura.Crisi e Rinascita
La seconda dinastia è segnata da una crisi profonda. Una diminuzione delle inondazioni del Nilo porta carestia e instabilità, mentre una guerra civile divide il nord e il sud del paese. In questo contesto, il re Sekemib si schiera con Set, dio del caos e della distruzione, riflettendo le tensioni regionali e la lotta per il potere. La situazione cambia con l’ascesa di Khasekhemwy, un re del sud che riesce a riunificare l’Egitto. Adottando un nome che onora sia Horus che Set, Khasekhemwy simboleggia la riconciliazione delle fazioni opposte e la restaurazione dell’ordine. Con il suo regno, i sacrifici umani vengono aboliti, segnando una trasformazione nella natura del potere faraonico. Tuttavia, la lotta tra Horus e Set continua nei miti, rappresentando una costante minaccia all’ordine e alla stabilità del regno.La Persia Sasanide e la Sfida a Roma
Nel 222 d.C., l’impero persiano dei Sasanidi si riorganizza sotto la guida di Ardashir I. Egli instaura lo Zoroastrismo come religione di stato, unendo il popolo in una lotta contro il male e creando una nuova identità nazionale. Questa nuova Persia, forte e coesa, lancia una sfida all’impero romano, già indebolito da invasioni gotiche e lotte interne per il potere. La cattura dell’imperatore Valeriano da parte dei persiani simboleggia la fragilità di Roma e la crescente potenza dei Sasanidi.La Tetrarchia e la Cristianizzazione dell’Impero Romano
Diocleziano, per salvare l’impero dalla crisi, lo divide tra più imperatori, creando una tetrarchia. Questa mossa, sebbene inizialmente efficace nel ristabilire l’ordine, non impedisce nuove lotte per il potere tra i vari imperatori. In questo contesto emerge la figura di Costantino, che adotta il cristianesimo dopo una visione e sconfigge il rivale Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio. La conversione di Costantino segna una svolta epocale, trasformando l’impero romano in qualcosa di nuovo, basato su una fede religiosa monoteista.Se la divinizzazione del potere, come dimostrato dai faraoni egizi, è stata messa in discussione da eventi come carestie e guerre civili, perché il capitolo non approfondisce come mai, in seguito, imperi come quello romano hanno continuato ad adottare strategie simili, come l’associazione del potere a figure divine o la cristianizzazione sotto Costantino?
Il capitolo sembra suggerire una progressione lineare dall’uso del potere divino in Egitto alla sua trasformazione sotto l’impero romano, senza però affrontare adeguatamente le contraddizioni e le complessità di questo processo. Per esempio, non viene menzionato come la divinizzazione dell’imperatore fosse una pratica comune a Roma ben prima di Costantino, e come questa si intrecciasse con le dinamiche politiche e sociali dell’epoca. Per comprendere meglio queste dinamiche, sarebbe utile approfondire gli studi di storici come Mary Beard o Peter Brown, che hanno analizzato in dettaglio la religione e il potere nell’antica Roma, o ancora gli studi di egiptologia di Jan Assmann. Inoltre, un’analisi più approfondita delle motivazioni dietro la conversione di Costantino, al di là della semplice visione, potrebbe arricchire la discussione, considerando il contesto politico e strategico dell’epoca.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]