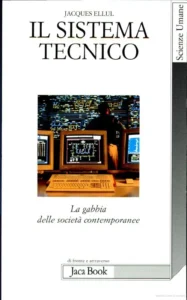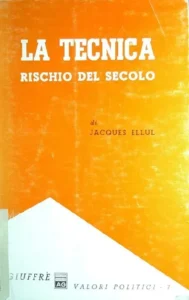Contenuti del libro
Informazioni
“La sovversione del cristianesimo” di Jacques Ellul è un libro che ti fa pensare parecchio su come il cristianesimo, quello che vediamo oggi o nella storia, si sia allontanato un sacco dal messaggio originale di Gesù e Paolo. Ellul non dice che è solo un po’ diverso, ma che è proprio una subversione, un ribaltamento. Invece di restare quella forza radicale che sfidava il potere e il denaro, la chiesa storica si è istituzionalizzata, diventando una religione con regole rigide e alleata con lo stato (la politicizzazione cristianesimo). L’autore analizza come la fede si sia trasformata in morale cristiana, perdendo un po’ quella libertà e quell’amore al centro del vangelo. Parla anche di come influenze esterne, tipo l’influenza islam cristianesimo in certi periodi, abbiano spinto verso un’enfasi sul diritto o sulla guerra santa, cose lontane dalle cristianesimo origini. Ellul arriva a dire che, paradossalmente, certe derive cristiane hanno persino contribuito al nichilismo moderno. Non dimentica il ruolo di quelle che chiama potenze spirituali, forze che agiscono nel mondo attraverso cose come il denaro o lo stato per corrompere il messaggio. Però, nonostante questa subversione del cristianesimo, il libro suggerisce che qualcosa del vero messaggio resiste, spesso in modo nascosto, al di fuori delle grandi istituzioni. È una critica forte, ma che cerca di capire perché le cose sono andate così e cosa resta del vero.Riassunto Breve
Il cristianesimo, nato come forza che metteva in discussione il potere, il denaro e le religioni esistenti, proponendo una morale nuova e radicale, ha subito nel tempo una trasformazione profonda, allontanandosi dai principi originari di Gesù e Paolo. Questa non è una semplice evoluzione, ma una vera e propria sovversione. Inizialmente, il messaggio biblico promuoveva la desacralizzazione del mondo, vedendo la creazione come profana e disponibile all’uomo, con il sacro riservato solo alla relazione tra l’uomo e un Dio trascendente. Tuttavia, con la crescita e l’istituzionalizzazione, il cristianesimo ha reintrodotto elementi sacri in luoghi, tempi e oggetti, e ha trasformato la fede, basata sull’amore e la libertà, in un sistema rigido di norme morali, spesso usato per controllo sociale, portando anche a visioni che emarginavano la donna. L’influenza di altre culture, come l’Islam, ha contribuito a questa deviazione, introducendo concetti come il diritto religioso, la guerra santa (trasformata in crociata) e l’idea di sottomissione totale a Dio, estranei alla libertà e non-violenza evangelica. La politicizzazione iniziata con Costantino ha ulteriormente pervertito il messaggio, alleando la Chiesa con lo Stato e trasformando il simbolo della croce da segno di sconfitta a simbolo di potere militare. Questa deriva ha portato il cristianesimo a giustificare il potere, a diventare esso stesso una struttura di potere e a frammentarsi. Nonostante il suo messaggio sia intrinsecamente antinichilista, basato su creazione, senso della storia e speranza, il cristianianesimo storico ha paradossalmente contribuito al nichilismo attraverso interpretazioni che svalutano il mondo terreno, rimuovono limiti allo sfruttamento e generano pessimismo sull’uomo, perché la radicalità originale della grazia gratuita, della giustificazione divina e del rifiuto della forza risulta difficile da accettare per l’orgoglio umano. Potenze spirituali come il denaro, lo Stato, la menzogna e la divisione agiscono per corrompere la Chiesa e ostacolare l’amore di Dio nel mondo. Nonostante queste deviazioni e tradimenti, il cristianesimo persiste, sostenuto dalla fedeltà divina e dall’opera discreta dello Spirito Santo. La verità riemerge attraverso figure di pensatori, movimenti popolari e la fede semplice, e la Parola di Dio mantiene la sua potenza trasformatrice anche all’interno di istituzioni imperfette, riaprendo la via all’Eterno.Riassunto Lungo
1. Le Catacombe del Successo
Lo sviluppo della comunità cristiana e della Chiesa ha creato una civiltà e una cultura molto diverse dagli insegnamenti della Bibbia e dai principi di Gesù e Paolo. Questa differenza non è solo un piccolo allontanamento, ma una vera e propria trasformazione opposta. In altre religioni o sistemi di pensiero, i cambiamenti negativi possono essere visti come sviluppi di idee già presenti all’inizio. Nel cristianesimo, invece, questa contraddizione è più profonda e inaspettata.Il messaggio originale del cristianesimo
All’inizio, il cristianesimo era una forza che andava contro il potere dei soldi, contro l’autorità politica e contro le religioni già esistenti. Proponeva un modo di vivere completamente nuovo. Con il passare del tempo, però, il cristianesimo è diventato una religione organizzata, con le sue regole, le sue credenze e una morale spesso rigida e tradizionale. In questo modo, si è allontanato dallo spirito rivoluzionario che aveva all’inizio. Il cristianesimo, nella sua forma storica, ha finito per accettare e difendere le strutture di potere e le regole della società, diventando portatore di valori comuni invece di essere un motore di cambiamento radicale.I fattori che hanno portato al cambiamento
Diversi fattori hanno causato questo cambiamento di direzione.La diversa interpretazione della Rivelazione
Un cambiamento molto importante è avvenuto nel modo di capire la Rivelazione. Si è passati da una visione storica a una filosofica, interpretando i testi biblici con le categorie del pensiero greco.Il successo e la crescita del cristianesimo
Il successo e la grande diffusione del cristianesimo hanno portato alla creazione di istituzioni e alla necessità di controllare grandi gruppi di persone. Questo ha compromesso il messaggio originale di libertà e di impegno personale.Le difficoltà interne al messaggio cristiano
Infine, alcune difficoltà e contraddizioni interne al messaggio cristiano, come la richiesta di essere perfetti e l’idea di un Dio apparentemente contraddittorio, hanno reso difficile mantenere intatta la forza rivoluzionaria del messaggio evangelico. Queste difficoltà hanno aperto la strada a nuove interpretazioni e adattamenti.La responsabilità umana nella trasformazione
In conclusione, la trasformazione del cristianesimo in qualcosa di diverso dal suo messaggio originale sembra essere una scelta umana. È stata una risposta alle sfide della storia e alla difficoltà di vivere pienamente il messaggio radicale del Vangelo. I cristiani, pur avendo ricevuto lo Spirito Santo, hanno preferito seguire strade più facili e accettate dal mondo, tradendo così l’essenza rivoluzionaria della Rivelazione.Ma è realmente corretto parlare di un unico “messaggio originale” del cristianesimo, quando già nei testi neotestamentari si riscontrano diverse interpretazioni e sfumature dottrinali?
Il capitolo presenta una visione un po’ semplicistica delle origini cristiane, quasi idealizzando un ipotetico “cristianesimo originario” puro e incorrotto. Per rispondere alla domanda, sarebbe utile approfondire la storia del cristianesimo delle origini, studiando autori come Bart Ehrman, e analizzando criticamente le diverse correnti teologiche presenti già nel Nuovo Testamento, come evidenziato negli studi di Rudolf Bultmann. Inoltre, l’analisi sociologica delle prime comunità cristiane, come proposto da Gerd Theissen, potrebbe fornire un quadro più complesso e sfumato.2. La Svolta Morale
Il concetto di sacro
In ogni società, il sacro si manifesta come un insieme di valori attribuiti a esperienze, oggetti e riti. Questi elementi sono visti come speciali e separati dall’uso comune, e sono considerati fonte di ordine e significato per la comunità.La critica al sacro nelle religioni ebraiche e cristiane
L’ebraismo e il cristianesimo primitivo hanno introdotto un cambiamento importante rispetto a questa visione del sacro. Queste religioni hanno criticato il sacro pagano, con l’obiettivo di desacralizzare la natura e le forze naturali. Secondo questa nuova prospettiva, Dio è trascendente e separato dal mondo, che diventa quindi profano e disponibile per l’uomo. Solo l’essere umano, nella sua relazione con Dio, assume una dimensione sacra.Il ritorno del sacro nel cristianesimo
Nonostante l’idea iniziale di desacralizzazione, nel cristianesimo si è verificato un graduale ritorno al sacro. L’arrivo di nuove persone convertite ha portato con sé tradizioni e modi di pensare precedenti. Queste nuove influenze hanno modificato l’aspetto delle chiese, il modo di concepire il tempo e gli spazi dedicati al sacro. Luoghi, momenti e oggetti usati nelle cerimonie religiose hanno riacquistato un carattere sacro. Inoltre, è stata reintrodotta la figura del sacerdote come intermediario tra Dio e i fedeli, allontanandosi dall’idea originaria di una desacralizzazione radicale.La trasformazione della fede in morale
In parallelo, la fede cristiana ha subito una trasformazione, diventando sempre più una questione di morale. Il messaggio cristiano, che in origine era un annuncio di libertà e amore, si è trasformato in un sistema rigido di regole e divieti. La Chiesa, di fronte ai problemi di immoralità nella società e al grande numero di persone che si convertivano, ha utilizzato la morale come strumento per mantenere il controllo e l’ordine. Questa svolta verso la morale ha però rappresentato un allontanamento dal vero messaggio del Vangelo, che metteva l’amore al di sopra della legge e considerava la libertà un elemento centrale dell’esperienza cristiana.Le conseguenze della morale: la svalutazione della donna
L’importanza eccessiva data alla morale ha avuto conseguenze profonde, tra cui una visione negativa nei confronti delle donne. La mentalità moralista, identificata con i valori maschili di legge e giudizio, ha portato a mettere le donne in una posizione marginale. Le qualità femminili, come la compassione e la cura, sono state subordinate a un rigido codice morale. Questo ha rappresentato un ulteriore tradimento dello spirito originario del Vangelo, allontanando la Chiesa dalla sua vera vocazione spirituale.È corretto affermare che la “svolta morale” sia un tradimento dello spirito originario del Vangelo, o è piuttosto una sua inevitabile evoluzione storica di fronte alle sfide sociali?
Il capitolo sembra presupporre una netta contrapposizione tra il messaggio evangelico originario e la successiva “svolta morale”, quasi fossero due entità inconciliabili. Tuttavia, è necessario considerare se questa trasformazione sia stata una deviazione o piuttosto una risposta, seppur problematica, alle complesse dinamiche sociali e storiche. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire la storia del cristianesimo e la sociologia della religione, per comprendere meglio come le istituzioni religiose si adattano e cambiano nel tempo. Autori come Peter Berger potrebbero offrire spunti interessanti in tal senso.3. I Sentieri Tortuosi della Fede
Influsso dell’Islam sul Cristianesimo
L’influenza dell’Islam sul cristianesimo è un aspetto storico spesso trascurato, soprattutto per il periodo compreso tra il IX e l’XI secolo. In questi secoli, anche se si pensava che il mondo cristiano fosse minacciato dall’espansione islamica, in realtà ci fu un importante scambio di cultura tra le due civiltà. Questo scambio culturale non riguardò solo la filosofia e la scienza, con l’arrivo in Europa delle opere di Aristotele grazie ai commenti di filosofi islamici come Averroè e Avicenna. L’influsso islamico si estese anche ad altri campi, come le arti esoteriche, la musica, le tecniche militari e perfino l’agronomia, cioè le tecniche per coltivare i campi. Alcuni studiosi pensano che questo contatto ebbe conseguenze profonde anche nel diritto e nella teologia cristiana. Ad esempio, si è ipotizzato che alcune parti del diritto della Chiesa, chiamato diritto canonico, e le regole che riguardavano la condizione dei servi della gleba, possano avere avuto origine da modelli islamici.Il contrasto tra Islam e Cristianesimo
L’Islam presenta una visione di Dio molto diversa da quella cristiana. Nell’Islam, Dio è visto soprattutto come un giudice severo e onnipotente. Inoltre, l’Islam unisce in sé la religione, la politica e il diritto in modo molto stretto. Questa concezione è molto diversa dalla Rivelazione cristiana, che invece si basa sull’amore di Dio e sulla sua grazia, cioè sul suo perdono gratuito. Nonostante queste differenze profonde, il cristianesimo in alcuni periodi storici ha imitato l’Islam, arrivando a dare molta importanza ad aspetti come il diritto religioso e l’idea di guerra santa. Questi concetti erano in realtà estranei al messaggio originale del Vangelo. Ad esempio, l’idea islamica di Jihad, cioè di lotta per la fede, ha trovato un’eco nell’idea cristiana di crociata, la guerra combattuta in nome della religione. In questo modo, il principio evangelico della non-violenza è stato messo da parte.La devozione e la mistica
Un altro cambiamento importante riguarda il modo di vivere la fede e il rapporto con Dio. L’Islam insegna una sottomissione completa alla volontà di Dio. Questa idea è entrata anche nel cristianesimo, allontanandolo dall’idea di libertà e di dialogo con Dio che si trovano nella Bibbia. La mistica, cioè la ricerca di un contatto diretto e profondo con Dio attraverso esperienze interiori, è molto importante nell’Islam. Anche la mistica è entrata nel cristianesimo, anche se non faceva parte dell’essenza originaria del messaggio biblico, che invece dava più importanza all’ascolto della Parola di Dio e all’impegno attivo nel mondo.La politicizzazione del Cristianesimo
Un punto di svolta nella storia del cristianesimo è stata la sua politicizzazione, iniziata con l’imperatore Costantino nel IV secolo. Questo cambiamento ha rappresentato una vera e propria perversione del messaggio cristiano. La croce, che in origine era il simbolo della sconfitta e dell’umiliazione di Gesù, è stata trasformata in un simbolo di vittoria militare e di potere politico. La Chiesa, attratta dal potere, si è alleata con lo Stato, dimenticando il rifiuto di Gesù di fronte alle tentazioni di potere e ricchezza. Questa alleanza ha portato la Chiesa a giustificare il potere politico, a diventare essa stessa una sorta di stato, e a dividersi in molte chiese nazionali, ognuna sottomessa al potere politico del proprio paese. Questa trasformazione è stata completata dalla contaminazione con il diritto e con il modo di amministrare tipico dello stato. La Chiesa ha adottato modelli organizzativi statali e ha dato più importanza alle leggi umane che alla verità del Vangelo. Tutto questo percorso storico ha segnato un allontanamento dalla forza di cambiamento che il Vangelo aveva in origine. Il cristianesimo si è trasformato in una religione che si adatta al mondo, diventando conformista, oppure in una ricerca di spiritualità separata dalla vita concreta. Entrambe queste trasformazioni rappresentano una distorsione del messaggio originale di Gesù.Se le azioni umane sono guidate da queste entità spirituali invisibili, come possiamo distinguere tra questa interpretazione e spiegazioni sociologiche o psicologiche del comportamento umano?
Il capitolo presenta una visione del mondo in cui forze spirituali occulte influenzano le azioni umane, ma non offre un metodo chiaro per distinguere questa interpretazione da analisi sociologiche o psicologiche. Per comprendere meglio le dinamiche sociali e individuali, è utile approfondire discipline come la sociologia della religione e la psicologia sociale. Studiare autori classici della sociologia, come Durkheim o Weber, può fornire strumenti concettuali per analizzare le istituzioni religiose e il comportamento umano in modo più empirico e meno speculativo.6. Radici e Critiche del Pensiero Cristiano
Millenarismo e testi biblici
È sbagliato considerare superficialmente lo studio dei millenarismi come fenomeni sociali comuni e privi di originalità. In realtà, questi movimenti, spesso legati ad annunci di catastrofi e futuri regni ideali, hanno origini profonde nei testi biblici. Questi testi sono la fonte principale da cui sono nate diverse interpretazioni, a volte anche distorte.La complessità della figura di Las Casas
La vicenda di Las Casas è un esempio significativo di questa complessità. Sebbene sia stato accusato, in parte giustamente, di aver promosso l’uso di schiavi africani in America Latina, è fondamentale considerare come il suo pensiero si è evoluto nel tempo. Dopo aver compreso le terribili conseguenze della schiavitù, Las Casas condannò fermamente questa pratica, tornando indietro rispetto al suo errore iniziale. La sua storia è stata spesso manipolata per attaccare la fede cristiana, nascondendo il suo impegno totale nella difesa della libertà religiosa e dei diritti umani. Las Casas arrivò persino ad affermare che era preferibile un indigeno pagano vivo piuttosto che un cristiano morto. L’opposizione che figure come Las Casas e i Gesuiti dovettero affrontare, fino a vedere il loro lavoro nascosto, nasceva proprio dalla loro critica radicale verso le istituzioni religiose del tempo.La critica di Amery e la risposta del pensiero cristiano
Lo scrittore Amery critica duramente i cristiani che cercano la verità nell’arte e nella letteratura, considerandoli persone che vivono fuori dalla realtà, senza valori concreti e legate a un passato idealizzato. Questa critica ignora figure importanti del pensiero cristiano moderno. Tuttavia, rifiutare completamente l’ebraismo e il cristianesimo appare una semplificazione eccessiva e poco utile. Infatti, ciò che conta non sono solo i risultati materiali, ma anche le aspirazioni e gli ideali che hanno guidato la storia.Teologie della liberazione: un’analisi critica
Le teologie della rivoluzione e della liberazione, pur nascendo da movimenti popolari con motivazioni religiose e bibliche, non possono essere considerate vere e proprie teologie elaborate. Si tratta piuttosto di espressioni legate a situazioni politiche e sociali specifiche, difficilmente applicabili in contesti occidentali. Anche se la loro devozione può essere apprezzabile, l’uso di idee marxiste per interpretare la Bibbia è sbagliato e fuorviante, portando a un utilizzo strumentale di temi religiosi.Regno dei Cieli e Regno di Dio: due concetti distinti
Infine, è importante distinguere tra il Regno dei Cieli e il Regno di Dio. Il Regno dei Cieli si manifesta nella storia e nel mondo reale, creando dinamiche e principi specifici, diversi dall’idea puramente spirituale del Regno di Dio.Se le teologie della liberazione sono liquidate come “non vere teologie” a causa delle loro origini e influenze marxiste, non si rischia di ignorare le specifiche situazioni sociali e politiche che hanno generato tali movimenti, riducendo la teologia a un esercizio puramente accademico e decontestualizzato?
Il capitolo sembra liquidare frettolosamente le teologie della liberazione, concentrandosi sulla critica all’uso di idee marxiste. Tuttavia, per comprendere appieno questi movimenti, sarebbe utile esplorare il contesto storico e sociale specifico in cui sono nati, approfondendo le dinamiche politiche e le ingiustizie che hanno spinto alla loro formulazione. Studiare autori come Gustavo Gutiérrez, uno dei principali esponenti di queste teologie, e confrontarsi con analisi sociologiche delle religioni e teorie politiche, potrebbe offrire una comprensione più completa e sfumata della questione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]