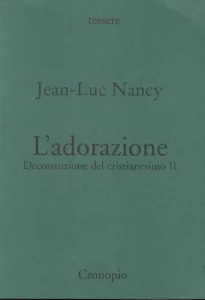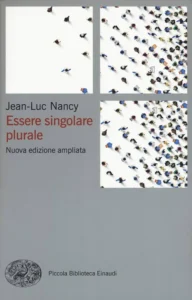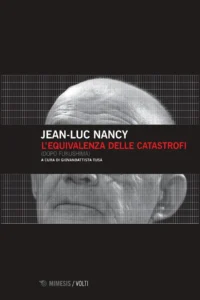1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
RISPOSTA: “La sofferenza è animale” di Jean-Luc Nancy è un libro che ti fa guardare in modo completamente nuovo al rapporto tra noi e gli animali, ma anche a noi stessi. Non è solo una questione morale, ma un vero e proprio scavo nella nostra “animalità”, quella parte istintiva e vitale che spesso ci mette a disagio e ci fa provare angoscia esistenziale. Nancy esplora la “questione animale” andando oltre i soliti confini, mostrando come lo sfruttamento animale e la nostra idea di distinzione tra umano e animale siano legati a come pensiamo la vita, il corpo e la comunità. Non ci sono personaggi o luoghi specifici, è un viaggio nel pensiero filosofico contemporaneo che mette in discussione concetti come l’essere-insieme, la finitezza e il partage, cioè quel condividere uno spazio senza fondersi. L’autore ci invita ad ascoltare la “non-parola” dei corpi senzienti e a riconoscere una comune sofferenza animale che ci lega a tutti i viventi, spingendoci a ripensare la nostra umanità e la giustizia verso ogni forma di vita.Riassunto Breve
L’idea di “animalità” porta con sé un senso di selvatichezza e aggressività, anche se la filosofia si interessa sempre più agli animali. Questa connotazione negativa non colpisce l’animale in sé, ma il concetto di animalità, che genera inquietudine. L’animalità deriva dal latino e significa ciò che è animato da un soffio vitale, una forza che fa vivere e che precede la coscienza. La vita è un respiro continuo, un’esperienza. L’animalità si vede in comportamenti come l’agguato, la cura del corpo, le funzioni del corpo, e l’uomo riconosce in questi tratti una parte di sé, provando fastidio. L’inquietudine umana è diversa da quella animale, è un’angoscia che nasce dalla difficoltà di capire i propri istinti e dalla consapevolezza della morte. L’esistenza è animazione, un soffio presente in ogni forma di vita, e questa vitalità senza limiti preoccupa l’uomo, che si sente escluso e angosciato dalla morte e dall’irrazionalità della vita, pur sentendo l’eco dell’animalità dentro di sé. C’è un’animalità comune che si manifesta in modi diversi, unendo uomini e animali nella ricerca di una vita difficile da afferrare.La “questione animale” va oltre la morale, toccando le basi della filosofia e della politica occidentali. La divisione tra umano e animale, vista come un grande distacco, è fondamentale per ripensare la filosofia e la società, che si basa sullo sfruttamento degli animali, specialmente quello terribile di oggi. Pensare agli animali porta a chiedersi cosa facciamo noi umani e come ci relazioniamo con il mondo, che è diventato un “cantiere”. L’allevamento e il consumo industriale di animali hanno effetti negativi sulla nostra salute, sensibilità ed etica. Quindi, la questione animale è profondamente umana.La filosofia di oggi dice che non siamo soggetti isolati, ma che le relazioni e ciò che viene prima dell’individuo sono importanti. Se siamo legati agli animali per cultura ed evoluzione, escluderli dalle nostre relazioni sembra sbagliato. La storia umana è piena di legami con il vivente, come mostrano i totem e l’arte antica. Questo fa capire che i problemi attuali con gli animali vengono da grandi cambiamenti nella civiltà occidentale. La vita, sia animale che vegetale, è un essere diversi e una relazione tra esseri viventi, un continuo cambiare sé stessi e gli altri. Il “sé” è sempre diverso da sé. La vita è una continua sopravvivenza senza un’identità fissa, sempre in cambiamento. L'”essere-insieme” riguarda tutti gli esseri, umani, animali, vegetali, anche quelli non vivi o immaginari, superando l’idea di gruppi chiusi. Questa visione mette in discussione la vecchia divisione e gerarchia tra umani e animali, suggerendo una differenza che non significa che uno sia superiore all’altro.Pensare all’animale è cambiato, passando da poco interesse a un ascolto attento. Si cerca di prendere un “punto di vista animale”, ascoltando il loro modo di comunicare senza parole, superando la barriera del linguaggio umano. Questa prospettiva invita a considerare tutti i corpi che sentono sullo stesso piano, superando le gerarchie e riconoscendo un’esposizione animale che è comune a tutti i viventi. Il corpo, umano e animale, è un luogo di contatto, di passaggio e di desiderio, non qualcosa di separato. Gli animali partecipano pienamente a questo gioco del corpo e del desiderio. L’idea di specie, come quella di razza o sesso, può essere vista come qualcosa che limita. La differenza tra uomo e animale, spesso basata sul linguaggio, viene messa in discussione. Il linguaggio, invece di fissare le differenze, dovrebbe servire a non fissarle, permettendo un continuo cambiamento.La riflessione di Derrida sul fatto che agli animali sia negato l’habeas corpus e l’habeas corpse è importante. L’idea che gli animali non muoiano davvero o che la loro morte non sia importante viene contestata. La morte animale è reale e ha significato. La politica, intesa come il modo di gestire l'”essere-con”, deve tenere aperta la comunità, evitando chiusure e gerarchie. La comunità esiste da sempre, va oltre l’umano e si muove sempre, cercando e perdendosi senza fine. Il linguaggio, visto spesso come il confine tra umano e animale, deve essere ripensato. Nonostante quello che sappiamo dall’etologia, si continua a definire il linguaggio in modo da escludere gli animali dal mondo dei simboli. Si propone di vedere il linguaggio come un sistema di segni-traccia, una comunicazione non per forza verbale, fatta di richiami, risposte, inviti. Il linguaggio diventa così un altro nome per il “partage”, il condividere un senso comune.Il divenire animale, un concetto di Deleuze, può essere un modo per creare una lingua “minore”, che si apre ai linguaggi animali e crea una comunità aperta. Pensare all’animalità porta a chiedersi chi siamo noi umani: siamo mai stati davvero umani? Dobbiamo ancora diventarlo? La sofferenza degli animali è fondamentale. Opere d’arte antiche e moderne mostrano la forza, la dolcezza, il desiderio e soprattutto la sofferenza animale, che rivela la sofferenza come qualcosa di universale tra i viventi.La comunità non è qualcosa che gli esseri possiedono o un legame che li unisce, ma lo spazio dove si mostrano gli uni agli altri, definendo i loro limiti. Non è una sostanza comune o uno sfondo condiviso, ma l’esperienza di esserci insieme, del comparire delle singolarità. Questo “in comune” è un “partage”, una divisione di un niente in comune, che permette il contatto e la comunicazione senza mescolarsi del tutto. L’idea di comunità come qualcosa da costruire, che cerca di fondersi, è dannosa perché annulla lo spazio necessario dell'”essere-con”.Il mondo, in questa visione, non dipende da significati esterni. La fine dell’idea di un “altro mondo” significa che il senso non viene da fuori, ma circola nel mondo stesso, attraverso le relazioni e le differenze tra gli esseri. Il mondo è il mantenersi di questi legami e spazi, un passaggio continuo di esseri ed esistenze che, comparendo e scomparendo, creano il senso. La mondializzazione mostra questa condizione, ma la sua trasformazione in globalizzazione, con la sua logica di uguaglianza forzata e sfruttamento, è una minaccia. Dobbiamo opporci a questa omologazione per affermare l’uguaglianza di ciò che non si può misurare e costruire un mondo vero.L’esistenza è una posizione assoluta, un essere già fuori di sé, esposto e cambiato dalla relazione con sé e con gli altri. Non si esiste da soli, ma in una coesistenza che c’è sempre e non si può evitare. La finitezza non è solo la vita limitata nel tempo, ma la condivisione che espone ogni esistenza alle altre. Non c’è un’interiorità chiusa, ogni sé è esposizione. La singolarità, quindi, non è un individuo isolato o un soggetto fisso, ma si manifesta sempre in tanti modi, in molte relazioni ed esposizioni reciproche. Ogni singolarità si definisce nel suo essere esposta in tanti modi, in ogni contatto e comparizione singolare. Non c’è un Altro trascendente, ma tanti altri, ognuno unico e straniero, origine del mondo.Il corpo, in questa visione, non è un punto interno, ma un’estensione esposta al contatto, sempre fuori di sé. È un’estensione che si trova in un luogo ed è plurale, un insieme di sensazioni e vibrazioni. Il corpo è intoccabile proprio perché è sempre aperto, nuovo e non può essere posseduto del tutto. Non ha una sostanza o una forma predefinita, ma è attraversato da infinite influenze esterne, un corpo che è tecnico per sua natura. Non esiste un corpo in sé, ma una continua relazione di contatto reciproco.Il sacrificio, in questa prospettiva, non è un fenomeno umano primario, ma una costruzione occidentale moderna. Il sacrificio cristiano-moderno esalta il soggetto a scapito della vittima, in un tentativo illusorio di possesso e purificazione. L’esistenza, però, non si può sacrificare o esaltare, ma solo condividere o distruggere. La sofferenza e l’orrore non si possono superare con il sacrificio.Infine, la natura stessa è intrinsecamente tecnica. La metafisica nasce quando la natura viene vista come un problema, già cambiata da tecniche che esistevano prima. La tecnica non è qualcosa che si aggiunge alla natura dall’esterno, ma la sua condizione originaria. Anche le forme di vita più semplici mostrano una tecnicità intrinseca. Per questo, le idee biopolitiche, che vedono un potere esterno che si appropria della vita, non bastano. La vita stessa è ecotecnica, e la lotta per la giustizia verso i viventi deve considerare questa condizione originaria.Riassunto Lungo
1. L’Ombra Animale in Noi
L’interesse per gli animali dal punto di vista filosofico è aumentato molto. Nonostante questo, le parole “animale” e “animalità” continuano a suggerire qualcosa di selvaggio e difficile da controllare. Anche se l’argomento è studiato a fondo, “animalità” mantiene un significato negativo e aggressivo. Lo si nota quando usiamo “animale” o “bestia” come insulti.Che cosa significa animalità
L’aggressività non è rivolta agli animali veri e propri, ma all’idea di animalità. Questa idea ci rende nervosi e ci fa paura. La parola “animalità” viene dal latino e indica la caratteristica di ciò che ha un’anima, intesa come soffio vitale. Questo soffio è la forza che fa vivere un essere vivente, un legame con sé stessi che viene prima della coscienza e dell’identità. La vita si mostra come esperienza, un respiro continuo.Come si manifesta l’animalità
L’animalità si vede in molti atteggiamenti e comportamenti simili a quelli delle bestie: l’attesa nascosta per attaccare, l’istinto di sopravvivenza, il bisogno di difendere il proprio territorio, la cura del corpo, la riproduzione, i bisogni fisici, mostrare dolore e piacere. In tutti questi aspetti, l’uomo riconosce una parte di sé e si senteConfuso e a disagio. L’animalità è dentro l’uomo e crea un’inquietudine diversa da quella degli animali, un’angoscia profonda perché è difficile capire fino in fondo i propri istinti e la propria morte inevitabile.Animalità ed esistenza umana
La vita stessa è animazione, un respiro che si esprime in tante forme diverse, dall’ameba al gorilla. Questa energia vitale che si manifesta senza limiti fa sentire l’uomo escluso e preoccupato. L’angoscia dell’uomo nasce dalla consapevolezza di dover morire e dalla percezione che la vita non è sempre logica. Allo stesso tempo, l’uomo sente dentro di sé l’eco di questa animalità antica. C’è un’animalità comune che si mostra in modi diversi, unendo uomini e animali nella continua ricerca di una vita che non si può afferrare, forse destinata a sparire nel nulla.Ma è davvero l’ “animalità” la radice ultima dell’angoscia umana, o non stiamo forse confondendo piani diversi, proiettando sull’ombra animale paure che nascono dalla nostra stessa coscienza?
Il capitolo presenta l’animalità come fonte di inquietudine esistenziale, ma non chiarisce se questa angoscia derivi dall’animalità in sé o dalla coscienza umana che riflette sull’animalità. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare la filosofia esistenzialista, studiando autori come Sartre e Camus, che hanno analizzato a fondo il tema dell’angoscia e della condizione umana.2. La questione animale: oltre i confini umani
La questione animale non è solo un problema morale, ma riguarda anche la filosofia occidentale a livello ontologico e politico. La distinzione tra esseri umani e animali, spesso considerata insormontabile, è fondamentale per ripensare la filosofia e la società, che si basa sullo sfruttamento degli animali. È quindi necessario che la filosofia e la politica si confrontino seriamente con la condizione animale, soprattutto considerando quanto è diventato grave lo sfruttamento degli animali oggi.La centralità della questione animale
La riflessione sugli animali ci porta a interrogarci sulle azioni umane e sul nostro rapporto con il mondo, che abbiamo trasformato in un “cantiere”. L’allevamento e il consumo di animali a livello industriale hanno raggiunto un punto tale da danneggiare la nostra salute, la nostra sensibilità e la nostra etica. Perciò, la questione animale si rivela essere un problema profondamente umano che ci riguarda da vicino.La messa in discussione dei soggetti isolati
La filosofia di oggi critica l’idea che gli individui siano isolati, mettendo invece in luce l’importanza delle relazioni e di ciò che precede l’individualità. Se consideriamo che gli esseri umani sono legati culturalmente e dal punto di vista evolutivo agli animali, diventa problematico escludere sistematicamente gli animali dalle nostre relazioni. La storia umana è piena di esempi di convivenza con il mondo vivente, come dimostrano i totem, gli animali sacri e le pitture rupestri. Questi elementi ci fanno capire che le attuali problematiche legate agli animali nascono da cambiamenti profondi nella civiltà occidentale.La vita come relazione e alterità
La vita, sia animale che vegetale, si manifesta come qualcosa di diverso da noi e come legame tra esseri viventi. È un continuo scambio reciproco e interno. Il “sé” è quindi per sua natura qualcosa di diverso da sé stesso. La vita è un processo continuo di sopravvivenza, senza un’identità fissa all’origine, in costante trasformazione. Il concetto fondamentale di “essere-insieme” si estende a tutti gli esseri, umani, animali, vegetali, oggetti inanimati, realtà e finzioni, superando l’idea di gruppi separati. Questa visione mette in discussione la tradizionale divisione e superiorità degli umani sugli animali, suggerendo invece una differenza che non implica una gerarchia.L’evoluzione della riflessione sull’animale
Nel tempo, il modo di pensare agli animali è cambiato. Inizialmente c’era meno interesse, poi si è passati a una fase di ascolto e attenzione, come dimostra l’apprezzamento per il lavoro di Jean-Christophe Bailly. Si cerca di adottare una “prospettiva animale”, ascoltando ciò che gli animali ci comunicano senza parole, cercando di superare la barriera del linguaggio. Questo approccio ci invita a considerare tutti gli esseri senzienti come sullo stesso piano, superando le differenze di importanza e riconoscendo una condizione di vulnerabilità comune a tutti i viventi.Il corpo come luogo di contatto
Il corpo, sia umano che animale, è un punto di incontro, di scambio e di desiderio, non qualcosa di isolato. Anche gli animali partecipano pienamente a questo gioco del corpo e del desiderio. L’idea di specie, come quella di razza o sesso, può essere vista come un limite. La differenza tra uomo e animale, spesso basata sul linguaggio, è messa in discussione. Il linguaggio, invece di creare divisioni, dovrebbe essere uno strumento per evitarle, aprendo la strada a un continuo ripensamento.La prospettiva di Derrida sulla questione animale
La riflessione di Derrida sulla questione animale, in particolare sul fatto che agli animali vengono negati l'”habeas corpus” e l'”habeas corpse”, è molto importante. Si contesta l’idea che gli animali non muoiano veramente o che la loro morte non meriti rispetto. La morte degli animali è reale e significativa. La politica, intesa come gestione della convivenza, deve mantenere aperta la comunità, evitando chiusure e gerarchie. La comunità è qualcosa di originario, che va oltre l’umano ed è in continuo movimento, cercando e perdendosi senza fine.Ripensare il linguaggio
Il linguaggio, spesso considerato ciò che distingue umani e animali, deve essere ripensato. Nonostante i progressi dell’etologia, si continua a definire il linguaggio in modo da escludere gli animali dalla capacità di usare simboli. Si propone di vedere il linguaggio come un sistema di segni, una comunicazione non verbale fatta di richiami, risposte, inviti e rifiuti. In questo modo, il linguaggio diventa un altro modo di chiamare la condivisione, un modo di condividere un significato comune.Il divenire animale e la sofferenza
Il concetto di “divenire animale” di Deleuze può essere visto come un modo per accedere a una lingua minore, che si apre ai linguaggi animali e crea una comunità aperta. La riflessione sull’animalità ci porta a interrogarci sull’umanità stessa: siamo mai stati veramente umani? Dobbiamo ancora diventarlo? Infine, la sofferenza degli animali è un punto centrale. Opere d’arte come i leoni di Chauvet, i quadri di Rousseau, gli arazzi medievali e i lavori di Bacon, testimoniano la forza, la dolcezza, il desiderio e soprattutto la sofferenza degli animali. Questa sofferenza ci rivela che la capacità di soffrire è una dimensione universale del mondo animale.Se la sofferenza è il fulcro della questione animale, quali sono i limiti di tale approccio?
Il capitolo pone giustamente l’accento sulla sofferenza animale come elemento cruciale per ripensare il nostro rapporto con le altre specie. Tuttavia, concentrarsi unicamente sulla sofferenza rischia di limitare la complessità della questione animale. Per ampliare la prospettiva, sarebbe utile esplorare le diverse dimensioni dell’esistenza animale, approfondendo studi di etologia e filosofia animale, e confrontandosi con autori come Peter Singer, che hanno affrontato la questione animale in modo ampio e articolato.Se la comunità si basa sulla divisione di qualcosa che non è comune a nessuno, come si possono affrontare problemi concreti come la disuguaglianza economica o i conflitti sociali, che richiedono azioni comuni e obiettivi condivisi?
Il capitolo sembra proporre una visione della comunità e dell’esistenza basata su principi astratti di relazione e apertura. Tuttavia, rimane poco chiaro come questi principi possano tradursi in soluzioni pratiche per le sfide concrete che le società umane affrontano. Per approfondire questa critica, è utile studiare autori che si sono occupati di filosofia politica e sociale, come Hannah Arendt, che ha analizzato le dinamiche del potere e dell’azione collettiva, o autori come Pierre Bourdieu, che ha studiato le disuguaglianze sociali e i meccanismi di riproduzione delle stesse.5. Volti della Filosofia Contemporanea
Tecnologia, virtuale e spazio
La filosofia contemporanea si confronta con le nuove frontiere tecnologiche, esplorando la cibernetica e la realtà virtuale. Questi temi aprono interrogativi inediti sull’esperienza umana e sulla percezione del reale. Inoltre, si analizzano gli spazi eterotopici, luoghi che sfidano le concezioni tradizionali di spazio, e l’architettura della sparizione, che riflette sulla natura effimera e transitoria dell’esistenza.Psiche, corpo e affetti
Un altro ambito di indagine riguarda la relazione tra psiche e sessualità, esplorando le dinamiche profonde dell’esperienza umana. L’amore viene esaminato nelle sue molteplici sfaccettature, dal legame con la musica alle riflessioni sull’intimità e sulla teatralità delle relazioni affettive. Si considerano anche i frammenti postumi, l’amore inespresso e la corrispondenza filosofica come espressioni complesse del sentimento amoroso.Sacro e profano
La riflessione filosofica si interroga sul significato del divino nascosto e sulle nuove forme di sacralità e profanità che emergono nella società contemporanea. Si analizzano le reliquie e il loro significato culturale, i segreti della Chiesa e il rapporto complesso tra fede e critica religiosa. Si affronta anche il tema del dialogo interreligioso e si esplorano concetti come l’illuminismo magico e la fine del giudizio divino.Arte, estetica e rappresentazione
Il cinema viene studiato come linguaggio e forma d’arte, aprendo una riflessione sul virtuale e le sue implicazioni filosofiche. Si considerano categorie estetiche come il sublime e il ridicolo nell’analisi cinematografica, la profondità spaziale e le possibilità del remake. Altri temi includono il trash sublime, la musica in Caravaggio, il rapporto tra arte e pubblico, la tecno-estetica, l’estetica e il rapporto tra bello e bene. Si indaga anche il linguaggio per immagini e il pensiero visuale.Politica, società e potere
La riflessione politica si articola attraverso concetti chiave come repubblica, federalismo ed eguaglianza, analizzando criticamente fenomeni come il berlusconismo e mettendo in discussione la tolleranza. Si affronta il concetto stesso di politica e le dinamiche del governo mondiale. Altri temi rilevanti sono la crescita economica, la concezione europea della vita, la libertà, il significato della guerra, la democrazia e i partiti, altre forme di politica, l’utopia, civiltà e barbarie, la sociologia francese, gli istinti e le istituzioni, i poteri e le strategie, il matriarcato e il problema della sociologia, la speranza oggi e il cinismo moderno.Esistenza, conoscenza e pensiero
La filosofia si confronta con interrogativi fondamentali sull’esistenza, esplorando il fascino dei fantasmi e la passione per la morte, il nulla, l’essere e il divenire. Si riflette sull’intellettuale senza patria e sull’orientamento nel pensiero, sulla verità e sulla corrispondenza filosofica. Si affrontano temi come il disastro oscuro, l’insonnia dello spirito, le leggi dell’abitudine, la conoscenza e l’ignoranza, il relativismo moderno, il confronto tra Oriente e Occidente e l’alterità. Infine, si considerano la lettura di classici letterari, il mito di Faust, il carteggio filosofico, il rapporto con Benjamin Fondane, l’esperienza artistica, la speranza, l’Europa, il giudaismo nella musica, il destino, la logica, il mito edipico, la poesia, le rime sulla morte e il miracolo naturale.In che modo questo capitolo, che spazia tra temi così diversi come tecnologia, affetti, sacro, arte, politica ed esistenza, riesce a fornire un quadro coerente della filosofia contemporanea, invece di presentarsi come una mera giustapposizione di argomenti?
Il capitolo presenta un’ampia gamma di temi, ma la domanda sorge spontanea: come vengono collegati questi argomenti in un quadro filosofico unitario? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire le opere di filosofi contemporanei che hanno cercato di fornire una visione d’insieme della filosofia attuale, come ad esempio Foucault con la sua analisi del potere e della conoscenza, o Deleuze con la sua filosofia della differenza e della molteplicità. Esplorare autori che si sono interrogati sulla ‘condizione postmoderna’ potrebbe anche offrire una chiave di lettura per comprendere come questi temi si intrecciano nel panorama filosofico contemporaneo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]