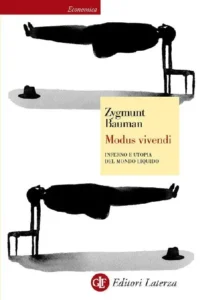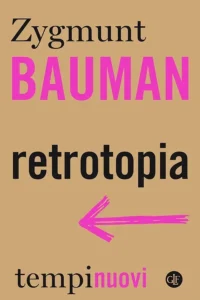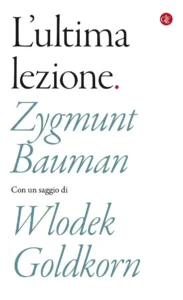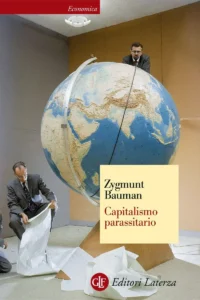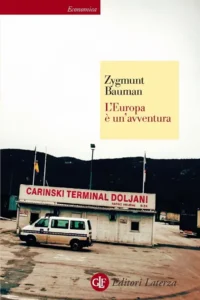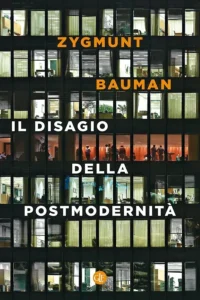1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La società sotto assedio” di Zygmunt Bauman ti fa capire che il mondo in cui viviamo non è più quello di una volta. Se prima si pensava alla società come a qualcosa di gestibile, quasi una macchina prevedibile controllata dallo stato nazionale, Bauman ci mostra che oggi è tutto molto più liquido e incerto. La globalizzazione ha spostato il potere, non è più solo una questione di territori e confini, ma di flussi globali, capitali che si muovono liberamente e un’élite mobile che opera al di fuori delle vecchie regole. Questo crea un sacco di insicurezza e incertezza per noi individui. I problemi che prima sembravano collettivi, da risolvere insieme, ora vengono scaricati sulle spalle del singolo, che deve arrangiarsi in un mondo dominato dal consumismo e dalla ricerca di una felicità effimera, fatta di piaceri veloci e usa e getta. La politica tradizionale sembra impotente di fronte a queste forze globali, e anche se siamo più consapevoli delle sofferenze altrui (pensiamo ai rifugiati o ai problemi globali), è difficilissimo trovare un modo per agire insieme in modo efficace. Il libro è un po’ come una mappa di questo nuovo paesaggio sociale frammentato, dove le vecchie sicurezze sono crollate e siamo tutti un po’ sotto assedio da forze che non riusciamo a controllare del tutto.Riassunto Breve
La sociologia all’inizio studiava la società come un sistema stabile e gestibile, cercando di capire come le azioni delle persone creassero modelli fissi e come le norme esterne guidassero i comportamenti. L’idea era di poter pianificare e controllare la vita sociale, quasi come un meccanismo. Per capire la società, si guardava alle strutture esterne, non solo a quello che le persone pensavano di fare. Però, negli ultimi decenni del Novecento, questa visione è cambiata molto. L’idea di gestire la società dall’alto è svanita. Il potere si è spostato dal controllo diretto a forme più sottili, come la seduzione e la creazione di desideri, un po’ come funziona il mercato. Le sicurezze di una volta, come i lavori fissi, sono sparite, sostituite da progetti temporanei e dalla necessità di essere sempre flessibili e pronti a cambiare. Essere bravi a muoversi in diverse situazioni e a comunicare è diventato più importante delle competenze tecniche specifiche. La vita di tutti i giorni non sembra più parte di un insieme unico e controllabile. Il mondo appare frammentato, difficile da prevedere, fatto di collegamenti che durano poco. Anche gli stati nazionali fanno fatica a controllare le forze globali che influenzano la vita delle persone. L’idea che la “società” sia un gruppo unito con un destino comune e che possa essere gestita insieme non sembra più vera. Questo ha portato più libertà di scelta per il singolo, ma anche un forte senso di non poter fare nulla a livello collettivo. I problemi globali sono troppo grandi per essere risolti solo con azioni locali. La politica, che per Aristotele era l’arte di distinguere il giusto dallo sbagliato e di partecipare alla vita della comunità, si è ridotta a descrivere chi ha il potere. La modernità aveva promesso benessere, ma ha anche caricato gli individui di responsabilità, generando ansia e un senso di impotenza. Questo si vede anche in fenomeni come i reality show, dove le persone sono sole e responsabili del proprio successo in un mondo incerto. I rischi che riguardano tutti vengono visti come problemi del singolo. C’è stata una grande separazione: il capitale, cioè i soldi e le grandi aziende, si è liberato dal controllo degli stati, creando uno spazio senza regole precise. Gli stati nazionali sono diventati più deboli, a volte solo guardiani dell’ordine per il capitale globale e gestori dell’insicurezza. La capacità di decidere a livello politico si è divisa, mentre le forze economiche agiscono a livello mondiale senza un vero contrappeso politico. Questa incertezza diffusa porta le persone a disinteressarsi della politica tradizionale o a sfogare l’aggressività in privato. La capacità di spostarsi è diventata fondamentale, ma non è distribuita in modo uguale, e si creano barriere per chi cerca di muoversi per sopravvivere, come i rifugiati. Non ci sono soluzioni facili: cercare sicurezza nell’identità di gruppo (comunitarismo) rischia di dividere ancora di più, mentre un’azione politica globale sarebbe necessaria ma non ha un luogo dove realizzarsi. Dopo l’11 settembre 2001, è diventato chiaro che il territorio non garantisce più sicurezza. La sicurezza e la vulnerabilità dipendono da quello che succede nello “spazio dei flussi” globale, non dai confini fisici. Il mondo globale è diventato una specie di terra di frontiera, dove la velocità e la capacità di muoversi contano più del controllo del territorio. I conflitti non si vincono conquistando terra, perché i nemici si spostano. Le alleanze cambiano in fretta, basate sulla convenienza. Questa mancanza di regole globali aiuta sia i poteri forti che i gruppi non statali, come i terroristi. La violenza spesso serve a testare le capacità dell’avversario. Le guerre sono diverse, asimmetriche, riflettendo la differenza tra chi si muove liberamente nel mondo e chi è legato a un luogo. Chi è mobile può colpire da lontano, chi non lo è cerca di mostrare che anche i potenti sono vulnerabili. Gli eserciti sono diventati professionali, per agire velocemente, ma questo aumenta i danni ai civili. L’etica militare si concentra sull’efficienza, meno sulle questioni morali. Il mondo è “pieno”, non ci sono più posti vuoti dove mandare via le persone indesiderate. I rifugiati sono bloccati in campi, senza poter tornare indietro né andare avanti, e diventano simbolo della precarietà globale e bersaglio delle paure locali. Mancano istituzioni politiche globali per affrontare questi problemi. Anche l’idea di felicità è cambiata. Un tempo era vista come qualcosa di raro, legato alla virtù o a una vita dopo la morte. Poi è diventata un diritto per tutti, da cercare sulla terra, legata al progresso e al soddisfacimento dei bisogni futuri. Oggi, con l’incertezza del futuro, la felicità non è più vista come uno stato stabile o l’accumulo di cose durature. È diventata la ricerca continua di piaceri veloci, l’accumulo di sensazioni. Si passa dall'”avere” o dall'”essere” all'”usare” e buttare via in fretta. I desideri vengono stimolati continuamente senza mai trovare una soddisfazione definitiva. La felicità è diventata il movimento costante e la successione rapida di esperienze che durano poco. La televisione ha cambiato molto la vita, creando una “iperrealtà” dove quello che si vede in TV sembra più vero del mondo reale. Questo mezzo è veloce e istantaneo, trasformando la vita in una serie di eventi rapidi e scollegati, come un gioco d’azzardo dove non serve pianificare. La TV ha eliminato il confine tra pubblico e privato, mettendo in mostra l’intimità e trasformando i problemi personali in spettacolo. Questo fa sì che le persone cerchino soluzioni individuali a problemi che invece riguardano tutti. La politica tradizionale, che dovrebbe trasformare i problemi privati in questioni pubbliche, si indebolisce. I politici sono sostituiti da personaggi famosi che mostrano come avere successo nella vita personale, non come cambiare la società insieme. Nella società dei consumi, quello che spinge non sono i bisogni, ma i desideri e i capricci, che durano poco e vogliono essere soddisfatti subito con cose sempre nuove. Questa enfasi sul cambiamento rapido e sulla flessibilità si adatta bene a un mondo del lavoro instabile. Il mercato usa l’insicurezza creata da questa precarietà, offrendo prodotti e servizi come soluzioni temporanee e usa e getta. Garantisce la possibilità di scegliere, ma non che le cose durino. L’ansia diventa utile per mantenere attivo il ciclo del consumo. Fare il male e non fare nulla contro il male sono facce della stessa medaglia, legate al negare la realtà. Le scuse tipiche sono “non sapevo” o “non potevo fare niente”. Oggi, con tutte le informazioni disponibili, “non sapevo” non regge più. Tutti siamo spettatori delle sofferenze nel mondo. C’è una distanza tra sapere cosa succede e poter agire in modo efficace. La globalizzazione ci fa sapere di più, ma non ci dà gli strumenti per risolvere le cause dei problemi. La responsabilità sembra riguardare tutta l’umanità, ma l’azione collettiva è debole. Nella modernità di una volta, l’idea di un mondo migliore era legata all’utopia, un luogo preciso e un progetto con una fine chiara: una società perfetta gestita dallo stato. Il potere era legato al territorio. Oggi, lo stato perde potere a favore di forze globali che non hanno un territorio fisso, come le grandi aziende e un’élite che si sposta liberamente. Questa élite pensa in modo nomade, non si sente legata a un luogo. L’idea di utopia, legata a un luogo fisso e a un obiettivo finale, non funziona più. La felicità è diventata una ricerca personale, immediata, legata alla velocità, non a un progetto di gruppo o a un luogo stabile. La difficoltà di passare dall’essere spettatori all’agire sta proprio qui: i problemi sono globali, ma gli strumenti politici per fare qualcosa di giusto sono divisi o non ci sono. È difficile impegnarsi insieme per cambiare il sistema.Riassunto Lungo
1. Il miraggio della società gestibile
La sociologia nasce per capire come le azioni delle singole persone creano modelli sociali che durano nel tempo. La visione che prevaleva all’inizio considerava la società come un sistema che cerca di stare in equilibrio. Questo sistema veniva visto come gestito da strutture esterne e da regole culturali che guidano il comportamento di ognuno. L’obiettivo era quasi quello di “costruire” la società, rendendo la vita delle persone prevedibile e controllabile, un po’ come se fosse un meccanismo preciso o un percorso già tracciato. Per questo, i primi sociologi studiavano queste forze che venivano da fuori, pensando che capire solo le azioni individuali non bastasse per afferrare la realtà sociale nel suo complesso.Il Cambiamento di Prospettiva
Negli ultimi anni del Novecento, questo modo di vedere le cose cambia molto. Le grandi ambizioni di organizzare e controllare la società dall’alto si riducono. Il potere non si basa più tanto sul controllo diretto, ma si sposta verso la capacità di attrarre e creare nuovi desideri, un po’ come succede nel mercato dei consumi. La sicurezza che prima veniva da lavori stabili e strutture solide scompare. Al suo posto, emergono progetti temporanei e la necessità di sapersi adattare continuamente ed essere flessibili. Diventa più importante sapersi muovere all’interno di reti di contatti e saper comunicare, rispetto al possedere solo conoscenze tecniche specifiche.Un Mondo Senza un Centro Chiaro
L’esperienza di tutti i giorni non ci dà più l’idea di una realtà unica e completa, o di qualcosa che possiamo gestire facilmente. Il mondo appare diviso in tanti pezzi, difficile da prevedere, come una rete fatta di collegamenti che durano poco. Anche lo stato nazionale mostra i suoi limiti nel riuscire a controllare quelle forze che decidono come vivono le persone. L’idea stessa di “società”, intesa come un gruppo unito da un destino comune e che si può guidare insieme, non sembra più vera se guardiamo i fatti.Più Scelte Individuali, Meno Potere Collettivo
Tutto questo porta da un lato a una maggiore libertà di scelta per il singolo, ma dall’altro crea anche un forte senso di non poter fare nulla a livello di gruppo. I problemi che riguardano tutto il mondo sono troppo grandi per essere risolti solo con azioni politiche a livello locale. La sfida per la sociologia oggi è proprio quella di affrontare questa situazione. Deve capire cosa succede in una realtà dove la società, come forza capace di agire unita, sembra svanita. Deve studiare le nuove forme di potere e i modi in cui le persone cercano di vivere e organizzarsi in un mondo che non ha più un centro di controllo evidente.Se il capitolo descrive un mondo senza centro, perché non spiega come ci siamo arrivati, e se questa perdita è davvero totale?
Il capitolo offre una descrizione efficace del passaggio da una visione della società come sistema controllabile a una realtà frammentata e senza un centro apparente. Tuttavia, non approfondisce adeguatamente le cause profonde e i processi storici che hanno portato a questa trasformazione radicale. Per comprendere meglio perché la società ha perso il suo centro percepito e se questa perdita è un fenomeno assoluto o parziale, sarebbe utile esplorare le analisi di autori come Zygmunt Bauman sulla modernità liquida, Manuel Castells sulla società in rete, o David Harvey sui processi di globalizzazione e neoliberismo. Approfondire la storia economica e politica degli ultimi decenni del Novecento è essenziale.2. Dalla Politica di Aristotele all’Incertezza Globale
La politica, secondo Aristotele, si basa sulla capacità umana di distinguere bene e male, giusto e ingiusto. Per lui, le persone hanno bisogno di unirsi nello stato per realizzare la giustizia. Essere cittadini significa partecipare attivamente alla creazione e alla modifica delle leggi, non solo usarle per proteggersi. Per avere una vera comunità politica, è necessaria un’assemblea dove le leggi possano essere discusse e criticate.Il Passaggio alla Politica Moderna
Col passare del tempo, l’idea di politica è cambiata. Non si è più concentrata sulla critica della realtà, ma sulla descrizione dei sistemi di potere già esistenti. La modernità aveva promesso di eliminare le sofferenze inutili e ha affidato allo stato il compito di garantire il benessere. Tuttavia, questo ha anche caricato l’individuo di molte responsabilità, generando ansia e un senso di impotenza. Questo porta le persone a cercare una “fuga dalla libertà”, immergendosi nel mondo esterno. Oggi, questa condizione si vede in fenomeni come i reality show televisivi. Questi programmi mostrano un mondo incerto e imprevedibile, dove ogni individuo è solo e responsabile del proprio successo o fallimento, in un gioco in cui uno vince solo se l’altro perde. Il “Grande Fratello” televisivo non interviene, fornisce solo il campo da gioco e lascia ai partecipanti il compito di eliminarsi a vicenda. Questo riflette una realtà sociale in cui i rischi e i problemi del sistema vengono fatti ricadere sul singolo.La ‘Seconda Grande Separazione’ Globale
Oggi stiamo assistendo a quella che viene chiamata una “seconda grande separazione”. Il capitale, cioè le risorse economiche e finanziarie, si è liberato dal controllo dei singoli stati nazionali, creando uno spazio che non è più legato a un territorio preciso. Questo ha indebolito gli stati nazionali, che spesso si ritrovano a fare solo da garanti dell’ordine per questo capitale che si sposta liberamente e a gestire l’insicurezza sociale. La capacità di decidere in politica (la sovranità) si è frammentata. Le forze economiche operano su scala mondiale, ma non c’è un potere politico adeguato a bilanciarle.Effetti dell’Incertezza e Possibili Risposte
Questa incertezza diffusa ha diverse conseguenze. Porta a un disinteresse per la politica tradizionale e a un’aggressività che viene sfogata nella vita privata o rivolta contro sé stessi. La capacità di spostarsi (la mobilità) è diventata una risorsa fondamentale, ma è distribuita in modo molto diseguale. Vengono create barriere per impedire a chi cerca opportunità di sopravvivenza di spostarsi. Di fronte a questa situazione, ci sono diverse reazioni. Una è il comunitarismo, che cerca sicurezza nell’identità di gruppo, ma rischia di creare divisioni. Un’altra è la necessità di un’azione politica che operi a livello globale, ma manca ancora uno spazio adatto dove questa azione possa davvero realizzarsi.Davvero la crisi della politica moderna si riduce a un reality show?
Il capitolo utilizza l’esempio dei reality show per illustrare l’incertezza e la responsabilità individuale nel contesto contemporaneo. Tuttavia, presentare un singolo formato televisivo come riflesso diretto e quasi esaustivo di fenomeni complessi come la “fuga dalla libertà” o la crisi della partecipazione politica rischia di semplificare eccessivamente dinamiche sociali e psicologiche ben più stratificate. Per approfondire il rapporto tra media, cultura di massa e trasformazioni politiche, e per esplorare le molteplici cause dell’ansia e dell’impotenza individuale nella modernità, è consigliabile studiare la sociologia dei media e la teoria critica della società. Autori come Zygmunt Bauman o Neil Postman offrono analisi più articolate su questi temi.3. La terra di frontiera globale e la fine dello spazio protettivo
Oggi, la sicurezza non dipende più dai confini o dalla vastità del territorio. L’idea che uno Stato potesse proteggersi grazie alla sua posizione geografica o alle sue fortificazioni è superata. La vulnerabilità e la sicurezza sono diventate questioni che vanno oltre i confini nazionali, legate a una rete globale di connessioni e movimenti, chiamata “spazio dei flussi”. Questo significa che nessun luogo, nemmeno il più isolato o difeso, può sentirsi completamente al sicuro dagli attacchi.Il mondo come nuova frontiera
In questo contesto globale, il mondo assume il carattere di una vasta terra di frontiera. Qui, la capacità di muoversi velocemente e l’agilità sono più importanti della forza basata sul controllo del territorio. I conflitti non si vincono conquistando terre, perché i nemici non sono legati a un luogo specifico, ma sono mobili e operano al di fuori dei territori tradizionali. Le alleanze tra Stati o gruppi sono spesso temporanee e si formano in base alle necessità del momento, non su accordi duraturi. Questa situazione, caratterizzata da rapidi cambiamenti e dalla mancanza di regole globali fisse, favorisce sia i grandi poteri che i gruppi non statali, come quelli terroristici, perché entrambi possono sfruttare l’assenza di leggi internazionali vincolanti.La natura dei conflitti attuali
In questo ambiente fluido, la violenza si manifesta spesso come “battaglie di ricognizione”. Queste azioni non hanno lo scopo di conquistare territorio, ma servono a mettere alla prova le capacità e i punti deboli dell’avversario in un contesto dove le regole sono poco definite. Le guerre diventano diseguali, riflettendo la differenza tra chi ha grande mobilità (l’élite globale) e chi è legato a un luogo (le popolazioni locali o i gruppi meno organizzati). Chi è mobile può colpire da lontano, mentre i gruppi meno mobili, come i terroristi, cercano di dimostrare che anche i potenti sono vulnerabili. Gli eserciti sono sempre più composti da professionisti anziché da soldati di leva. Questo permette di agire rapidamente e a distanza, riducendo i rischi per i propri soldati, ma spesso causando più danni ai civili. L’etica militare tende a concentrarsi sull’efficacia dell’azione, allontanandosi dalle considerazioni morali tradizionali.Un mondo senza spazi vuoti: la condizione dei rifugiati
Oggi il mondo è diventato “pieno”, non esistono più luoghi disabitati o terre inesplorate dove trasferire chi non è desiderato. I rifugiati, costretti a lasciare le loro case ma non accettati altrove, si ritrovano bloccati in campi che diventano luoghi di attesa indefinita, dove non possono né tornare indietro né andare avanti. Essi rappresentano in modo drammatico l’incertezza della vita in un mondo globalizzato e diventano spesso oggetto di paura da parte delle comunità locali. La mancanza di organismi politici globali forti e di una visione condivisa a livello internazionale rende difficile affrontare in modo efficace questi problemi che riguardano l’intera umanità.Ma è davvero la televisione, da sola, l’artefice di questa “iperrealtà” e del declino della politica tradizionale?
Il capitolo attribuisce alla televisione un potere quasi esclusivo nel plasmare la percezione della realtà e nell’indebolire la politica. Tuttavia, un’analisi più approfondita dovrebbe considerare il ruolo di altri fattori storici, economici e tecnologici (come internet e i social media, assenti nel testo) che contribuiscono a definire la nostra percezione del mondo e le dinamiche politiche. Per comprendere meglio la complessità di questi fenomeni, sarebbe utile esplorare le teorie sull’iperrealtà di autori come Jean Baudrillard e approfondire gli studi nel campo della sociologia dei media e della scienza politica, che offrono prospettive più articolate sull’interazione tra tecnologia, società e potere.6. L’utopia liquida e l’azione mancata
Il fare il male e il non opporsi al male sono due aspetti dello stesso problema, entrambi legati a una forma di negazione. Le scuse più comuni usate per giustificare l’inazione sono spesso “non sapevo” o “non potevo farci niente”. Oggi, grazie alla vasta diffusione delle informazioni e alla loro facile accessibilità, la scusa “non sapevo” perde gran parte della sua credibilità. Molte persone si trovano nella condizione di spettatore, testimone delle sofferenze che avvengono in ogni parte del mondo. Questa posizione di osservatore passivo, purtroppo, è diventata una condizione quasi universale.La distanza tra sapere e agire
Esiste un divario significativo tra il sapere delle sofferenze altrui e la capacità concreta di agire in modo efficace per alleviarle. La globalizzazione ha aumentato enormemente la nostra consapevolezza di ciò che accade nel mondo, mostrandoci problemi lontani, ma non ci ha fornito gli strumenti adeguati per intervenire sulle cause profonde di queste difficoltà. La responsabilità sembra estendersi a tutta l’umanità, sentiamo che i problemi globali ci riguardano, ma l’azione collettiva necessaria per affrontare questa responsabilità su vasta scala appare debole e difficile da organizzare.L’utopia nella modernità solida
Nella fase storica che potremmo definire modernità solida, l’immaginazione di una vita migliore si concentrava sull’idea di utopia. L’utopia era concepita come un luogo fisico e un progetto ben definito, con un obiettivo chiaro e una fine stabilita: la creazione di una società perfetta e stabile. Questa società ideale si pensava dovesse essere gestita principalmente dallo stato nazionale, dove il potere era strettamente legato al controllo del territorio e alla capacità di decidere chi includere o escludere le persone da esso.Il potere mobile e la ricerca della felicità oggi
Oggi, assistiamo a un indebolimento del potere dello stato nazionale a favore di forze globali che non sono più legate a un territorio specifico. Queste forze includono grandi multinazionali e un’élite economica e culturale estremamente mobile, che si sposta facilmente da un luogo all’altro. Questa élite opera in spazi non fisici, come i mercati finanziari globali o il mondo digitale, e si sente libera dagli obblighi e dai legami locali che vincolavano le strutture di potere precedenti. La sua visione del futuro è “nomade” e non impegnata in un luogo fisso, valorizzando soprattutto la mobilità, la velocità e la fluidità. In questo contesto, l’idea di utopia, legata a un luogo stabile e a una finalità collettiva, non appare più rilevante o realizzabile. La ricerca della felicità è diventata una questione privata e immediata, qualcosa da ottenere velocemente, legata più alla velocità con cui si possono ottenere esperienze o beni, piuttosto che a un progetto collettivo a lungo termine o alla costruzione di un luogo stabile dove vivere insieme.La sfida dell’azione collettiva
La difficoltà di trasformarsi da semplici spettatori a persone capaci di agire concretamente risiede proprio in questo nuovo scenario descritto. I problemi che il mondo affronta sono globali e complessi, superano i confini nazionali, ma gli strumenti politici ed etici a nostra disposizione per un’azione efficace sono frammentati a livello nazionale o del tutto assenti su scala globale. Per questo motivo, l’impegno collettivo necessario per realizzare un cambiamento profondo e sistemico appare estremamente difficile da mettere in pratica.Davvero la ricerca della “felicità privata e immediata” è l’unico ostacolo all’azione collettiva di fronte ai problemi globali?
Il capitolo stabilisce un legame diretto tra il ripiegamento sulla ricerca di una felicità individuale e la difficoltà di organizzare un’azione collettiva efficace. Tuttavia, questa connessione, pur plausibile, potrebbe non esaurire la complessità del problema. La paralisi dell’azione potrebbe dipendere anche da altri fattori, come la percezione di impotenza di fronte a problemi di scala enorme, la mancanza di strumenti politici globali efficaci, o la stessa natura sfuggente e non territoriale del potere descritto. Per approfondire questa dinamica e capire meglio cosa impedisce realmente il passaggio dallo “spettatore” all'”attore”, sarebbe utile esplorare studi di sociologia politica e psicologia sociale, magari confrontandosi con autori che hanno analizzato le trasformazioni della società contemporanea e le sfide dell’azione collettiva, come Zygmunt Bauman.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]