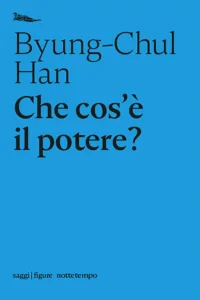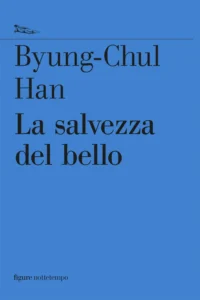1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La società della stanchezza” di Byung-Chul Han ti sbatte in faccia una realtà che forse senti già addosso: non siamo più schiavi di divieti esterni, ma ci auto-sfruttiamo in una “società della prestazione” dove l’imperativo è “poter fare” sempre di più. Han dice che le malattie di oggi, come il burnout e la depressione, non vengono da fuori, ma da un eccesso di positività, da questa pressione costante a essere performanti. È una violenza strana, non quella di prima, ma una “violenza neuronale” che ci logora dentro. In questo mondo iperattivo, perdiamo la capacità di annoiarci davvero, quella noia “profonda” che invece serve per pensare e creare cose nuove, e ci ritroviamo con un’attenzione superficiale, frammentata. Han ci fa capire che abbiamo perso il “potere negativo”, quello di dire “no”, di fermarci, di contemplare, che è fondamentale per non diventare macchine. E così, anche il tempo cambia: non c’è più spazio per il “tempo solenne” della festa, del sacro, solo per il tempo vuoto del lavoro incessante. È un libro che ti fa riflettere su quanto questa spinta a fare e a essere sempre positivi ci stia in realtà rendendo stanchi, isolati e svuotati, trasformandoci in “homo sacer” di noi stessi, intrappolati in un ciclo senza fine di performance.Riassunto Breve
Le malattie del nostro tempo, come depressione e burnout, non nascono da minacce esterne o negatività, ma da un eccesso di positività e pressione interna al sistema. Questo segna un cambiamento rispetto al passato, dove i problemi venivano dalla difesa contro ciò che era diverso o negativo. Oggi, la differenza non innesca reazioni di difesa, e la violenza è interna, legata all’eccesso di stimoli e alla sovrapproduzione. La vecchia società basata su divieti e negatività è stata sostituita dalla società della prestazione, dove l’obiettivo è il “poter fare” senza limiti. La depressione diventa la malattia principale, segno che l’individuo non riesce a reggere le richieste continue di essere performante. Chi vive nella società della prestazione si sente libero ma in realtà si sfrutta da solo; libertà e costrizione coincidono. Questa pressione interna causa disturbi psichici, legati all’eccesso di positività e alla spinta a rendere al massimo. La società attuale è piena di stimoli che rendono l’attenzione superficiale, simile a quella degli animali. Fare tante cose insieme (multitasking) non è un progresso, ma un ritorno a forme di attenzione meno evolute, non adatte a pensare in profondità. Questa stimolazione continua è l’opposto della noia profonda, che invece è fondamentale per la creatività e per vivere esperienze vere. La noia non è inutile, ma è il terreno dove nascono idee nuove. La cultura e il pensiero nascono dalla capacità di osservare con calma, cosa che oggi è difficile a causa dell’iperattività e della paura della noia. La fretta porta solo a ripetere le stesse cose più velocemente, mentre la noia profonda apre a novità e cambiamenti. La società che spinge all’azione continua rischia di perdere la capacità di ascoltare e osservare, che sono essenziali per una vita umana ricca. Vivere in modo contemplativo, basato sullo stupore e sul prendersi tempo, permette di vedere la profondità delle cose, sfuggendo alla superficialità dell’iperattività. Anche se oggi si esalta la vita attiva, perdere la capacità di contemplare è una delle cause principali dei problemi psicologici attuali. Rafforzare la capacità di osservare con calma è necessario per un equilibrio migliore. La vita contemplativa richiede di imparare a guardare in modo diverso, abituando l’occhio alla calma, alla pazienza e all’attesa. Questo significa avere un’attenzione profonda, uno sguardo lento, e soprattutto, non reagire subito agli stimoli, ma controllare gli impulsi. Non avere spirito significa non saper dire “no” agli stimoli esterni. La vera vita contemplativa non è stare fermi senza fare niente, ma resistere attivamente all’iperattività che, in modo strano, porta a essere troppo passivi e costretti. Per agire in modo autentico serve fermarsi e avere un po’ di negatività. Prendere tempo, anche se non è un’azione concreta, è fondamentale perché l’agire non diventi solo lavoro meccanico. La società frenetica elimina le pause e gli spazi vuoti, portando a un’attività senza pensiero. Questa iperattività elimina anche sentimenti come la rabbia, che ha bisogno di tempo per manifestarsi, sostituendola con una semplice irritazione superficiale. La rabbia, a differenza dell’irritazione, ha la forza di cambiare una situazione e iniziarne una nuova. Il mondo sempre più positivo indebolisce la negatività necessaria per sentimenti come l’angoscia e la tristezza, e trasforma il pensiero in un semplice calcolo. Il computer, che è una macchina completamente positiva, raccoglie dati senza rifiutarli, mentre il pensiero umano ha bisogno di ciò che è diverso e della negatività per riflettere. L’uomo e la società rischiano di diventare macchine che pensano solo a fare sempre di più, escludendo la negatività. Esistono due tipi di forza: quella positiva, del fare, e quella negativa, del non-fare, del dire no. Quest’ultima è diversa dall’essere impotenti ed è cruciale. Senza la forza negativa di non percepire, saremmo sommersi dagli stimoli. Senza la forza negativa di non fare, saremmo iperattivi fino a morirne. La contemplazione, come la meditazione, cerca la pura negatività del non-fare, il vuoto, come un modo attivo per liberarsi e avere controllo su se stessi. L’iperattività, invece, è un modo passivo di agire, basato solo sulla forza positiva. La società contemporanea si è spostata da un modello basato su regole e divieti a uno basato sulla prestazione, dove conta il “poter fare” e la libertà individuale. Questo cambiamento trasforma le persone in macchine che devono rendere al massimo, portandole a cercare modi per migliorare le proprie capacità fisiche e mentali. Ma questo eccesso di positività crea una stanchezza particolare, che isola e non permette di relazionarsi, diversa dalla stanchezza fisica. Esiste invece una “stanchezza fondamentale”, una calma che crea spazio per connettersi con gli altri e vedere il mondo in modo nuovo, riscoprendo il valore del non-fare. Questa stanchezza positiva si oppone all’iperattività della società della prestazione, suggerendo un modo diverso di stare attenti. La società della prestazione, con la sua enfasi sulla libertà e sul realizzare se stessi, porta in modo strano a sfruttarsi da soli. L’individuo di oggi non è più oppresso da regole esterne, ma è spinto da un ideale di sé irraggiungibile, costringendosi a essere sempre al massimo, il che porta a esaurimento e depressione. Queste malattie, a differenza di quelle del passato legate alla repressione, vengono dall’eccesso di positività e dall’incapacità di mettere limiti. In questo contesto, l’individuo diventa vittima di se stesso, non più escluso dalla società, ma intrappolato in un ciclo di auto-persecuzione. La vita si riduce a semplice sopravvivenza biologica, senza scopo o storia, con un’ossessione per la salute che diventa quasi una nuova religione. La persona contemporanea, anche se è iperattiva, è spiritualmente spenta, incapace di trovare riposo o significato al di fuori della prestazione. Il tempo delle feste è molto diverso dal tempo normale che passa velocemente. La festa non è un tempo che scorre, ma uno spazio in cui si sta, un tempo che si celebra come se non finisse mai. Questo tempo speciale si chiama tempo solenne, un tempo pieno e intenso, il contrario del tempo del lavoro, che sembra vuoto e da riempire. La festa ha un aspetto sacro, un’apertura al divino. In un’epoca dominata dal lavoro e dalla prestazione, il tempo solenne sta scomparendo, sostituito da un tempo lavorativo che occupa tutto. Questa prevalenza del lavoro porta a sfruttarsi da soli, dove la persona è sia chi sfrutta sia chi viene sfruttato, in una corsa all’ottimizzazione che elimina ogni spazio per la festa. La società di oggi, concentrata sulla sopravvivenza e sulla produttività, ha perso la capacità di celebrare e vivere momenti davvero intensi. La vita si riduce a una semplice esistenza biologica, senza quella dimensione festiva che eleva l’uomo e lo lega al sacro. Anche le feste di oggi sembrano vuote del loro significato originale, ridotte a eventi o spettacoli passeggeri, lontani dalla profondità del tempo solenne. Tuttavia, si può trovare una via d’uscita nel “profanare”: liberare oggetti e tempo dal loro valore solo pratico ed economico, per usarli in modo libero e giocoso. Questo atto di profanazione, come i bambini che giocano con i soldi, può trasformare il tempo del lavoro in tempo di festa, recuperando quella dimensione sacra e intensa dell’esistenza che la società di oggi sembra aver dimenticato. La bellezza stessa, molto legata alla festa, indica la direzione: ricostruire una “casa festiva” partendo dal “grande magazzino” del mondo di oggi, un luogo dove valga la pena vivere pienamente.Riassunto Lungo
1. L’Avvento della Violenza Positiva
Il cambiamento di paradigma nel XXI secolo
Nel XXI secolo, si assiste a un cambiamento radicale rispetto al passato. Le malattie neuronali più diffuse, come la depressione e il burnout, non sono causate da fattori negativi esterni. Al contrario, derivano da un eccesso di positività interna al sistema stesso. Questo rappresenta una netta rottura con il modello del XX secolo, che si basava sulla difesaImmunitaria dall’alterità e dalla negatività. Oggi, il concetto di alterità immunologica perde il suo significato. La differenza non scatena più reazioni di difesaImmunitaria, ma viene inglobata nel sistema senza抵抗. Di conseguenza, la forma di violenza predominante non è piùImmunitaria o virale, ma neuronale. Questa nuova violenza nasce proprio dall’eccesso di positività e dalla sovrapproduzione che caratterizzano il nostro tempo.La società della prestazione e l’auto-sfruttamento
La società disciplinare, che si fondava sul divieto e sulla negatività, è stata superata da un nuovo modello: la società della prestazione. In questo nuovo sistema, l’imperativo dominante è “poter fare” senza limiti. La depressione emerge come la malattia principale di questa epoca, manifestandosi come l’incapacità di reggere alle continue richieste di performance. Il soggetto che vive nella società della prestazione si illude di essere libero, ma in realtà cade in una dinamica di auto-sfruttamento. Libertà e costrizione, in questo contesto, finiscono per coincidere. Questa “libertà che costringe” genera una violenza interna profonda, che si traduce in disturbi psichici. Questi disturbi sono radicati nell’eccesso di positività e nella pressione costante a performare, tipici della società contemporanea.Ma la “violenza positiva” è una categoria diagnostica validata o una metafora suggestiva per descrivere il disagio contemporaneo?
Il capitolo introduce la nozione di “violenza positiva” come causa di malattie neuronali, ma non chiarisce se tale concetto abbia una validità scientifica o se sia piuttosto una chiave di lettura metaforica. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire la letteratura scientifica sulla psicopatologia contemporanea, consultando autori che si occupano di critica della ragione psichiatrica e sociologia della salute mentale. Questo permetterebbe di distinguere tra descrizioni metaforiche utili a interpretare fenomeni sociali e categorie diagnostiche convalidate empiricamente.2. Elogio della Noia Profonda
Oggi viviamo in una società piena di stimoli, troppi per la nostra attenzione. Questo eccesso di stimoli fa sì che la nostra attenzione si frammenti, diventando superficiale, quasi come quella degli animali. Il multitasking, che spesso viene visto come un passo avanti, in realtà ci riporta indietro a forme di attenzione primitive, che non ci permettono di pensare in profondità. Questa continua stimolazione è l’opposto della noia profonda, che invece è molto importante per la creatività e per vivere esperienze vere. La noia, quindi, non è tempo perso, ma piuttosto un terreno fertile dove possono nascere nuove idee e modi di vedere le cose.La cultura e la filosofia sono nate proprio dalla capacità di concentrarsi e riflettere con calma. Oggi, questa capacità è in pericolo a causa della nostra iperattività e della nostra paura della noia. La fretta e la frenesia ci portano solo a ripetere e accelerare ciò che già esiste, senza novità. Al contrario, la noia profonda ci permette di trovare nuove idee e cambiare le cose. La società di oggi, che ci spinge sempre ad agire senza sosta, rischia di farci perdere la capacità di ascoltare e riflettere. Queste capacità sono essenziali per vivere una vita piena e con significato.
La vita contemplativa, che si basa sulla capacità di meravigliarsi e di prendersi tempo per pensare, ci aiuta a capire le cose in profondità, evitando la superficialità tipica dell’iperattività. Anche se oggi si dà molta importanza alla “vita attiva”, si riconosce che aver perso la capacità di contemplare è una delle cause principali dell’ansia e dei problemi nervosi che vediamo nella società di oggi. Quindi, è importante riscoprire e rafforzare la nostra capacità di contemplazione. Questo è necessario per ritrovare un equilibrio umano più sano e per essere più creativi.
Ma il capitolo non rischia di presentare una visione eccessivamente dicotomica tra noia “profonda” e “iperattività”, trascurando la complessità delle esperienze umane e le diverse forme di stimolazione che possono arricchire la vita?
Il capitolo sembra suggerire che la noia profonda sia l’unico terreno fertile per la creatività e la riflessione, quasi demonizzando ogni forma di stimolazione esterna. Tuttavia, è importante considerare che la realtà è spesso più sfumata. Diverse discipline, come la psicologia della creatività e le neuroscienze, esplorano come differenti tipi di stimolazione, se ben gestiti, possano effettivamente potenziare il pensiero creativo e la capacità di problem-solving. Per una visione più completa, sarebbe utile approfondire autori come Johann Hari, che analizzano criticamente l’impatto della tecnologia sull’attenzione, offrendo una prospettiva più articolata sul rapporto tra stimoli, attenzione e benessere.3. L’Elogio della Negatività
La vita contemplativa si basa su un modo specifico di guardare le cose, un’educazione dello sguardo. Per Nietzsche, imparare a vedere è il primo passo per diventare spirituali. Vedere, in questo senso, significa abituare l’occhio alla calma, alla pazienza, al saper aspettare. È necessario quindi fare attenzione in modo profondo e contemplativo, guardare lentamente e a lungo. Soprattutto, bisogna essere capaci di non reagire subito a quello che ci colpisce, ma di controllare gli istinti che ci spingono ad agire d’impulso. La mancanza di spirito nasce proprio dall’incapacità di dire “no” agli stimoli che vengono da fuori, di opporsi ad essi. Quindi, la vera vita contemplativa non è essere passivi, ma resistere in modo attivo all’iperattività. Questa iperattività, che sembra il contrario della passività, in realtà porta a diventare iperpassivi e obbligati a fare sempre qualcosa.L’importanza dell’interruzione
Per agire in modo autentico, è necessario fermarsi e accettare la negatività. Anche se non è un’azione concreta, l’indugiare, il prendersi tempo, è fondamentale perché l’agire non diventi solo un lavoro meccanico. La società di oggi, sempre di corsa, elimina le pause e gli spazi vuoti, portando a un’attività senza pensiero, come una macchina. Questa iperattività cancella anche sentimenti importanti come la rabbia. La rabbia ha bisogno di tempo e di un’interruzione per farsi sentire, mentre al suo posto compare solo una irritazione superficiale. La rabbia, a differenza della semplice irritazione, ha la forza di interrompere una situazione e crearne una nuova.La negatività come strumento di pensiero
Se il mondo diventa sempre più positivo, si indebolisce quella negatività che è essenziale per sentimenti come l’angoscia e la tristezza. Inoltre, il pensiero rischia di diventare solo un calcolo, un’operazione matematica. Il computer, che è la macchina positiva per eccellenza, registra dati senza rifiutarne nessuno. Al contrario, il pensiero umano ha bisogno diAlternative e di negatività per riflettere, per pensare davvero. L’uomo e la società rischiano di trasformarsi in macchine autistiche concentrate solo sulla prestazione, dove l’obiettivo di fare sempre meglio esclude la negatività, il pensiero critico, la pausa.La potenza del “no”
Esistono due tipi di potenza, di forza: quella positiva, del fare, e quella negativa, del non fare, del dire no. Quest’ultima è molto importante e diversa dall’impotenza, dal non avere forza. Se non avessimo la forza negativa di non percepire, saremmo sopraffatti da troppi stimoli. Se non avessimo la forza negativa di non fare, cadremo in un’iperattività che ci distrugge. La contemplazione, come la meditazione zen, cerca proprio questa negatività pura del non-fare, il vuoto. Questo vuoto è visto come un atto attivo per liberarsi e diventare interiormente liberi e padroni di sé. L’iperattività, invece, è un modo di agire passivo, che si basa solo sulla potenza positiva, sul fare sempre di più.Il caso Bartleby
Il racconto di Melville, “Bartleby”, descrive un mondo del lavoro disumano, triste e pieno di problemi nervosi. Bartleby, con il suo famoso “preferirei di no”, non rappresenta la potenza negativa spirituale. Piuttosto, Bartleby mostra apatia e mancanza di motivazione in una società che controlla e punisce, simboleggiata da muri e prigioni. La sua situazione non è quella della società di oggi, concentrata sulla performance, ma di una società che disciplina e reprime la libertà individuale. Agamben interpreta Bartleby in modo metafisico, vedendolo come simbolo della pura potenza. Ma questa interpretazione non coglie l’aspetto malato e la negatività distruttiva del personaggio. Bartleby non è un portatore di un messaggio di liberazione, ma un simbolo di esaurimento, di stanchezza. Lo dimostra l’esclamazione finale del racconto: “Ah, Bartleby! Ah, umanità!”. La sua storia non offre una speranza per il futuro, ma piuttosto un lamento, un pianto sulla condizione umana.Ma è davvero inedita questa “stanchezza che divide” o non è forse una rielaborazione di concetti già noti?
Il capitolo presenta la “stanchezza che divide” come una novità legata alla società della performance. Tuttavia, non chiarisce se questa forma di stanchezza sia realmente un fenomeno inedito o se possa essere interpretata come una manifestazione contemporanea di dinamiche psicologiche e sociali già studiate in passato. Per comprendere meglio la specificità di questa “stanchezza”, sarebbe utile confrontarla con concetti classici come l’alienazione o l’anomia sociale, esplorati da autori come Durkheim e Marx, per capire se si tratti di una nuova patologia sociale o di una rilettura di malesseri esistenti.5. L’eclissi del Tempo Solenne
Il testo parla di un tipo di tempo particolare, chiamato tempo festivo. Questo tempo è molto diverso da come pensiamo di solito al tempo, cioè come una serie di momenti che passano velocemente. La festa non è un tempo che semplicemente scorre via, ma è più come uno spazio in cui ci si ferma volentieri, un tempo che si celebra come se non dovesse mai finire. Questa idea speciale di tempo è chiamata tempo solenne, un tempo pieno e ricco di significato, al contrario del tempo del lavoro, che spesso sembra vuoto e qualcosa che dobbiamo solo riempire.La dimensione sacra del tempo festivo
La festa ha in sé qualcosa di sacro, un collegamento con il divino. Oggi, però, dove tutto è concentrato sul lavoro e sul fare sempre di più, il tempo solenne sta scomparendo. Il tempo del lavoro ha preso il sopravvento, diventando quasi tutto ciò che esiste. Questa importanza eccessiva data al lavoro porta a una specie di sfruttamento di sé stessi. Le persone diventano sia quelle che sfruttano, sia quelle sfruttate, in un continuo sforzo per fare sempre meglio che non lascia spazio per la festa.La perdita della capacità di celebrare
La società di oggi, concentrata solo sul sopravvivere e produrre, ha dimenticato come celebrare e vivere momenti davvero intensi. La vita si riduce a una semplice esistenza fisica, senza quella dimensione festiva che rende le persone migliori e le lega al sacro. Anche le feste di oggi sembrano vuote, ridotte a eventi veloci e superficiali, lontane dal significato profondo e necessario del tempo solenne.La profanazione come via d’uscita
Nonostante questo, c’è una possibilità di cambiare le cose attraverso un gesto chiamato profanazione. Profanare significa liberare gli oggetti e il tempo dal loro valore solo utile e di denaro, per restituirli a un uso libero e divertente. Un esempio di profanazione è vedere i bambini che giocano con i soldi. Questo gesto può trasformare il tempo del lavoro in tempo festivo, recuperando quella dimensione sacra e intensa della vita che la società di oggi sembra aver dimenticato. La bellezza stessa, che è legata alla festa, ci indica la direzione: ricostruire una “casa festiva” partendo dal “grande magazzino” del mondo moderno, un posto dove valga la pena vivere pienamente.Ma la “profanazione” proposta nel capitolo è una soluzione concreta o rimane un concetto puramente teorico e idealistico?
Il capitolo introduce la “profanazione” come strumento per recuperare il tempo solenne, suggerendo di liberare oggetti e tempo dal loro valore utilitaristico. Tuttavia, non approfondisce come questa “profanazione” possa effettivamente realizzarsi nella complessa realtà sociale ed economica contemporanea. Per comprendere meglio le dinamiche del tempo festivo e lavorativo, e per valutare la praticabilità della “profanazione”, sarebbe utile esplorare studi sociologici e filosofici sul concetto di festa, tempo libero e sul rapporto tra sacro e profano. Autori come Mircea Eliade, con le sue analisi sul sacro e il tempo religioso, o studiosi del concetto di “gioco” e “ritualità” nelle società moderne, potrebbero fornire prospettive utili per rispondere a questa domanda.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]