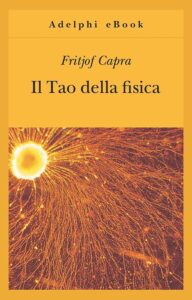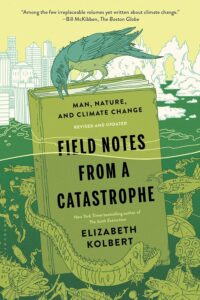1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La sesta estinzione. Una storia innaturale. Nuova ediz.” di Elizabeth Kolbert è un libro che ti prende subito perché parla di qualcosa di enorme: stiamo vivendo la sesta estinzione di massa nella storia della Terra, e la cosa pazzesca è che la causa siamo noi, l’Homo sapiens, che abbiamo dato il via all’Antropocene. Il libro non si limita a dirlo, ma ti porta in giro per il mondo, da Gubbio in Italia dove hanno trovato le prove dell’asteroide che ha spazzato via i dinosauri (parla di scienziati come Walter Álvarez e Georges Cuvier che hanno capito l’estinzione), fino alle foreste pluviali dell’Amazzonia per vedere come la frammentazione degli habitat distrugge la biodiversità. Ti fa conoscere la crisi degli anfibi, come la rana d’oro di Panama, minacciati da malattie e cambiamenti, e ti spiega quanto sia grave l’acidificazione degli oceani per le barriere coralline e la vita marina, con ricerche fatte in posti come Castello Aragonese. Non dimentica la scomparsa della megafauna o il destino dei Neandertal, suggerendo che l’arrivo dell’uomo moderno ha avuto un impatto enorme. È un viaggio attraverso la geologia, la biologia e la storia, che ti fa capire quanto sia fragile il nostro pianeta e quanto sia urgente la conservazione.Riassunto Breve
La Terra sta attraversando un periodo di rapida perdita di specie, un evento che gli scienziati chiamano la Sesta Estinzione. A differenza delle cinque grandi estinzioni di massa del passato, causate da catastrofi naturali come impatti di asteroidi o eruzioni vulcaniche, questa estinzione è principalmente guidata dall’attività umana. L’Homo sapiens, una specie comparsa circa duecentomila anni fa, si è diffuso rapidamente sul pianeta, modificando profondamente gli ambienti. L’abbattimento delle foreste per l’agricoltura e l’espansione demografica hanno distrutto habitat naturali. L’introduzione di specie da un continente all’altro, spesso involontaria, porta organismi invasivi che competono con le specie locali o diffondono malattie. Un esempio è il fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), che sta decimando le popolazioni di anfibi in tutto il mondo, rendendo gli anfibi la classe di animali più a rischio. Anche la sindrome del naso bianco, causata da un fungo, sta sterminando i pipistrelli. L’uso di combustibili fossili ha alterato la composizione atmosferica, causando cambiamenti climatici e l’acidificazione degli oceani. Gli oceani assorbono una parte significativa della CO2 emessa, riducendo il pH dell’acqua. Questo rende difficile per organismi come coralli e molluschi costruire i loro scheletri o gusci di carbonato di calcio. Studi vicino a condotti vulcanici sottomarini mostrano che molte specie marine scompaiono in acque più acide, suggerendo che un pH di 7,8 potrebbe essere un punto critico per molti ecosistemi marini, previsto per il 2100 se le emissioni continuano. Le barriere coralline, ricche di biodiversità, sono particolarmente vulnerabili all’acidificazione e al riscaldamento globale, che causa lo sbiancamento. La frammentazione degli habitat, come dimostrato dagli studi nella Riserva 1202 in Amazzonia, porta a una perdita continua di specie, poiché le piccole popolazioni isolate sono più esposte all’estinzione. Il concetto di Antropocene descrive questa nuova epoca geologica dove l’impatto umano è la forza dominante che modella il pianeta. La comprensione scientifica delle estinzioni è cambiata nel tempo, da Georges Cuvier che riconobbe l’esistenza di specie perdute a Walter Álvarez che propose l’ipotesi dell’impatto asteroidale per l’estinzione dei dinosauri, evidenziando come eventi catastrofici possano alterare la vita sulla Terra. Oggi, il tasso di estinzione è molto più alto del tasso naturale di fondo, e le estinzioni avvengono in tempo reale, non solo come eventi del passato geologico.Riassunto Lungo
Capitolo 1: La Sesta Estinzione
Il capitolo inizia descrivendo la scoperta di una nuova specie animale, l’Homo sapiens, che si è sviluppata circa duecentomila anni fa. Questa specie, pur non avendo caratteristiche fisiche superiori, ha mostrato una notevole capacità di adattamento e innovazione ambientale. Si espande rapidamente attraverso vari habitat, sterminando altre specie con cui entra in contatto, inclusi animali più grandi e forti. L’Homo sapiens si diffonde in tutto il pianeta e, nel corso dei millenni, inizia a modificare l’ambiente in modo significativo. L’abbattimento delle foreste per il sostentamento alimenta un’impennata demografica senza precedenti.L’impatto dell’uomo sull’ambiente
Questo processo di espansione porta a una crescente estinzione di altre specie, accelerata dall’introduzione di organismi da un continente all’altro. Contemporaneamente, la scoperta di risorse energetiche sotterranee provoca cambiamenti nella composizione atmosferica e negli ecosistemi marini. Le specie animali e vegetali reagiscono spostandosi verso i poli o scomparendo completamente. Il tasso di estinzione aumenta vertiginosamente, alterando radicalmente la vita sulla Terra.Le estinzioni di massa
Il capitolo evidenzia che eventi simili sono già accaduti nella storia della Terra, noti come le “Big Five”, cinque estinzioni di massa causate da catastrofi naturali. Tuttavia, ciò che accade ora è diverso: l’estinzione attuale è causata principalmente dall’azione umana ed è stata definita “Sesta Estinzione”. La narrazione prosegue presentando tredici capitoli che esplorano casi emblematici di estinzione. Si analizzano le estinzioni passate e il lavoro del naturalista Georges Cuvier nell’identificare queste crisi.La crisi degli anfibi e l’estinzione di massa
La seconda parte del libro si concentra sulle attuali minacce alla biodiversità in luoghi come la foresta pluviale amazzonica e la Grande Barriera Corallina. Viene discusso il tema dell’estinzione di massa, sottolineando sia l’orrore che suscita sia l’interesse scientifico che genera. L’obiettivo è far comprendere ai lettori l’importanza del momento storico attuale riguardo alla biodiversità. Il capitolo introduce anche la rana d’oro di Panama (Atelopus zeteki), simbolo della crisi degli anfibi. La popolazione di queste rane diminuisce drammaticamente a causa di malattie e cambiamenti ambientali.La scoperta di Walter Álvarez
Un contributo molto importante è stato dato da Walter Álvarez, con il suo lavoro sui foraminiferi a Gubbio, dove viene scoperto uno strato di argilla privo di fossili che segna un evento catastrofico coincidente con l’estinzione dei dinosauri. Attraverso analisi chimiche viene identificato un picco di iridio nell’argilla, suggerendo un impatto asteroidale come causa dell’estinzione. L’articolo pubblicato da Álvarez e suo padre nel 1980 suscita un ampio dibattito scientifico e viene accolto con entusiasmo ma anche critiche aspre da parte della comunità paleontologica.La relazione tra evoluzione ed estinzione
Nonostante le resistenze iniziali, l’ipotesi dell’impatto diventa una teoria accettata per spiegare le estinzioni di massa. In conclusione, il capitolo mette in luce la relazione tra evoluzione ed estinzione, sottolineando come entrambe siano processi naturali influenzati anche dall’attività umana. Le scoperte scientifiche recenti offrono nuove prospettive sul futuro della biodiversità e sull’importanza della conservazione degli ecosistemi minacciati.La “Sesta Estinzione” è un concetto scientifico ancora oggetto di dibattito e critica, o è un fatto universalmente accettato?
Il capitolo presenta la “Sesta Estinzione” come un evento in corso, ma non approfondisce adeguatamente le controversie e le critiche che circondano questo concetto. Per una comprensione più approfondita, è utile esaminare le posizioni di vari scienziati e le evidenze scientifiche che sostengono o confutano questa teoria. Un’analisi critica delle fonti e una lettura di testi come “The Sixth Extinction: An Unnatural History” di Elizabeth Kolbert possono fornire ulteriori informazioni su questo tema. Inoltre, sarebbe interessante esplorare come le diverse discipline scientifiche, dalla biologia all’ecologia, contribuiscono alla nostra comprensione di questo fenomeno.Capitolo 2: L’estinzione e l’Antropocene
Il capitolo esplora il concetto di estinzione di massa attraverso la storia della vita sulla Terra, analizzando eventi significativi come le estinzioni del Paleozoico e del Cretaceo. John Phillips, nel 1841, suddivise la storia della vita in tre ere: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, basandosi sulle evidenti differenze nei fossili rinvenuti. Le interruzioni nel registro fossile sono state ben documentate da Charles Lyell, che notò fratture tra le specie marine di epoche diverse, suggerendo che queste lacune rappresentassero lunghi intervalli di tempo. Charles Darwin riconobbe anch’egli queste fratture e propose che le apparenti estinzioni brusche potessero nascondere processi più lenti. Tuttavia, i suoi successori si trovarono a dover affrontare una crescente tensione tra la visione uniformitarista della scienza e i dati emergenti sul registro fossile.Le teorie sull’estinzione
Le discussioni sui cambiamenti climatici e sull’impatto umano sull’ambiente hanno portato a nuove teorie sulle estinzioni di massa. George Gaylord Simpson sostenne che l’estinzione alla fine del Cretaceo fosse un processo lungo e continuo, mentre altri scienziati iniziarono a considerare eventi catastrofici come cause per le estinzioni. Nel contesto contemporaneo, si è sviluppata l’ipotesi dell’Antropocene, proposta da Paul Crutzen. Questa nuova epoca geologica è caratterizzata dall’impatto umano significativo sul pianeta. Crutzen ha evidenziato come l’attività umana abbia alterato radicalmente la superficie terrestre, i corsi d’acqua e l’atmosfera.L’acidificazione degli oceani
I cambiamenti climatici causati dalle emissioni di gas serra sono stati identificati come fattori chiave in questo processo. L’acidificazione degli oceani è un tema cruciale trattato nel capitolo. Hall-Spencer ha condotto ricerche nei condotti vulcanici di Castello Aragonese per studiare gli effetti dell’acidificazione su diverse specie marine. Ha scoperto che molte specie tipiche del Mediterraneo scomparivano man mano che si avvicinavano ai camini vulcanici dove il pH era più basso. Questo studio ha mappato le forme di vita esistenti in relazione ai cambiamenti previsti negli oceani globali. Le conclusioni delle ricerche indicano che il punto critico per la sopravvivenza degli ecosistemi marini potrebbe essere il pH 7,8, previsto per il 2100.Conclusioni
Ciò rappresenta un allerta significativa riguardo agli effetti dell’acidificazione sugli organismi marini. In sintesi, il capitolo sottolinea la suddivisione della storia della vita in ere geologiche, le osservazioni storiche sulle interruzioni nel registro fossile, l’importanza dell’impatto umano sull’ambiente attuale, la ricerca sull’acidificazione degli oceani e le sue conseguenze sulle specie marine, e il riconoscimento dell’Antropocene come nuova epoca geologica influenzata dall’uomo. La narrazione mette in evidenza come ogni evento di estinzione sia unico e complesso, con implicazioni significative per il futuro della biodiversità terrestre e marina.Come possiamo essere certi che l’acidificazione degli oceani sia principalmente causata dalle emissioni di gas serra e non da altri fattori?
Il capitolo sembra omettere alcune considerazioni importanti circa la complessità dei processi oceanici. Per rispondere a questa domanda, potrebbe essere utile approfondire la chimica degli oceani e le teorie del cambiamento climatico. Un buon punto di partenza potrebbe essere “Climate Change 2007: The Physical Science Basis” del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC). Inoltre, potrebbe essere utile esaminare studi che prendono in considerazione altri fattori che potrebbero contribuire all’acidificazione degli oceani, come ad esempio le attività umane costiere e l’inquinamento.Capitolo 3: L’acidificazione degli oceani e i coralli
Dalla pubblicazione del primo articolo di Hall-Spencer nel 2008, l’interesse per l’acidificazione oceanica è cresciuto. Sono stati avviati progetti di ricerca internazionali e condotti numerosi esperimenti per valutare gli effetti dell’aumento dei livelli di CO2 sugli ecosistemi marini. I risultati mostrano che mentre alcune specie possono adattarsi a un oceano acidificato, molte altre, come il coccolitoforo Emiliania huxleyi e la Limacina helicina, sono vulnerabili e rischiano l’estinzione. Ulf Riebesell ha evidenziato che le specie più resistenti aumenteranno in abbondanza, ma la biodiversità complessiva diminuirà, simile a eventi di estinzione di massa passati. L’acidificazione degli oceani è paragonata al riscaldamento globale ed è stata implicata in diverse estinzioni storiche.Gli effetti dell’acidificazione sugli ecosistemi marini
Gli studi indicano che la composizione chimica delle acque oceaniche è un indicatore affidabile della salute degli ecosistemi marini. Le conseguenze dell’acidificazione sono molteplici e includono impatti sul metabolismo degli organismi, sulla disponibilità di nutrienti e sulla fotosintesi. Un aspetto significativo riguarda i calcificanti, organismi come coralli e molluschi che costruiscono gusci o scheletri di carbonato di calcio. L’acidificazione aumenta lo sforzo necessario per la calcificazione riducendo la disponibilità di ioni carbonato. Esperimenti hanno dimostrato che l’abbassamento del pH influisce negativamente sui calcificanti. Nelle aree con elevati livelli di CO2, molte specie calcificanti sono scomparse.L’impatto dell’acidificazione sui coralli
I coralli svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi marini; senza di essi, gli habitat subacquei crollerebbero. Le barriere coralline sono eccezionalmente diverse e ricche di vita, ma stanno affrontando minacce multiple: acidificazione oceanica, cambiamenti climatici, pesca eccessiva e inquinamento. Queste pressioni rendono i coralli più vulnerabili alle malattie. Il riscaldamento globale rappresenta una sfida significativa per i coralli poiché le temperature elevate compromettono il legame simbiotico tra i polipi e le zooxantelle. Gli eventi di sbiancamento dei coralli sono diventati sempre più frequenti a causa dell’innalzamento delle temperature oceaniche. In sintesi, l’acidificazione degli oceani costituisce una minaccia seria per i coralli e gli ecosistemi marini in generale. Senza interventi immediati per ridurre le emissioni di carbonio e proteggere gli habitat marini, si prevede una drastica diminuzione della biodiversità marina nei prossimi decenni.Come possiamo essere certi che l’attuale tasso di estinzione sia dovuto principalmente all’attività umana e non a fattori naturali?
Il capitolo non fornisce una spiegazione approfondita delle cause naturali che potrebbero contribuire all’estinzione. Per approfondire l’argomento, è utile approfondire le teorie dell’evoluzione e la paleontologia. Un buon libro per farlo è “L’origine delle specie” di Charles Darwin, mentre per le teorie dell’estinzione è utile approfondire le teorie di Luis Alvarez e Walter Alvarez.Capitolo 9: L’estinzione degli anfibi e le sue cause
Gli anfibi sono attualmente la classe di animali più a rischio di estinzione, con un tasso di perdita che supera le quarantacinquemila volte il normale. Le estinzioni avvengono in tutto il mondo, colpendo anche altre specie come coralli, molluschi, squali, mammiferi e uccelli. I motivi dietro questa crisi possono sembrare vari, ma alla fine si riducono a un’unica causa principale: la presenza di specie invasive. Un fungo chiamato Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) è stato identificato come uno dei principali colpevoli dell’estinzione degli anfibi. Questo fungo può diffondersi attraverso l’acqua e i carichi di rane infette.La diffusione del fungo Bd
Due teorie spiegano la sua diffusione: una suggerisce che sia stato portato da rane artigliate africane utilizzate nei test di gravidanza, mentre l’altra attribuisce la responsabilità alla rana toro nordamericana, spesso esportata per il consumo alimentare. In entrambi i casi, il Bd ha avuto effetti devastanti sulle popolazioni locali di anfibi. Il fungo non solo ha sterminato molte specie in natura, ma ha anche reso difficile il recupero degli esemplari rimasti.Gli sforzi di conservazione
Griffith, un erpetologo panamense, ha organizzato spedizioni per cercare rane sopravvissute da portare all’EVACC (El Valle Amphibian Conservation Center), dove gli animali possono essere protetti dall’infezione. Tuttavia, una volta catturate, le rane non possono tornare nel loro habitat naturale poiché il fungo persiste nell’ambiente. L’EVACC è progettato per isolare gli anfibi dal mondo esterno e proteggerli dalle malattie. Tuttavia, mantenere gli animali in cattività solleva interrogativi sul futuro della loro reintroduzione in natura.La comprensione delle estinzioni
Cuvier ha contribuito enormemente alla comprensione delle estinzioni attraverso le sue teorie sui cataclismi e sulla stabilità delle specie. Ha sostenuto che eventi catastrofici hanno causato la scomparsa di diverse forme di vita nel passato. Sebbene alcune delle sue idee siano state confutate nel tempo, altre si sono dimostrate valide: la vita sulla Terra è stata effettivamente soggetta a cambiamenti drammatici. La teoria dell’evoluzione proposta da Darwin ha ampliato ulteriormente la comprensione del rapporto tra estinzione e origine delle specie. Secondo Darwin, l’estinzione e l’emergere di nuove forme viventi sono processi interconnessi guidati dalla selezione naturale.La conservazione degli anfibi nel lungo termine
Le variazioni favorevoli vengono preservate mentre quelle sfavorevoli vengono eliminate nel corso del tempo. In sintesi, l’attuale crisi degli anfibi è un fenomeno complesso influenzato da fattori ecologici e biologici. La conservazione degli anfibi richiede non solo interventi diretti come la protezione in centri specializzati ma anche una comprensione profonda delle dinamiche evolutive e ambientali che influenzano la loro sopravvivenza nel lungo termine. La speranza è che le condizioni possano migliorare e che le rane possano essere ripopolate nelle foreste un giorno.Perché l’autore del capitolo attribuisce la responsabilità della crisi degli anfibi principalmente alla presenza di specie invasive?
Il capitolo sembra concentrarsi prevalentemente sul fungo Bd come causa principale della crisi degli anfibi, senza approfondire altre possibili cause. Tuttavia, la letteratura scientifica sottolinea l’importanza di considerare una combinazione di fattori, tra cui il cambiamento climatico, la distruzione dell’habitat e l’inquinamento, che potrebbero contribuire all’estinzione degli anfibi. Per un approfondimento più completo sulla tematica, si consiglia di leggere “L’estinzione: un problema globale” di Niles Eldredge.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]