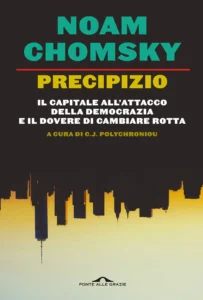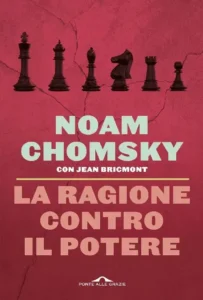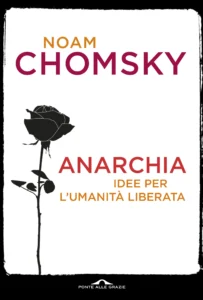1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La responsabilità degli intellettuali” di Noam Chomsky è un libro che ti fa riflettere un sacco sul ruolo di chi ha accesso alle informazioni e alla libertà di parola. Chomsky dice che gli intellettuali, proprio per i loro privilegi, hanno il dovere di cercare la verità e denunciare le bugie, soprattutto quelle che vengono dal potere. Invece, spesso vediamo che molti, specialmente quelli vicini al governo, come negli esempi della Baia dei Porci o della Guerra del Vietnam, finiscono per giustificare o nascondere le azioni brutali e la propaganda. Il libro parla di come si cerca di dividere la critica in “responsabile”, che accetta il sistema, e “sentimentale”, che invece mette in discussione i principi morali, sminuendo quest’ultima. C’è anche l’idea che solo gli “esperti” possano parlare di politica estera USA, creando un “culto dell’esperto” per zittire il dissenso. Chomsky usa esempi storici, come l’Affare Dreyfus, per mostrare che ci sono sempre stati due tipi di intellettuali: quelli che sfidano il potere e i dissidenti, e quelli che lo servono. Sottolinea che la vera responsabilità degli intellettuali è analizzare criticamente il proprio governo e contribuire ai movimenti popolari, non guidarli, decifrando la propaganda e cercando soluzioni concrete. È un invito a usare il proprio privilegio per la giustizia, non per essere complici del potere.Riassunto Breve
Gli intellettuali hanno una responsabilità speciale nel cercare la verità e denunciare le bugie, più grande rispetto alla gente comune, perché hanno privilegi come l’accesso alle informazioni e la libertà di parlare. Molti, però, soprattutto quelli vicini al potere, non fanno questo, accettando o promuovendo le falsità del governo, come quelle sull’invasione della Baia dei Porci o sulla guerra in Vietnam. Giustificano azioni violente presentandole come scelte razionali o fatte per “buona volontà”. Si crea una differenza tra critica “responsabile”, che accetta il diritto di un paese potente di espandere la sua influenza e discute solo su come farlo, e critica “sentimentale”, che mette in discussione i principi morali dietro le azioni e viene vista come irrazionale. Si promuove l’idea che la politica estera sia solo per “esperti” con conoscenze particolari, mettendo da parte l’analisi basata sui fatti e sulla morale. Questo serve a giustificare le politiche esistenti e a non dare spazio a chi non è d’accordo. La politica estera di un paese mira spesso a mantenere altre nazioni “aperte” ai propri interessi economici e politici. In Vietnam, questo significava non accettare una soluzione politica basata sul sostegno popolare locale, perché il governo appoggiato dagli Stati Uniti non aveva questo sostegno. La strategia diventa quindi distruggere l’opposizione con la forza militare, non potendo vincerla politicamente. Accettare le bugie del governo o stare zitti di fronte a cose terribili rende complici. La responsabilità dell’intellettuale è opporsi all’autorità quando questa va contro i principi morali fondamentali. Il concetto moderno di intellettuale nasce con l’affare Dreyfus, dove alcuni intellettuali sfidarono il potere militare per la giustizia, contrapponendosi a quelli che difendevano le istituzioni. Nella storia, gli intellettuali spesso si schierano con il proprio paese, specialmente in guerra, e chi dissente viene messo da parte. Negli anni Settanta, si distinguono gli intellettuali che criticano l’autorità (“guidati dai valori”) e quelli che lavorano dentro le istituzioni (“tecnocratici”). Il termine “dissidente” viene usato solo per chi si oppone ai regimi nemici, non per chi critica il proprio paese o i suoi alleati. Ad esempio, le violenze e le torture in America Latina tra il 1960 e il 1990, spesso commesse da regimi supportati dagli Stati Uniti, vengono minimizzate rispetto ai crimini in altri paesi. Le vittime sotto l’influenza del proprio paese vengono ignorate, mentre quelle sotto i regimi nemici vengono ricordate. Anche l’uso di nomi di tribù native per operazioni militari mostra come si tenda a ignorare i crimini storici. Gli intellettuali hanno un privilegio che offre opportunità e quindi responsabilità. La scelta fondamentale è usare questo status per servire il potere o per sfidarlo in nome della giustizia e della libertà. Il compito principale degli intellettuali è analizzare le azioni dei governi, concentrandosi su quelle del proprio paese e dei suoi alleati. Durante la Guerra Fredda, l’analisi era semplificata dall’idea di difendersi da un nemico, nascondendo l’uso della violenza da entrambe le parti. La fine della Guerra Fredda non ha reso le cose più complicate, ma ha tolto una distorsione propagandistica. Il ruolo degli intellettuali non è guidare le masse, ma aiutare i movimenti popolari. Questo significa capire la propaganda, vedere le strutture di potere e proporre idee concrete per un pensiero diverso da quello dominante. Gli intellettuali con competenze specifiche possono dare analisi storiche o aiutare a definire proposte pratiche, come per i movimenti sul clima. C’è il rischio che questi sforzi vengano usati dal potere, quindi serve attenzione. I social media rendono difficile la discussione, favorendo slogan semplici e la ricerca di colpevoli, allontanando dai problemi veri. La risposta è cercare le cause profonde dei problemi e promuovere la comprensione e la partecipazione. Gli intellettuali che sfidano il potere vengono spesso criticati, mentre chi lo sostiene riceve elogi. Questo schema si ripete, come si è visto con le critiche all’invasione dell’Iraq. Gli intellettuali devono essere onesti, riconoscere il loro privilegio e usarlo per aiutare la lotta popolare, senza sentirsi superiori. La differenza tra intellettuali che stanno con il potere e quelli indipendenti e idealisti continua a esistere.Riassunto Lungo
1. La verità e il potere degli intellettuali
Gli intellettuali hanno una responsabilità unica: cercare la verità e denunciare le menzogne. Questa responsabilità è amplificata dai loro privilegi, come l’accesso alle informazioni e la libertà di espressione, che li rendono più responsabili rispetto alla popolazione generale.La distorsione della verità
Molti intellettuali, specialmente quelli vicini al potere, non rispettano questo dovere. Accettano o promuovono le falsità del governo, come quelle riguardanti l’invasione della Baia dei Porci o i negoziati sul Vietnam. Presentano distorsioni storiche o giustificano azioni brutali, come i bombardamenti, definendole basate su “argomenti razionali” o parte di un programma di “buona volontà”. Si crea una distinzione tra critica “responsabile”, che accetta l’assioma che gli Stati Uniti hanno il diritto di estendere il proprio potere, e critica “sentimentale”, che mette in discussione i principi morali e i moventi dietro le azioni. Quest’ultima viene spesso sminuita come irrazionale.Il culto dell’esperto
La politica estera viene presentata come una questione per “esperti” con conoscenze speciali, escludendo l’analisi basata su fatti accessibili e principi morali. Questo “culto dell’esperto” serve a giustificare le politiche esistenti e a marginalizzare il dissenso. La politica estera americana mira a mantenere le nazioni come “società aperte”, accessibili agli interessi economici e politici degli Stati Uniti. In Vietnam, questo si traduce nel rifiuto di una soluzione politica basata sulle forze locali, poiché il Fronte di Liberazione Nazionale ha un forte sostegno popolare che il governo sostenuto dagli USA non possiede. La strategia si concentra sulla distruzione della struttura politica avversaria tramite la forza militare, non potendo competere politicamente.La responsabilità degli intellettuali
Accettare le menzogne del governo o rimanere in silenzio di fronte alle atrocità equivale a diventare complici. La responsabilità dell’intellettuale implica opporsi all’autorità quando questa agisce in conflitto con un codice morale fondamentale. Gli intellettuali devono essere i custodi della verità e della giustizia, anche quando ciò significa sfidare il potere costituito.Ma è davvero così semplice distinguere la “verità” dalla “menzogna” e il “codice morale fondamentale” dall’interesse di parte, o il capitolo non rischia di cadere nello stesso dogmatismo che critica?
Il capitolo presenta una visione molto netta del ruolo dell’intellettuale e della distinzione tra verità e menzogna, specialmente nel contesto politico. Tuttavia, la realtà delle dinamiche di potere, la produzione del sapere e la definizione stessa di “verità” o di un “codice morale fondamentale” universalmente accettato in contesti complessi e conflittuali è oggetto di dibattito filosofico e sociologico da secoli. Il capitolo, pur sollevando questioni importanti sulla responsabilità, potrebbe beneficiare di un’analisi più approfondita su come si costruiscono le narrazioni dominanti e su chi detiene il potere di definire cosa sia “razionale” o “responsabile”. Per esplorare queste complessità, si potrebbero approfondire discipline come la filosofia (in particolare l’epistemologia e l’etica applicata alla politica), la sociologia del sapere e la teoria politica, leggendo autori come Michel Foucault o Antonio Gramsci, che hanno analizzato i legami tra potere, conoscenza e il ruolo degli intellettuali nella società.2. Servire o Sfidare: La Responsabilità Intellettuale
Il concetto moderno di intellettuale nasce con l’affare Dreyfus nel 1898. I dreyfusardi si pongono come difensori della giustizia, criticando il potere militare e opponendosi agli intellettuali tradizionali, che li vedono come una minaccia per le istituzioni. Questo scontro definisce due tipi di intellettuali: quelli che sfidano il potere e quelli che lo servono.Intellettuali e guerra
Durante la Prima Guerra Mondiale, molti intellettuali si schierano con il proprio Stato, sostenendo la linea ufficiale. Chi dissente viene punito o emarginato, mentre chi appoggia il governo è celebrato. Negli anni Settanta, questa divisione si formalizza: emergono gli “intellettuali guidati dai valori”, critici dell’autorità e dell’indottrinamento, e gli “intellettuali tecnocratici e guidati dalla politica”, che lavorano all’interno delle istituzioni.Il termine “dissidente” e i suoi doppi standard
Il termine “dissidente” è usato in modo selettivo. Si applica positivamente a chi si oppone ai regimi nemici, ma non a chi critica le azioni del proprio paese o dei suoi alleati. In America Latina, tra il 1960 e il 1990, regimi supportati dagli Stati Uniti causano un numero elevato di vittime e torturati, superando quelli dell’Europa dell’Est nello stesso periodo. Eventi come il colpo di Stato in Cile nel 1973 (il “primo 11 settembre”) sono spesso minimizzati, mentre le vittime nella sfera d’influenza del proprio paese vengono ignorate o denigrate.Crimini storici e narrazioni distorte
L’assassinio di Osama bin Laden, chiamato “Operazione Geronimo”, e l’uso di nomi di tribù native per armi militari rivelano una tendenza a sminuire i crimini storici commessi. Queste scelte linguistiche riflettono una narrativa distorta, che ignora o ridimensiona le ingiustizie del passato.Il privilegio e la responsabilità degli intellettuali
Gli intellettuali godono di un privilegio che offre loro opportunità uniche. Questo status implica una scelta fondamentale: servire il potere costituito o sfidarlo in nome di valori come giustizia e libertà. La loro responsabilità è decidere come utilizzare la propria influenza per plasmare la società.Ma davvero la responsabilità intellettuale si riduce a un semplice bivio tra servire il potere e sfidarlo?
Il capitolo presenta una dicotomia netta tra intellettuali che “servono” e intellettuali che “sfidano” il potere, ma questa polarizzazione rischia di semplificare eccessivamente un rapporto ben più complesso. La realtà spesso si colloca in una zona grigia, dove gli intellettuali possono operare all’interno di istituzioni o strutture di potere, cercando comunque di influenzarle criticamente o di promuovere valori progressisti. Non sempre “servire” implica un’adesione acritica, né “sfidare” garantisce efficacia o rettitudine morale. Per comprendere meglio le sfumature di questo rapporto, è utile approfondire la sociologia degli intellettuali, la storia delle idee e le teorie critiche del potere. Autori come Michel Foucault o Noam Chomsky offrono prospettive che vanno oltre la semplice contrapposizione.3. Il ruolo degli intellettuali tra potere e movimenti popolari
Gli intellettuali hanno la responsabilità di analizzare le azioni dei governi, con particolare attenzione al proprio paese e ai suoi alleati. Durante la Guerra Fredda, questa analisi era semplificata da una cornice ideologica che inquadrava gli eventi come una difesa contro un nemico. Questo approccio nascondeva l’uso della violenza e della sovversione da parte di entrambe le superpotenze nelle rispettive aree di influenza. Con la fine di questa cornice, la complessità non aumenta, ma viene rimossa una distorsione propagandistica.Compito e ruolo degli intellettuali
Il compito degli intellettuali non è guidare le masse, ma contribuire ai movimenti popolari. Questo si realizza decifrando la propaganda politica, individuando le strutture di potere e sviluppando idee concrete e attuabili per un pensiero contro-egemonico. Gli intellettuali con competenze specifiche possono offrire analisi storiche o contribuire a definire proposte pratiche, come nel caso dei movimenti per il clima e il Green New Deal. Esiste il rischio che questi sforzi vengano cooptati dai sistemi di potere, richiedendo vigilanza da parte degli attivisti.Sfide e risposte
I social media rappresentano una sfida significativa, poiché facilitano la diffusione di slogan semplici e il ricorso a capri espiatori, distogliendo l’attenzione dai problemi reali. La risposta a questa dinamica è cercare le cause profonde dei problemi e promuovere una comprensione più profonda, accompagnata da una mobilitazione efficace.Storia e critica degli intellettuali
Storicamente, gli intellettuali che sfidano il potere costituito vengono spesso criticati o emarginati, mentre chi sostiene lo stato riceve elogi. Questo schema si ripete, come dimostrano le reazioni alla critica dell’invasione dell’Iraq. Gli intellettuali dovrebbero essere onesti, riconoscere il proprio privilegio e usarlo per contribuire alla lotta popolare, senza presentarsi come guide superiori. La distinzione tra intellettuali allineati al potere e quelli indipendenti e idealisti rimane un tema centrale.Se il compito non è guidare, come possono gli intellettuali contribuire efficacemente ai movimenti popolari senza perdersi nell’astrazione o essere semplicemente ignorati nell’era dei social media?
Il capitolo delinea un ruolo cruciale per gli intellettuali nel decifrare la propaganda e individuare le strutture di potere, ma la transizione da questa analisi alla “contribuzione ai movimenti popolari” e allo sviluppo di un “pensiero contro-egemonico” rimane piuttosto generica. Non è chiaro come si possa tradurre l’analisi complessa in forme comunicative e pratiche che siano efficaci per la mobilitazione, specialmente di fronte alla sfida dei social media, che il capitolo stesso riconosce come terreno fertile per la semplificazione e lo slogan. Per approfondire questo nodo cruciale, sarebbe utile esplorare la sociologia degli intellettuali, le teorie della comunicazione e i meccanismi dei movimenti sociali. Autori come Gramsci, Bourdieu e Said offrono strumenti concettuali per comprendere il posizionamento degli intellettuali nel campo del potere e i processi di egemonia e contro-egemonia, mentre lo studio dei movimenti sociali contemporanei e delle dinamiche digitali può fornire spunti più concreti sulle strategie di intervento e comunicazione efficaci.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]