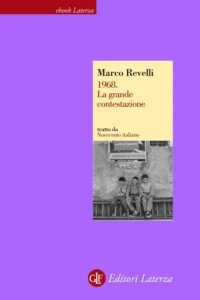1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite” di Marco Revelli ci porta dentro la profonda crisi della democrazia che stiamo vivendo, una crisi non di decisioni, ma di capacità di condividerle, che trasforma i sistemi in oligarchie elettive distanti dai cittadini. È in questo vuoto di rappresentanza e fiducia nei partiti tradizionali, percepiti come obsoleti e lontani, che fiorisce il populismo, definito come un’ideologia che contrappone un “popolo puro” a un'”élite corrotta”. Il libro esplora la geografia del malcontento, mostrando come il sostegno populista cresca nelle aree periferiche e meno fortunate di paesi come USA, UK, Francia, Germania e Italia, luoghi colpiti dalle nuove disuguaglianze generate dalla grande crisi economica post-2007, che ha aumentato povertà e concentrato ricchezza. Questo scenario alimenta un forte rancore sociale, un’ira che non trova sbocco politico e viene sfruttata dalla psicopolitica per creare nemici e identità basate sull’esclusione. Revelli dipinge un quadro di una politica che ha perso la sua funzione collettiva, ridotta a racconto, e dove la sfiducia diffusa e la ricerca di capri espiatori diventano il terreno fertile per l’ascesa di movimenti che promettono vendetta e protezione in cambio di lealtà.Riassunto Breve
La democrazia oggi vive una crisi profonda, non nella capacità di decidere, ma di decidere insieme. Diventa una sorta di oligarchia elettiva dove chi governa risponde meno ai cittadini e più ad altri poteri. Questo porta le persone a sentirsi deluse e a non votare più, o a cercare partiti nuovi, spesso chiamati populisti, che sembrano dare voce alla rabbia contro i politici di sempre. La politica stessa si è allontanata dalla vita reale, diventando un discorso vuoto. Per anni, si è creduto che la globalizzazione e la democrazia liberale fossero l’unica strada possibile, ma questo ha creato molte differenze sociali. Da qui nasce un’altra idea, quella di un’identità forte e antica minacciata dall’esterno, che dice che il popolo è stato tradito e cerca vendetta, trovando un nemico. Il populismo si inserisce qui, dicendo che la società è divisa tra un popolo buono e un’élite cattiva. Non accetta idee diverse e vede il popolo come una cosa sola, contro chi è diverso. Cresce quando le istituzioni non funzionano più e la gente non si fida. Alcuni pensano che il populismo aiuti a ridare importanza al popolo, altri che sia un segno di debolezza che non affronta i veri problemi, ma crea solo nemici, portando a escludere gli altri. Questa ondata populista arriva dopo grandi cambiamenti nella società e nell’economia, come la crisi del lavoro e la difficoltà del ceto medio. Eventi come la Brexit e l’elezione di Trump mostrano che il sistema economico attuale ha dei problemi. Il voto populista si lega a dove vivono le persone, mostrando un disagio che si trova soprattutto lontano dalle città ricche e dalle zone che crescono velocemente. Negli Stati Uniti, Trump ha vinto nelle zone interne, mentre le città sulla costa hanno votato diversamente. In Inghilterra, chi voleva uscire dall’Europa ha vinto nelle zone periferiche e industriali, chi voleva restare a Londra e nelle grandi città. In Francia, Marine Le Pen ha più voti nelle campagne e nei paesi piccoli, tra operai e persone con meno soldi e istruzione. Macron vince nelle città grandi e tra chi sta meglio. In Germania, il partito AfD è forte nell’Est, nelle campagne e tra gli anziani con meno istruzione, preoccupati per l’immigrazione. Nell’Est Europa, il populismo unisce l’idea di nazione forte alla sfiducia verso l’Europa, trovando appoggio tra chi si sente svantaggiato. In Italia, il Movimento 5 Stelle è forte al Sud, legato al disagio, mentre la Lega al Nord, anche nelle zone industriali. I partiti vecchi, come la sinistra, prendono voti nelle città e tra le classi più ricche. Il voto mostra una divisione tra chi vive nelle zone meno ricche e periferiche e chi vive nei centri più ricchi. La politica si sposta dai centri alle periferie, anche se il potere economico resta nelle città. I partiti tradizionali, soprattutto la sinistra, non riescono più a rappresentare tutti e sembrano aver lasciato la loro gente per stare con le élite globali. Questo fa arrabbiare chi si sente dimenticato e lo spinge verso i populisti che vengono dalle periferie. I partiti, una volta, davano un’idea di comunità e identità. La loro crisi lascia un vuoto. La gente si fida sempre meno dei partiti. Il populismo occupa questo spazio. I partiti del passato erano come fabbriche o uffici rigidi, adatti a organizzare tante persone per bisogni semplici come lavoro e sicurezza. Ma la società di oggi è diversa, più istruita, cerca più libertà personale. Le persone sono meno disposte a seguire regole rigide. La globalizzazione ha creato una distanza tra le élite globali e la gente legata al territorio. I vecchi partiti non funzionano più in questo mondo che cambia velocemente e richiede flessibilità. I partiti di massa hanno anche problemi di soldi. Costano troppo per mantenere le loro strutture e per farsi conoscere, soprattutto con i media moderni. Le campagne elettorali costano tantissimo, specialmente negli Stati Uniti, e trovare i soldi diventa più importante delle idee. In Italia, i partiti hanno avuto molti soldi pubblici, usati per mantenere le strutture e le persone fedeli. Questa difficoltà dei partiti vecchi lascia spazio al disordine nel dibattito pubblico. Si diffondono idee strane e non vere, dove le emozioni contano più dei fatti. Internet e i social media peggiorano le cose, creando gruppi chiusi dove si sentono solo certe idee e la fiducia nelle istituzioni e nei giornali diminuisce. La democrazia cambia. Non sono più i partiti a fare da ponte tra la gente e lo Stato. Si parla di democrazia del pubblico o della sfiducia. La gente vota più per l’immagine di una persona che per un partito, un’immagine creata dai media. Il cittadino non partecipa più tanto, ma guarda da fuori con diffidenza. Questa situazione di sfiducia e rappresentanza che cambia favorisce i populismi. La crisi economica iniziata nel 2007 ha causato grandi problemi sociali. Negli Stati Uniti, milioni di persone hanno perso la casa. Molti americani vivono in povertà, anche se lavorano. Questo colpisce soprattutto madri sole e operai poco qualificati. Anche in Italia la povertà è aumentata. La crisi è legata a imbrogli nel mondo della finanza. Banche e altre istituzioni hanno contribuito a creare la bolla speculativa, causando danni enormi alle famiglie. Nel mondo, le differenze tra ricchi e poveri sono cresciute molto. Pochi ricchissimi hanno quanto tutto il resto della popolazione. Questa concentrazione di ricchezza e l’aumento della povertà creano una società con grandi disuguaglianze. Anche tra le città e le zone fuori, le differenze aumentano. Le città crescono, le periferie perdono servizi e lavoro. Queste divisioni sociali e territoriali creano un clima di disagio e sfiducia che aiuta i movimenti politici che usano la rabbia. C’è il rischio che questo porti a governi autoritari. La povertà fa arrabbiare le persone. Episodi come l’incendio dei campi rom mostrano questa rabbia diretta verso i più deboli. La gente si sente tradita, non trova le parole per esprimere la sua rabbia e sfoga tutto in odio. C’è una grande differenza tra l’idea di benessere che si vede e la realtà di precarietà. Il rancore è la sensazione di un’attesa non mantenuta. Questa rabbia viene usata dalla “psicopolitica”, che governa usando le emozioni, soprattutto quelle negative, per creare un senso di appartenenza e riempire un vuoto. I populisti sono bravi a fare questo, parlando alla pancia e creando nemici facili, come i migranti o i rom. Anche l’invidia cambia. Prima si invidiava chi aveva di più. Oggi si invidia chi ha meno, i “penultimi” invidiano gli “ultimi”. Questo crea scontri tra poveri, dove la lotta non è per migliorare, ma per far stare peggio gli altri. Si cerca di sentirsi meglio escludendo chi sta peggio. Quando mancano politiche sociali serie, queste idee populiste trovano spazio. Invece di dare diritti a tutti, si offrono riconoscimenti basati sull’esclusione e sulla fedeltà, trasformando il rapporto tra cittadini e potere in uno scambio dove chi chiede protezione la ottiene in cambio di lealtà.Riassunto Lungo
1. La Crisi della Democrazia e il Populismo
La democrazia sta attraversando un momento di profonda e duratura crisi. Non si tratta di un problema nella capacità di decidere, ma nella difficoltà di arrivare a decisioni che siano davvero condivise da tutti. Questa crisi si manifesta come una mancanza di rappresentanza e legittimità. Le democrazie sembrano trasformarsi in “oligarchie elettive”, dove chi è al potere risponde meno ai cittadini e più ad altri interessi esterni al controllo popolare. Di conseguenza, le persone provano delusione e sfiducia, si allontanano dal voto e si rivolgono a nuove forze politiche, spesso chiamate populiste. Queste nuove forze raccolgono i sentimenti popolari, a volte aggressivi, e il desiderio di protestare o di rivalersi contro la politica tradizionale.La Politica che Cambia Forma
Questo scenario riflette anche una crisi della politica intesa come spazio comune per la vita della collettività. La politica sembra essersi ridotta a un linguaggio astratto, a un racconto che parla solo di sé, perdendo il suo ruolo di attività concreta rivolta a un obiettivo comune.Due Racconti in Contrasto
Negli ultimi trent’anni, il dibattito politico è stato dominato da due grandi narrazioni opposte. La prima, la “politica dell’inevitabilità”, sosteneva che la globalizzazione e la democrazia liberale fossero un percorso obbligato e senza alternative. Questa visione ha però creato disuguaglianze e non ha mantenuto le sue promesse. Dalla crisi di questa narrazione è emersa la seconda, la “politica dell’eternità”. Questa si basa sul mito di un’identità originaria del popolo, vista come minacciata dall’esterno. Si concentra sull’idea di un tradimento subito dal popolo e cerca una sorta di risarcimento, spesso individuando un “altro” come nemico.Il Populismo e la Crisi
Il populismo è strettamente legato a questa situazione di crisi. Viene descritto come un modo di pensare la società che la divide nettamente in un “popolo puro” e un'”élite corrotta”. Una caratteristica fondamentale del populismo è la tendenza a rifiutare il pluralismo, considerando il popolo come un blocco unico e omogeneo, contrapposto a un “non-noi”. Per affermarsi, il populismo ha bisogno di un contesto in cui le istituzioni e i loro rappresentanti siano in crisi profonda.Diversi Modi di Vedere il Populismo
Alcuni studiosi vedono il populismo come un tentativo di costruire l’idea stessa di “popolo” e di ridare importanza alla dimensione politica, che rischia di essere ridotta a semplice amministrazione. Altri, invece, lo considerano un segnale di impotenza che non affronta le cause profonde e sistemiche dei problemi, preferendo invece creare nemici concreti. Questo approccio può portare a tendenze di esclusione. L’attuale diffusione del populismo è il risultato di grandi cambiamenti sociali ed economici avvenuti negli ultimi decenni, tra cui la crisi del mondo del lavoro e del ceto medio.Ma il populismo è davvero solo quel monolite anti-pluralista descritto, o questa definizione rischia di semplificare eccessivamente un fenomeno complesso e multiforme?
Il capitolo offre una lettura del populismo focalizzata sulla divisione “popolo puro” contro “élite corrotta” e sul rifiuto del pluralismo. Tuttavia, questa prospettiva, pur valida per certi contesti, potrebbe non esaurire la complessità del fenomeno. Esistono diverse scuole di pensiero che analizzano il populismo non solo come sintomo di crisi o patologia democratica, ma anche come una modalità di articolazione delle domande sociali o come una strategia politica. Per approfondire queste sfumature e comprendere meglio le diverse facce del populismo, al di là della sua descrizione nel capitolo, è utile esplorare gli studi in scienza politica e sociologia, confrontandosi con autori che hanno proposto definizioni alternative o complementari, come Ernesto Laclau o Cas Mudde, che offrono prospettive diverse sulla sua natura e funzione.2. La Geografia del Malcontento
La stabilità in Occidente si rompe con eventi come Brexit e l’elezione di Trump nel 2016, segnando l’emergere di problemi nel sistema neoliberista e conflitti strutturali profondi. Una risposta significativa da parte di chi subisce le conseguenze di questo sistema si manifesta attraverso il voto. Questo voto, spesso definito populista, è strettamente legato al territorio e rappresenta un chiaro segnale di disagio sociale diffuso. Richiama vecchie e persistenti divisioni geografiche e sociali, come quella tra centro e periferia o tra grandi città e aree rurali o di provincia.Il Modello Geografico del Voto
Il sostegno ai movimenti populisti tende a concentrarsi lontano dai centri economici più ricchi e dalle aree in rapido sviluppo. Prevale invece in zone storicamente legate alla vecchia economia industriale o agricola, spesso colpite dalla perdita di industrie e posti di lavoro. Al contrario, le forze politiche più tradizionali o quelle percepite come più integrate nel sistema globale raccolgono consensi nei grandi centri urbani, nelle aree economicamente più dinamiche e tra i gruppi sociali con maggiore istruzione e reddito. Questa divisione profonda si basa su fattori come il luogo di residenza, il reddito, il livello di istruzione e la classe sociale.Esempi Internazionali
Negli Stati Uniti, la vittoria di Trump si è concentrata nelle aree interne del paese, mentre le città costiere hanno espresso un voto differente. Analogamente, la Brexit in Inghilterra ha mostrato una netta divisione, con il voto per “Leave” prevalente nelle aree periferiche e nelle ex zone industriali, contrapposto al “Remain” di Londra e delle maggiori città, un esito che riflette le difficoltà sociali e il declino economico di quelle aree, spesso legate alla classe lavoratrice. Anche la Francia presenta uno schema simile, con Marine Le Pen che ottiene i maggiori consensi nelle aree rurali e nei piccoli centri, in particolare tra operai e persone con minore istruzione e reddito, mentre Macron prevale nelle grandi città e tra i gruppi sociali più elevati. In Germania, la crescita del partito AfD è forte nell’Est del paese, nelle aree rurali e tra gli elettori anziani con minore istruzione e reddito, un fenomeno spesso legato a preoccupazioni sull’immigrazione e a una generale sfiducia nei partiti politici tradizionali.Europa dell’Est e Italia
In diversi paesi dell’Europa dell’Est, come Ungheria e Polonia, il populismo di destra radicale unisce un forte nazionalismo a una marcata diffidenza verso le istituzioni europee. Questi movimenti trovano un solido sostegno tra coloro che si sentono svantaggiati dai rapidi cambiamenti economici e sociali degli ultimi decenni. In Italia, il sistema politico ha visto un cambiamento significativo con l’affermarsi di un populismo diviso: il Movimento 5 Stelle ha mostrato una forte presenza al Sud, spesso legata a un diffuso disagio sociale, mentre la Lega ha prevalso al Nord, anche in aree tradizionalmente industriali, esprimendo frustrazione e richieste di autonomia o cambiamento. Parallelamente, il tradizionale partito di centrosinistra ha visto spostare il suo bacino di supporto verso le classi sociali più alte e le aree urbane più prospere.Ma davvero il voto “populista” si spiega solo con la geografia del malcontento e il disagio economico?
Il capitolo offre un’analisi convincente del legame tra disuguaglianze territoriali e sociali e le nuove fratture politiche. Tuttavia, un modello che si concentra quasi esclusivamente su questi fattori rischia di trascurare altre dimensioni cruciali del fenomeno populista, come le dinamiche culturali, identitarie, la percezione della sovranità, il ruolo dei media digitali o la crisi di fiducia nelle istituzioni. Per una comprensione più completa, sarebbe utile integrare questa prospettiva con studi di scienza politica e sociologia che esplorano le motivazioni non strettamente economiche del voto e del consenso ai movimenti populisti. Autori come Cas Mudde o Nadia Urbinati offrono spunti importanti su questi aspetti.3. Il Vuoto del Padre Politico
Oggi il modo in cui la società e la politica funzionano sta cambiando in modo profondo. Non sono più i grandi centri urbani il luogo principale dove nascono i conflitti e le trasformazioni sociali, come succedeva con il vecchio modello industriale. Sebbene il potere economico rimanga nelle aree metropolitane, la formazione delle idee e della mentalità collettiva si sposta verso la vita di tutti i giorni e le relazioni che si creano nei luoghi più piccoli, nelle periferie. Questo significa che la dinamica sociale e politica si sta spostando dai centri alle zone circostanti.La Crisi dei Partiti Tradizionali
Questo spostamento coincide con un forte indebolimento dei partiti politici di una volta, specialmente quelli di sinistra. Questi partiti non riescono più a rappresentare le diverse parti della società come facevano un tempo. Molti sentono che la classe politica si è allontanata dalla gente comune, cercando invece legami con i gruppi potenti a livello mondiale. Questa mancanza di rappresentanza e la percezione di abbandono generano molta rabbia tra le persone. Questa rabbia spinge le persone ad appoggiare leader populisti che spesso arrivano proprio dalle periferie.Il Vuoto di Riferimento
Se guardiamo più a fondo, i partiti politici, in passato, offrivano alla comunità qualcosa di molto importante. Fungevano da punto di riferimento, dando alle persone un senso di appartenenza e aiutandole a capire il loro posto nella società. Si può paragonare questo ruolo a quello che nella psicologia individuale viene chiamato il ‘Nome-del-Padre’, che aiuta a definire l’identità e a dare ordine. La loro crisi attuale non è solo politica, ma crea un vero e proprio ‘vuoto’ in questo spazio simbolico che riguarda tutta la collettività. Manca un riferimento forte che dia orientamento e unità.Le Conseguenze del Vuoto e il Populismo
Questo vuoto di riferimento contribuisce in modo significativo a una diffusa mancanza di fiducia verso le istituzioni politiche. È chiaro, anche dai dati disponibili, che le persone si fidano sempre meno dei partiti in molti paesi occidentali. Quando manca questo punto di riferimento tradizionale che dava un senso di identità e ordine, si crea uno spazio libero. Questo spazio viene percepito e sfruttato da nuove forze. Il populismo emerge proprio per occupare questo spazio lasciato vuoto dal declino del sistema dei partiti di una volta, offrendo nuove, seppur diverse, forme di identificazione e appartenenza.Davvero tutta questa disuguaglianza e questo malessere politico sono solo colpa della crisi del 2007?
Il capitolo, pur descrivendo con efficacia le conseguenze della crisi del 2007, tende a presentarla come la causa quasi esclusiva delle nuove disuguaglianze e delle fratture sociali e politiche. Questa impostazione rischia di trascurare le tendenze di aumento della disuguaglianza e di trasformazione del mercato del lavoro che erano già in atto da decenni prima del 2007. Per comprendere appieno il contesto, è utile studiare la storia economica e la sociologia delle disuguaglianze su un arco temporale più ampio, magari approfondendo il lavoro di autori come Piketty o Stiglitz, che analizzano le cause strutturali di lungo periodo di questi fenomeni.7. Rancore e psicopolitica
L’impoverimento può avere un effetto profondo sulle persone, trasformandole e riempiendole di una forte ira. Questa rabbia, che nasce da un senso di frustrazione e fallimento materiale, si manifesta a volte in modo violento e si dirige spesso verso i gruppi più deboli della società. Episodi accaduti in Italia mostrano chiaramente questa dinamica. Pensiamo all’incendio dei campi rom a Ponticelli nel 2008, un evento drammatico in cui baracche furono bruciate e una donna arrivò a sputare su una bambina rom, tra gli applausi della folla presente. Un altro esempio è il presidio ostile avvenuto a Opera nel 2006, dove una tendopoli provvisoria per famiglie rom fu incendiata, seguito da un lungo periodo di molestie verso i volontari che cercavano di portare aiuto. Questi fatti non sono isolati, ma indicano un rancore diffuso.Il Senso di Attesa Tradita
Questo rancore nasce in gran parte dalla crescente distanza tra l’immagine di benessere che la società proietta e la realtà di precarietà in cui molte persone si trovano a vivere. È la sensazione amara di un’attesa che è stata tradita, di aver subito un danno o un’espropriazione che non trova però un modo politico per essere espressa e compresa. Questa frustrazione profonda finisce così per sfogarsi in sentimenti molto più elementari e distruttivi, come l’odio verso chi viene percepito come diverso o inferiore.Come le Emozioni Vengono Usate per Governare
Questa dinamica di rabbia e frustrazione non passa inosservata, anzi, viene spesso sfruttata da un modo di governare che potremmo definire “psicopolitica”. Si tratta di una strategia che usa abilmente le emozioni delle persone, specialmente quelle negative, per creare un forte senso di appartenenza a un gruppo. Serve anche a riempire quel vuoto di identità che molte persone sentono nella società moderna. I movimenti populisti di oggi sono particolarmente efficaci nell’usare questa strategia. Fanno leva sul pensiero più istintivo e immediato delle persone e, soprattutto, creano dei nemici ben identificabili e facili da colpire, come i migranti o le comunità rom.L’Invidia che si Rivolge Verso Chi Ha Meno
In questo quadro, l’invidia sociale assume un ruolo centrale, ma con una caratteristica particolare. Tradizionalmente, l’invidia si rivolgeva verso chi possedeva di più, verso chi stava più in alto nella scala sociale. Oggi, invece, assistiamo a un fenomeno diverso e preoccupante: l’invidia si dirige verso chi ha oggettivamente di meno, verso gli “ultimi”, da parte di chi si sente solo un po’ meglio, i “penultimi”. Questo genera dei conflitti che non puntano a migliorare la propria posizione salendo, ma sono “orizzontali”: si cerca di spingere gli altri ancora più in basso. Non si lotta per ottenere diritti o beni concreti, ma si cercano “risarcimenti” di tipo simbolico. Questi risarcimenti consistono spesso nell’escludere l’altro, nel negargli un posto, per affermare, per contrasto, il proprio status o la propria sicurezza.La Politica e lo Scambio Diseguale
La mancanza di politiche sociali efficaci e capaci di dare risposte concrete ai bisogni delle persone lascia un ampio spazio a queste retoriche populiste che fanno leva sulle emozioni negative e sull’esclusione. Invece di garantire a tutti i cittadini diritti universali e certi, il potere offre forme di riconoscimento che si basano sull’esclusione di qualcun altro o sulla fedeltà dimostrata al leader o al partito. Questo trasforma il rapporto tra i cittadini e chi governa in uno scambio profondamente diseguale: da una parte c’è chi si sente costretto a chiedere protezione e riconoscimento, dall’altra chi li concede, ma solo in cambio di lealtà o accettando l’idea che altri debbano essere esclusi.Affermare che la rabbia nata dalla precarietà si diriga naturalmente verso i più deboli, e che l’invidia colpisca solo chi sta peggio, non rischia di semplificare eccessivamente dinamiche sociali complesse?
Il capitolo presenta un legame molto diretto tra l’impoverimento, la precarietà e la manifestazione di rabbia e invidia specificamente rivolte verso i gruppi più svantaggiati. Sebbene questa dinamica sia certamente presente e documentata, le cause e le direzioni del rancore sociale sono spesso più sfaccettate e influenzate da una pluralità di fattori, non solo economici. Per comprendere meglio la complessità di questi fenomeni, è utile approfondire gli studi sulla stratificazione sociale, le dinamiche di gruppo, il pregiudizio e le teorie sul populismo. Autori come Pierre Bourdieu hanno analizzato come le posizioni nello spazio sociale influenzino percezioni e conflitti, mentre studiosi come Cas Mudde hanno indagato i meccanismi retorici e sociali dei movimenti populisti che sfruttano il risentimento. Approfondire queste prospettive può aiutare a cogliere le molteplici variabili che determinano chi diventa il bersaglio della frustrazione sociale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]