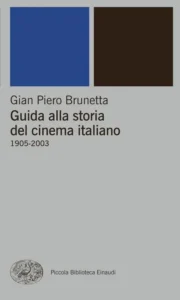Contenuti del libro
Informazioni
“La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 1932-2022” di Gian Brunetta ci porta in un viaggio incredibile attraverso la storia del festival di cinema più antico del mondo. Nato al Lido di Venezia nel 1932, quasi per caso, come parte della Biennale e legato al sogno di “Grande Venezia” di Giuseppe Volpi, questo evento è diventato subito un punto di riferimento. Il libro racconta come la Mostra del Cinema sia cresciuta, diventando un palcoscenico globale dove l’arte incontra la politica, la mondanità si scontra con la critica ideologica, e l’industria cerca nuovi mercati. Vediamo il Palazzo del Cinema trasformarsi, accogliere star internazionali e registi leggendari, da Fellini a Scorsese, da Visconti a Kurosawa. Ma non è solo glamour: la Mostra ha attraversato guerre, tensioni politiche (pensiamo alla Guerra Fredda o alla contestazione del ’68), crisi e rinascite, sempre riflettendo i grandi cambiamenti del cinema e della società. Dalle prime edizioni sotto il Fascismo, passando per la sfida di Cannes, fino all’era di Alberto Barbera che ha riportato Hollywood al Lido e aperto alla Realtà Virtuale e alle piattaforme come Netflix, questo libro ci mostra come Venezia sia rimasta un luogo unico per scoprire il cinema internazionale, dibattere sul suo futuro e celebrare la sua storia, tra premi come il Leone d’Oro e pellicole che hanno fatto epoca. È la cronaca appassionante di un festival che è molto più di una semplice rassegna di film.Riassunto Breve
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nasce al Lido di Venezia, un luogo già importante per il turismo di lusso e parte del progetto “Grande Venezia” di Giuseppe Volpi. L’idea è inserire il cinema nelle attività della Biennale per attrarre pubblico internazionale e promuovere l’immagine dell’Italia fascista. Figure come Volpi, Antonio Maraini e Luciano De Feo sono fondamentali all’inizio. La prima edizione è nel 1932, senza premi ufficiali, ma presenta film da vari paesi. Nelle prime edizioni c’è una certa libertà, ma presto aumenta l’influenza politica, con l’introduzione di premi come le Coppe Mussolini e la costruzione del Palazzo del Cinema nel 1937. Le edizioni degli anni Trenta riflettono il clima politico, con incidenti diplomatici e la proiezione di film di propaganda. Durante la guerra, la Mostra si sposta a Venezia e riduce la partecipazione internazionale. Dopo la Liberazione, la Mostra rinasce al Lido, affrontando difficoltà economiche e la concorrenza di altri festival come Cannes. Vengono reintrodotti i premi e una giuria internazionale, ma il clima della Guerra Fredda influenza giudizi e selezioni. Gli anni Cinquanta vedono la scoperta di nuove cinematografie, come quella giapponese, ma anche tensioni tra arte, politica e mondanità. La critica si divide ideologicamente. Negli anni Sessanta, direttori come Luigi Chiarini cercano di privilegiare la qualità artistica, scontrandosi con pressioni politiche e commerciali. La Mostra diventa un luogo di dibattito e accoglie nuove correnti cinematografiche. La contestazione del 1968 porta a una crisi profonda, con l’abolizione dei premi e la perdita di prestigio negli anni Settanta. Vengono tentate riforme e decentramenti, ma la Mostra viene sospesa per alcuni anni. La rinascita avviene alla fine degli anni Settanta con Carlo Lizzani, che reintroduce premi e giuria internazionale, riportando pubblico e attenzione. Seguono direzioni che puntano sugli autori (Gian Luigi Rondi) o affrontano controversie (Guglielmo Biraghi con *L’ultima tentazione di Cristo*). Gillo Pontecorvo negli anni Novanta ristabilisce i legami con Hollywood. La trasformazione della Biennale in ente privato alla fine degli anni Novanta porta nuovi direttori come Alberto Barbera e Marco Müller, che rinnovano la selezione, esplorano nuove tecnologie (Realtà Virtuale) e creano nuove sezioni (Orizzonti, Venezia Classici, Giornate degli Autori). Nonostante problemi strutturali e finanziari, la Mostra si afferma come trampolino per film che ottengono successo internazionale, inclusi premi Oscar. La sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del settore e di mantenere un equilibrio tra cinema d’autore, mercato e nuove piattaforme le permette di conservare un ruolo centrale nel panorama festivaliero mondiale, anche affrontando sfide recenti come la pandemia nel 2020. I luoghi simbolo come il Palazzo del Cinema, i premi (Leone d’Oro, Coppa Volpi) e la presenza di grandi personalità definiscono la sua storia.Riassunto Lungo
1. Il Lido: Nascita di un Festival Mondiale
L’isola del Lido a Venezia è il luogo dove sono nati i primi festival internazionali del cinema. Questa zona è da molto tempo un punto di riferimento per le immagini. La Mostra del Cinema è stata il culmine di un percorso e ha reso il Lido un importante punto d’incontro per le immagini a livello europeo e internazionale.
Il progetto “Grande Venezia” e la scelta del Lido
La scelta del Lido come sede della Mostra è legata al progetto di Giuseppe Volpi chiamato “Grande Venezia”. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Volpi voleva cambiare l’immagine di Venezia, che sembrava ferma nel tempo. Voleva promuovere la modernità, unendo lo sviluppo delle industrie a Marghera con il turismo di lusso al Lido.
Il Lido come meta di lusso
Come parte di questo progetto, il Lido si era già trasformato all’inizio del Novecento in una meta turistica di lusso. Qui erano stati costruiti grandi alberghi come l’Excelsior e l’Hotel des Bains, oltre a ville e strutture per il divertimento. Era diventato un luogo famoso in tutto il mondo, chiamato “l’isola delle meraviglie”.
La Mostra completa l’offerta
La Mostra del Cinema ha completato questa offerta di turismo e vita sociale. La sua posizione al Lido, spesso descritta come la “più bella spiaggia del mondo”, ha aiutato molto il suo successo. La Mostra è stata promossa con cinegiornali e filmati, rafforzando l’idea del Lido come capitale del cinema.
L’impatto sulla città e sul cinema
Fin da subito, la Mostra ha attirato l’attenzione del mondo del cinema. Questo evento ha cambiato l’immagine di Venezia per molte persone, mostrandola come una città rinnovata e un importante centro culturale internazionale. La storia della Mostra ha portato alla nascita di altri festival nel tempo, come quello di Cannes, che pur essendo nato in modo diverso, ha preso spunto da Venezia. Questi festival sono diventati una rete mondiale per far circolare i film, dando visibilità anche a opere meno conosciute. Permettono anche di riscoprire film vecchi e restaurati, aiutando a conservare la memoria del cinema.
Il capitolo lega strettamente la nascita della Mostra al progetto “Grande Venezia” e al turismo di lusso. Ma non si rischia così di sminuire il suo significato culturale e il contesto politico della sua creazione?
Il capitolo, pur offrendo un quadro chiaro del legame tra la Mostra e lo sviluppo turistico del Lido, concentra l’attenzione quasi esclusivamente sull’aspetto economico e mondano. Questo approccio rischia di trascurare il ruolo fondamentale che la Mostra assunse fin da subito come evento culturale di portata internazionale e, soprattutto, il suo inserimento nel contesto politico dell’epoca. Per comprendere appieno la genesi e il significato della Mostra, sarebbe opportuno approfondire la storia del cinema italiano e internazionale negli anni ’30, la politica culturale del regime fascista e il ruolo degli eventi espositivi nell’Italia di quel periodo. Autori che si sono occupati della storia del cinema sotto il fascismo o della storia della Biennale di Venezia possono fornire il contesto necessario.2. L’alba del cinema a Venezia
L’idea di includere il cinema tra le attività della Biennale di Venezia nel 1930 nasce dalla visione di Giuseppe Volpi, che all’epoca presiedeva l’istituzione. Volpi intuì il grande potenziale del cinema sonoro come strumento per attrarre un pubblico internazionale di alto livello, creando eventi che unissero cultura e mondanità. Questa nuova iniziativa si affiancò al settore musicale, che era stato introdotto poco prima su suggerimento del segretario Antonio Maraini. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, destinata a diventare un appuntamento fisso, prese forma concreta grazie all’azione congiunta di Volpi, Maraini e Luciano De Feo, figure diverse ma unite da un obiettivo comune.Le figure chiave e i loro obiettivi
Questi tre uomini furono i motori dell’iniziativa, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie motivazioni, ma tutti orientati a usare la Biennale per promuovere l’immagine dell’Italia fascista a livello internazionale e riportare Venezia al centro della scena culturale. Giuseppe Volpi, figura poliedrica e profondamente legata alla città lagunare, vedeva la presidenza della Biennale come un’opportunità quasi “ducale” per rinnovare Venezia. Antonio Maraini, fascista convinto con legami diretti con Mussolini, mirava a rilanciare l’arte italiana e a porre la Biennale sotto il controllo statale, trasformandola in un ente autonomo già nel 1930. Luciano De Feo, direttore dell’Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa (ICE), fu l’organizzatore principale dell’evento; credeva fermamente nel cinema come mezzo di educazione e pacificazione universale e sfruttò la sua vasta rete di contatti internazionali per garantire la partecipazione di film da tutto il mondo, inclusi paesi come gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica.La prima edizione del 1932
La prima edizione della Mostra si tenne nel 1932 e si distinse per non avere ancora un carattere competitivo ufficiale. Un aspetto innovativo e apprezzato fu la proiezione dei film in lingua originale e senza tagli di censura, permettendo al pubblico di vedere le opere nella loro forma autentica. Furono presentate pellicole provenienti da diverse nazioni, offrendo uno spaccato della produzione cinematografica internazionale del tempo. Tra i film proiettati c’erano Il cammino verso la vita dall’Unione Sovietica, Ragazze in uniforme dalla Germania, Dr. Jekyll and Mr. Hyde dagli Stati Uniti, e Gli uomini, che mascalzoni! dall’Italia. L’evento riscosse subito grande interesse, attirando un pubblico variegato che andava dall’alta società alla borghesia veneziana.Gli anni iniziali: autonomia e successo
Nelle prime edizioni, dal 1932 al 1934, la Mostra godette di una notevole autonomia rispetto alle dirette ingerenze politiche del regime fascista. Si presentò come un luogo di libero scambio culturale a livello internazionale, favorendo il confronto tra diverse cinematografie. Critici cinematografici come Mario Gromo e Francesco Pasinetti iniziarono ad analizzare i film e il nascente linguaggio cinematografico, contribuendo in modo significativo a legittimare la critica cinematografica in Italia. Il successo immediato della manifestazione confermò il riconoscimento del cinema come una vera e propria forma d’arte a livello internazionale.Ma come poteva una manifestazione nata per “promuovere l’immagine dell’Italia fascista” godere contemporaneamente di “notevole autonomia” ed essere un luogo di “libero scambio culturale”?
Il capitolo evidenzia una potenziale contraddizione: se da un lato si afferma che le figure chiave intendevano usare la Mostra per fini propagandistici del regime, dall’altro si descrivono le prime edizioni come caratterizzate da autonomia e libero scambio. Questa tensione solleva interrogativi sulla reale natura dell’evento sotto il fascismo. Per comprendere meglio come le istituzioni culturali potessero navigare tra le direttive del regime e una parvenza di indipendenza, è fondamentale approfondire la storia del fascismo e il suo rapporto con le arti e la propaganda. Si possono consultare le opere di storici che hanno studiato il ventennio, come Emilio Gentile, o quelle specifiche sulla storia della Biennale e del cinema italiano del periodo.3. Venezia: Schermo e Potere
La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si definisce fin dalle sue prime edizioni attraverso diverse funzioni importanti. Si propone di promuovere il cinema come forma d’arte, ma agisce anche come strumento per la diplomazia culturale e la politica internazionale. È un luogo dove l’industria cinematografica può fare affari, una vetrina per le nuove tecniche espressive e un punto d’incontro fondamentale per la critica e il confronto culturale. Le ragioni legate al turismo e agli eventi mondani, spinte da figure come Volpi, sono cruciali per ottenere i finanziamenti necessari e garantire il successo iniziale, anche se altri organizzatori le considerano meno importanti rispetto agli obiettivi artistici e culturali.L’edizione del 1934
L’edizione del 1934 vede un aumento significativo dei paesi partecipanti e dei film presentati. Per migliorare la selezione, viene introdotto un sistema che prevede l’invito diretto dei film, superando la semplice ricezione delle opere inviate. Questa edizione è segnata dallo scandalo provocato dal film Extase, che suscita reazioni molto forti nel pubblico e accesi dibattiti tra i critici a causa di alcune scene esplicite. Il documentario si afferma come forma d’arte riconosciuta, grazie al premio assegnato a L’uomo di Aran. Una rassegna dedicata ai film sovietici attira molta attenzione e riceve un grande consenso critico. Si inizia a notare una differenza nel pubblico, con aspettative e reazioni diverse ai film proiettati. Emerge l’idea di creare un archivio dove conservare i film e uno spazio dedicato al mercato per l’industria. I premi, come le Coppe Mussolini, mostrano una crescente influenza del governo, anche se alcuni critici percepiscono ancora questa edizione come relativamente libera da forti condizionamenti politici.Il cambiamento del 1935
Nel 1935, la Mostra diventa un appuntamento annuale, rafforzando così il suo prestigio a livello internazionale. Viene istituita una giuria internazionale ufficiale, e tra i suoi membri figurano persone nominate direttamente dal governo fascista, come Luigi Freddi e Luigi Chiarini. Questo passaggio segna un chiaro aumento del controllo politico sulla manifestazione. La Mostra si allinea con la Camera internazionale del film, un organismo voluto dalla Germania per coordinare il cinema europeo e contrastare l’influenza americana. L’inaugurazione del 1935, con il discorso di Galeazzo Ciano, definisce esplicitamente il cinema come uno strumento politico e di propaganda al servizio del regime fascista. Viene creato uno spazio dedicato ai film sperimentali e alle cinematografie minori, attirando un pubblico specifico interessato a queste produzioni. Nonostante la crescente politicizzazione e la presenza di film di propaganda, la Mostra continua a essere un importante punto di incontro internazionale e un luogo cruciale per la formazione e l’affermazione della critica cinematografica, che si trova a dover affrontare pressioni esterne e nuove divisioni basate sulle ideologie politiche. Figure come Flavia Paulon diventano essenziali per gestire i rapporti con i rappresentanti degli altri paesi.È possibile comprendere il “palcoscenico” della Mostra senza considerare il suo contesto storico e politico?
Il capitolo elenca figure politiche di spicco come Joseph Goebbels e Winston Churchill tra i partecipanti, ma non approfondisce il significato della loro presenza né il contesto storico-politico in cui la Mostra è nata e si è sviluppata, specialmente nei suoi primi anni. Questo approccio rischia di presentare un quadro incompleto. Per cogliere appieno l’identità e l’evoluzione della Mostra, è fondamentale esplorare la storia del fascismo italiano, il ruolo della cultura e del cinema come strumenti politici e di propaganda, e le dinamiche internazionali che hanno influenzato l’evento fin dalle origini. Approfondire la storia del cinema italiano e i suoi legami con il potere politico del tempo, studiando autori che si sono occupati di storia contemporanea e storia del cinema, può fornire le chiavi di lettura necessarie.32. Cronache di Premi e Pellicole
Il cinema riceve importanti riconoscimenti nel corso degli anni, in particolare al Festival di Venezia. Vengono assegnati premi prestigiosi come il Leone d’Oro, il Leone d’Argento e la Coppa Volpi, coprendo un lungo periodo che va dal 1947 fino al 2020 e celebrando registi, attori e film che hanno lasciato un segno.Premi Principali
Tra i riconoscimenti più ambiti figurano il Leone d’Oro per il miglior film e il Leone d’Argento. Molti registi di fama mondiale hanno ricevuto il Leone d’Oro per le loro opere.- Roberto Rossellini
- Luchino Visconti
- Michelangelo Antonioni
- Gillo Pontecorvo
- Federico Fellini
- Francis Ford Coppola
- Robert Altman
- Takeshi Kitano
- Ang Lee
- Aleksandr Sokurov
- Alfonso Cuarón
Riconoscimenti alla Carriera
Il festival celebra anche le figure che hanno contribuito in modo significativo all’arte cinematografica con il Leone alla carriera. Questo premio onora l’insieme del lavoro di registi e attori che hanno segnato la storia del cinema.- Jean-Luc Godard
- Charlie Chaplin
- Robert De Niro
- Clint Eastwood
- Hayao Miyazaki
- David Lynch
- John Woo
- Francesco Rosi
- Ermanno Olmi
- Marco Bellocchio
- Jean-Paul Belmondo
- Pedro Almodóvar
- Tilda Swinton
- Robert Redford
- Jane Fonda
La Coppa Volpi è un altro premio importante assegnato agli attori e alle attrici per le loro interpretazioni. Tra i premiati con questo riconoscimento figurano nomi celebri come Sophia Loren, Toshiro Mifune e Massimo Troisi, che hanno dimostrato grande talento sullo schermo.
Film che hanno fatto la Storia
Nel corso di questo lungo periodo, molti film che hanno segnato la storia del cinema sono stati presentati o premiati al festival. Queste pellicole rappresentano una vasta gamma di generi e stili, mostrando l’evoluzione del linguaggio cinematografico attraverso le decadi e l’importanza del festival come vetrina per opere fondamentali.- Film di Jean Renoir
- Film di Roberto Rossellini
- Film di Akira Kurosawa
- Film di Federico Fellini
- Film di Luchino Visconti
- Film di Stanley Kubrick
- Film di Pier Paolo Pasolini
- Film di Bernardo Bertolucci
- Film di Pedro Almodóvar
- Film di Martin Scorsese
- Film di Jane Campion
- Film di Zhang Yimou
- Film di Abbas Kiarostami
- Film di Takeshi Kitano
- Film di Sofia Coppola
- Film di Alejandro Amenábar
- Film di Darren Aronofsky
- Film di Kathryn Bigelow
- Film di Samuel Maoz
- Film di Aleksandr Sokurov
- Film di Roman Polański
- Film di Kim Ki-duk
- Film di Gianfranco Rosi
- Film di Alfonso Cuarón
- Film di Chloé Zhao
Davvero una semplice lista di nomi e premi, pur coprendo un lungo periodo, può rendere giustizia alla complessità e all’evoluzione del cinema al Festival di Venezia?
Il capitolo elenca meticolosamente premiati e registi, ma questa carrellata di nomi, pur utile come riferimento, non spiega perché queste figure o questi film siano stati cruciali, né come il festival e il cinema stesso si siano trasformati nel lungo periodo considerato. Per comprendere appieno il significato di questi riconoscimenti e l’impatto di queste opere, sarebbe fondamentale approfondire la storia del cinema e la critica cinematografica, studiando autori che hanno analizzato l’evoluzione del linguaggio filmico e il ruolo culturale dei festival.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]