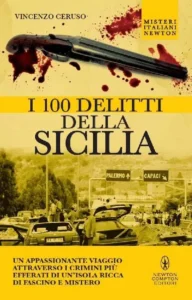Contenuti del libro
Informazioni
questo libro ti porta dentro una storia italiana pazzesca, quella dei legami oscuri tra la mafia, soprattutto Cosa Nostra in Sicilia, e i gruppi neofascisti come Ordine Nuovo. Non è solo una storia di criminalità, ma di come queste forze si siano unite, spesso con l’aiuto di pezzi deviati dello Stato e dei servizi segreti, per creare caos e paura, la famosa “strategia della tensione”. Si parte dal dopoguerra in Sicilia, con figure come Giuliano e la strage di Portella della Ginestra, e si arriva alle bombe degli anni ’70 e ’80 in città come Milano (Piazza Fontana), Brescia (Piazza della Loggia) e Bologna, fino alle stragi mafiose degli anni ’90 (Capaci, Via D’Amelio). Il filo rosso sono i depistaggi continui, le indagini deviate, la P2 che spunta ovunque. È un viaggio attraverso eventi terribili e personaggi ambigui, che mostra un’Italia dove la verità è stata spesso nascosta per proteggere poteri occulti.Riassunto Breve
La storia d’Italia dal dopoguerra in poi mostra una serie di eventi violenti e misteriosi che sembrano collegati tra loro da fili nascosti. Dopo la guerra, la mafia in Sicilia riprende forza, legandosi alle nuove autorità e scontrandosi con i movimenti dei lavoratori. In parallelo, nascono gruppi legati al vecchio fascismo, e la paura del comunismo spinge alcuni verso azioni illegali. Persone legate al fascismo mantengono posizioni nello Stato, anche se ricercate. Mafia e neofascisti sembrano attingere dallo stesso ambiente di chi vuole sovvertire l’ordine. In Sicilia, il bandito Giuliano, con legami neofascisti, attacca i partiti di sinistra e i sindacalisti, culminando nella strage di Portella della Ginestra nel 1947 contro contadini in festa, una risposta politica al successo delle sinistre. Le indagini su Giuliano mostrano subito depistaggi e complicità con pezzi dello Stato e capi mafia che lo proteggono. Negli anni Sessanta, questa tensione aumenta con la “strategia della tensione”, dove si usano bombe e falsi allarmi per creare paura e spingere verso un governo più forte. Gruppi neofascisti come Ordine Nuovo sono centrali in questa strategia, con legami internazionali e l’uso di esperti di esplosivi. Gli attentati colpiscono treni e luoghi pubblici, e le indagini vengono spesso deviate, con prove manomesse o distrutte. Il 12 dicembre 1969, le bombe di Piazza Fontana a Milano e a Roma segnano l’inizio di questa fase. Le indagini puntano subito sugli anarchici, portando alla morte di Giuseppe Pinelli e all’accusa di Pietro Valpreda, poi assolto. Emerge però la pista neofascista e il coinvolgimento dei servizi segreti (SID) che coprono i loro informatori legati a questi gruppi. Ufficiali del SID vengono poi condannati per aver aiutato a nascondere la verità. In questo periodo c’è anche il tentato golpe Borghese nel 1970, un piano per prendere il potere con l’aiuto di neofascisti, militari e forse mafia e Loggia P2, bloccato all’ultimo. Le indagini su questo golpe sono ostacolate, e giornalisti e magistrati che indagano su questi legami vengono uccisi. Negli anni Settanta, la trama eversiva continua, con gruppi neofascisti che agiscono per destabilizzare il paese, a volte finanziati dall’estero. L’attentato di Peteano nel 1972, dove muoiono carabinieri, viene inizialmente attribuito alla sinistra, ma un neofascista confessa, dicendo che lo Stato strumentalizza l’eversione nera. Le sentenze confermano che pezzi dello Stato sono coinvolti in piani di destabilizzazione. La strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, attribuita a neofascisti di Ordine Nuovo, e l’attentato all’Italicus nello stesso anno, mostrano come lo stragismo politico sia legato a progetti autoritari, con coperture in ambienti massonici (P2) e servizi segreti. Anche l’omicidio di Peppino Impastato nel 1978, che denunciava la mafia, viene inizialmente fatto passare per un suicidio terroristico, con depistaggi da parte delle forze dell’ordine, mostrando i legami tra mafia, eversione nera e pezzi deviati dello Stato. La strage di Bologna del 1980, attribuita a neofascisti, è un esempio enorme di depistaggio da parte dei servizi segreti e della P2, che cercano di inventare piste false. L’omicidio di Piersanti Mattarella a Palermo nel 1980, un politico che combatteva la corruzione legata alla mafia, presenta legami con ambienti neofascisti e mafiosi, con membri della P2 nelle indagini e tentativi di depistaggio. Anche se la mafia è stata condannata come mandante, si ipotizza che l’esecuzione sia stata affidata a neofascisti, suggerendo una collaborazione tra mafia ed eversione nera. La vicenda del banchiere Michele Sindona, legato a mafia e finanza, e il ritrovamento degli elenchi della P2, mostrano quanto fossero intrecciati finanza, mafia, servizi deviati e massoneria nel destabilizzare il paese. Dopo il 1989, la mafia cerca nuovi accordi con lo Stato, a volte tramite figure con legami sia mafiosi che eversivi. Tra il 1992 e il 1994, la mafia usa le bombe contro lo Stato (Capaci, Via D’Amelio, ecc.) per ottenere concessioni. Si pensa a un “sistema criminale” più ampio che unisce mafia, destra eversiva, massoneria e pezzi dello Stato per cambiare il sistema politico. Nella strage di Via D’Amelio, le indagini vengono depistate con un falso pentito, e il capo delle indagini viene accusato di aver orchestrato tutto, forse per nascondere i veri responsabili o i legami con altri poteri. La sigla “Falange Armata”, usata per rivendicare attentati, è stata collegata a sedi dei servizi segreti. Tutto questo fa pensare che l’Italia abbia vissuto una situazione particolare, dove una “struttura di condizionamento” ha legato diverse forze, inclusa l’eversione neofascista e la mafia, con pezzi delle classi dirigenti che agiscono al di sopra della legge per influenzare il paese. Chi dovrebbe difendere lo Stato a volte copre o dirige queste azioni. Nonostante la complessità e i depistaggi, la lotta ha portato a condannare molti responsabili di stragi, anche se non tutti i misteri sono stati risolti.Riassunto Lungo
1. Dalla Sicilia alle Bombe: Trame Nascoste
Dopo lo sbarco alleato in Sicilia nel 1943, la mafia riemerge nel dopoguerra. Stringe legami con le nuove autorità e diventa più potente, ostacolando le organizzazioni dei lavoratori. Uomini come Calogero Vizzini mostrano come la mafia si adatta ai cambiamenti economici. Nello stesso tempo, nascono gruppi legati al vecchio regime fascista. La paura del comunismo favorisce azioni violente e illegali. Persone che avevano legami col fascismo restano o salgono di grado nello Stato, anche se ricercate per crimini di guerra. Mafia e neofascisti trovano sostegno negli stessi ambienti che cercano il disordine.Il bandito Giuliano e Portella della Ginestra
In Sicilia, appare il bandito Salvatore Giuliano, capo di una banda armata. Giuliano ha legami con gruppi neofascisti e ottiene da loro armi e addestramento. La sua banda attacca i partiti di sinistra e i sindacalisti. La strage di Portella della Ginestra, il 1° maggio 1947, è compiuta dalla banda di Giuliano. Colpisce contadini riuniti per una festa ed è una risposta politica al successo elettorale dei partiti di sinistra in Sicilia. Le indagini e i processi sulla banda di Giuliano mostrano tentativi di depistaggio e complicità. Elementi dello Stato e capi mafia proteggono il bandito e cercano di influenzare quello che dice. Gaspare Pisciotta accusa figure importanti dello Stato di essere i mandanti, ma le sue parole non vengono confermate. Pisciotta poi muore in carcere.Bombe e depistaggi nella strategia della tensione
Negli anni Sessanta, si diffonde la “strategia della tensione”. Si usano operazioni come i “Manifesti cinesi”, che sono falsi manifesti che sembrano scritti dai comunisti. Servono a creare paura nella società e a giustificare azioni repressive. Gruppi neofascisti come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale partecipano attivamente a questa strategia. Questi gruppi hanno contatti internazionali, per esempio con Aginter Press e OAS. Imparano tecniche per infiltrarsi e per combattere come in una guerriglia. Cercano di infiltrarsi anche nelle forze armate. Usare esplosivi diventa molto importante. Figure come Carlo Digilio, esperto di bombe per Ordine Nuovo, sono centrali in questo. L’esplosivo è quasi una “firma” degli attentati. Per depistare le indagini, si manomettono o si distruggono le prove legate agli esplosivi. Bombe colpiscono treni e, a Trieste, una scuola slovena. Questo avviene in un periodo di tensioni ai confini e di forte anticomunismo. Anche apparati dello Stato provano a depistare le indagini, come nel caso del generale Maletti, cercando di portarle fuori strada.Se le “trame nascoste” coinvolgono apparati dello Stato, perché il capitolo non affronta la persistente mancanza di verità giudiziaria su molti dei depistaggi e delle complicità evocate?
Il capitolo suggerisce un coinvolgimento di apparati dello Stato nelle “trame nascoste” e nei depistaggi. Tuttavia, la narrazione storica di questi eventi (dalla vicenda Giuliano alla strategia della tensione) si scontra spesso con la persistente mancanza di verità giudiziaria completa e con sentenze controverse o incomplete. Molte delle complicità evocate rimangono in aree grigie, oggetto di dibattito storiografico e legale. Per approfondire queste complessità, è utile studiare la storia della giustizia italiana e le indagini sui grandi misteri del dopoguerra. Autori come Guido Salvini o Aldo Giannuli offrono prospettive diverse su questi temi.2. L’ombra dello Stato sulle Stragi
Il 12 dicembre 1969, una serie di esplosioni a Milano e Roma segna l’inizio di un periodo di forte tensione in Italia. Questa strategia mira a diffondere paura e incertezza per favorire un cambiamento politico verso un sistema più autoritario, cercando di attribuire la responsabilità all’estrema sinistra. L’attentato più grave colpisce la Banca Nazionale dell’Agricoltura a Milano, causando la morte di sedici persone e il ferimento di ottantotto.Le prime indagini e il caso Pinelli
Le indagini si concentrano fin da subito sugli ambienti anarchici. Giuseppe Pinelli, un anarchico milanese, viene fermato e muore tragicamente cadendo da una finestra della questura dopo giorni di interrogatori. Inizialmente, la polizia parla di suicidio, ma le successive inchieste escludono sia questa ipotesi che l’omicidio volontario, suggerendo invece un malore causato dallo stress e dalla mancanza di riposo. La morte di Pinelli diventa rapidamente il simbolo di un possibile tentativo di depistaggio delle indagini. Un altro anarchico, Pietro Valpreda, viene accusato in base a testimonianze controverse, ma sarà poi assolto. In questo contesto, emerge anche la figura di Mario Merlino, un anarchico che risulta avere legami con l’estrema destra romana e che si sospetta fosse un infiltrato.La pista neofascista e il ruolo dei servizi segreti
In seguito, le indagini prendono una nuova direzione, puntando verso gruppi neofascisti veneti legati a Ordine Nuovo, come Franco Freda e Giovanni Ventura, che tuttavia verranno assolti per la strage di Piazza Fontana. Durante le indagini, viene alla luce il coinvolgimento dei servizi segreti dello Stato, in particolare il SID (Servizio Informazioni Difesa). Si scopre che il SID ha protetto e favorito la fuga di informatori come Guido Giannettini e Marco Pozzan, che avevano contatti con gli ambienti neofascisti. Alcuni ufficiali del SID, tra cui il generale Maletti e il capitano Labruna, vengono poi condannati per favoreggiamento personale per aver coperto i loro contatti e ostacolato la giustizia.Il tentato golpe Borghese e i misteri irrisolti
In questo quadro complesso si inserisce anche il tentato colpo di Stato del 7 dicembre 1970, guidato dal principe Junio Valerio Borghese, noto per essere stato un comandante della X Mas durante la guerra. Il piano prevede l’occupazione di punti chiave dello Stato con l’appoggio di neofascisti, militari e forse anche elementi della mafia e della Loggia P2. L’operazione viene interrotta all’ultimo momento, forse per la mancanza di un sostegno militare sufficiente o per un intervento esterno ancora non del tutto chiaro. Le indagini su questo tentativo di golpe incontrano numerosi ostacoli. Il giornalista Mauro De Mauro, che stava indagando proprio sul golpe, scompare misteriosamente nel 1970. L’anno successivo, nel 1971, viene ucciso il procuratore Pietro Scaglione, che si occupava del caso De Mauro. Questi eventi mettono in luce i profondi e preoccupanti legami che esistevano in quel periodo tra l’estremismo di destra, i tentativi di sovvertire l’ordine democratico, settori degli apparati statali e la criminalità organizzata.Se l’ombra dello Stato era così evidente, perché la giustizia non è riuscita a fare piena luce e a individuare tutti i responsabili?
Il capitolo mette in luce la presenza di legami tra estremismo, apparati statali deviati e criminalità organizzata, eppure le vicende giudiziarie citate (le assoluzioni, le condanne solo per favoreggiamento, i misteri irrisolti) sembrano non aver mai raggiunto una verità completa e definitiva sull’intera “strategia della tensione”. Per comprendere questa apparente contraddizione, è fondamentale approfondire la storia del sistema giudiziario italiano negli anni di piombo, il ruolo dei servizi segreti e le dinamiche politiche che hanno influenzato le indagini. Utile è lo studio della storiografia sul periodo, che ha cercato di colmare le lacune lasciate dalle sentenze, e l’analisi delle inchieste parlamentari. Autori come De Lella, Fasanella, e Sofri offrono prospettive diverse e approfondite.3. Trame Nere e Segreti di Stato
Negli anni Settanta in Italia si manifesta un tentativo eversivo da parte della destra reazionaria, un movimento con solide basi organizzative e finanziarie che gode di appoggi sia interni che internazionali. Questo tentativo di sovversione non si esaurisce rapidamente, ma rappresenta una minaccia concreta per la stabilità del Paese. Già nel 1972, Arnaldo Forlani denuncia pubblicamente questa trama oscura, suggerendo che alcuni dei responsabili si nascondono all’interno delle stesse strutture dello Stato. L’obiettivo principale di questa strategia è chiaro: creare disordine e paura per destabilizzare il Paese e favorire così una svolta di tipo autoritario.La strategia e i gruppi eversivi
Diversi gruppi sono attivi in questo contesto, tra cui spiccano Ordine Nuovo e il Movimento di Azione Rivoluzionaria (MAR), formazioni che talvolta si trovano anche in contrasto con il Movimento Sociale Italiano. Queste organizzazioni ricevono finanziamenti significativi, anche dall’estero, a dimostrazione della portata del progetto eversivo. La strategia adottata si basa sulla creazione deliberata di disordine e terrore nella popolazione, con lo scopo di generare una diffusa richiesta di ordine e sicurezza che possa giustificare misure autoritarie. Vincenzo Vinciguerra, un militante neofascista, descrive efficacemente questo approccio con la frase “destabilizzare per stabilizzare”, riassumendo la logica perversa dietro gli attentati e le azioni violente.Gli attentati e i depistaggi
L’attentato di Peteano, avvenuto nel 1972, rappresenta un esempio tragico di questa strategia, causando la morte di tre carabinieri. Le indagini su questo attentato vengono inizialmente deviate verso la sinistra, un depistaggio che vede coinvolti anche alti ufficiali dei carabinieri, successivamente condannati per le loro azioni volte a sviare le indagini. Vincenzo Vinciguerra confessa l’attentato di Peteano, dichiarando di voler colpire lo Stato ma non i civili, e accusa apertamente settori degli apparati statali di aver strumentalizzato l’eversione nera per i propri scopi. Le sentenze emesse dalla magistratura confermano nel tempo che parti degli apparati statali sono effettivamente inquinate da soggetti che perseguono attivamente obiettivi di destabilizzazione del Paese.La strage di Piazza della Loggia a Brescia, nel 1974, è un altro episodio emblematico dello stragismo politico di quel periodo. Questo attentato, attribuito a Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, entrambi membri di Ordine Nuovo, colpisce una manifestazione antifascista e si inserisce in un clima di crescente tensione e di progetti autoritari. È significativo notare che Tramonte risulta essere una fonte dei servizi segreti e partecipa attivamente alle operazioni di depistaggio volte a nascondere la verità sull’attentato. Questo evento evidenzia i collegamenti profondi e inquietanti tra l’eversione nera, settori deviati degli apparati statali e poteri occulti come la loggia massonica P2.
Anche l’attentato all’Italicus, sempre nel 1974, che provoca la morte di 12 persone, rimane senza colpevoli definitivi, nonostante le indagini e le sentenze abbiano ricondotto la responsabilità a formazioni neofasciste. Anche in questo caso, emergono chiari collegamenti e coperture in ambienti della massoneria deviata e dei servizi segreti, a conferma di una rete di complicità che rende estremamente difficile l’accertamento completo della verità giudiziaria.
Il caso Peppino Impastato
Il caso di Peppino Impastato, ucciso nel 1978, getta ulteriore luce sui legami perversi tra mafia, eversione nera e i depistaggi operati da settori delle forze dell’ordine. Nonostante le prove raccolte sul luogo del delitto indichino fin da subito un omicidio di stampo mafioso, le indagini iniziali vengono incredibilmente indirizzate verso l’ipotesi di un suicidio a scopo terroristico. Durante questa fase investigativa, reperti fondamentali scompaiono e testimonianze cruciali vengono sistematicamente ignorate, nel tentativo evidente di nascondere la verità. Solo molti anni dopo la verità sull’omicidio e sui depistaggi inizia a emergere, portando all’incriminazione e alla condanna dei mandanti mafiosi e coinvolgendo nelle indagini anche alti ufficiali dei carabinieri che avevano gestito le prime fasi dell’inchiesta.Il capitolo parla di un “sistema criminale” e di “settori deviati dello Stato”: ma quali sono le prove definitive, o si tratta di ipotesi ancora dibattute e prive di consenso unanime?
Il capitolo accenna a ipotesi gravissime, come il coinvolgimento di apparati dello Stato in eventi traumatici. Tuttavia, la natura esatta di questo “sistema criminale” e l’estensione del presunto coinvolgimento statale sono temi estremamente complessi e tutt’altro che risolti, oggetto di indagini giudiziarie e dibattiti storiografici che non hanno raggiunto un consenso unanime. Per comprendere meglio le diverse prospettive e le difficoltà nel ricostruire questi eventi, è fondamentale approfondire gli studi sulla storia della mafia, sui servizi segreti italiani, sulle inchieste giudiziarie relative alle stragi e ai depistaggi, e sulle teorie della cospirazione. Autori come S. Lupo, I. Forgione, o chi ha seguito e scritto sui processi relativi alle stragi e alla trattativa Stato-Mafia, offrono spunti essenziali per navigare in un campo minato di verità processuali, ipotesi investigative e ricostruzioni storiografiche spesso in conflitto.6. Legami Oscuri e Verità Difficili
La storia italiana recente mostra una realtà complessa, dove sembra che il paese sia stato soggetto a regole diverse da quelle di una normale democrazia. Questa situazione crea frustrazione e rende difficile conservare il ricordo degli eventi importanti. I processi che riguardano le stragi compiute da gruppi neofascisti e dalla mafia sono spesso molto complicati, pieni di documenti difficili da capire, e questo impedisce di avere un quadro chiaro di ciò che è successo.Poteri Nascosti e Azioni Illegali
Esiste un legame nascosto, una specie di rete di influenze, che unisce diverse iniziative e gruppi, tra cui i movimenti che agiscono con violenza politica, come i neofascisti. È probabile che anche la mafia, Cosa Nostra, sia stata collegata a questa rete in vari momenti. Questa situazione fa pensare a “poteri forti che agiscono dall’alto”, cioè a classi dirigenti o gruppi di potere che si muovono al di fuori della legge, usando ogni mezzo per cambiare l’assetto del paese.Stato, Depistaggi e Verità Nascoste
Questo non significa che i mafiosi o i neofascisti siano solo dei semplici esecutori senza volontà propria. A volte, chi dovrebbe proteggere lo Stato finisce invece per coprire, nascondere prove o creare false piste (questo si chiama “depistaggio”). Altre volte ancora, sembra che siano stati proprio alcuni settori dello Stato a indirizzare certe azioni. Anche se questo ruolo non è sempre stato provato nei tribunali, appare come l’unica spiegazione logica per capire certe vicende, soprattutto quando persone che lavoravano per lo Stato erano infiltrate nelle organizzazioni criminali e non hanno impedito le stragi. Le operazioni di depistaggio servono proprio a nascondere questi legami e le lotte interne tra i vari apparati dello Stato per controllare chi agiva illegalmente.Le Ragioni di Chi Commette i Crimini
Capire perché i criminali agiscono è fondamentale. I neofascisti e i mafiosi spesso si comportano come soldati al servizio di qualcosa di più grande di loro, un “Noi” collettivo che va oltre la singola persona. Sentirsi parte di questa entità offre loro un ideale, qualcosa per cui sono disposti a fare cose terribili. Le loro motivazioni possono essere complicate, un misto di fanatismo e desiderio di trarre vantaggio personale. Per Cosa Nostra in particolare, l’organizzazione crea una specie di mondo immaginario che controlla totalmente i suoi membri. Dopo essere entrati a far parte dell’organizzazione, si diventa una persona diversa, le cui azioni hanno come unico scopo la sopravvivenza e il potere del gruppo.La Lotta per la Giustizia e i Risultati Ottenuti
Nonostante la complessità e il fatto che in passato molti colpevoli l’abbiano fatta franca, la lotta contro il terrorismo politico e la mafia ha portato a risultati importanti. Molti dei responsabili delle stragi più gravi, come quelle di piazza della Loggia, Bologna, Capaci e via D’Amelio, sono stati portati in tribunale e condannati. Anche se non tutti gli esecutori o le responsabilità sono state scoperte, oggi si conosce la vera natura e lo scopo politico di chi ha commesso questi omicidi. Raggiungere questo risultato ha richiesto un grande sforzo e ha avuto un costo altissimo.Davvero l’unica spiegazione logica per le stragi è l’indirizzo di settori dello Stato, o il capitolo trascura altre, scomode, possibilità?
Il capitolo afferma che l’indirizzo di certe azioni da parte di settori dello Stato appare come l’unica spiegazione logica. Questa è un’affermazione molto forte in un contesto storico e politico estremamente complesso e controverso. Ridurre la molteplicità di attori, interessi e dinamiche (criminalità organizzata, terrorismo, apparati statali deviati, influenze esterne) a un’unica “spiegazione logica” rischia di semplificare eccessivamente un quadro dove le responsabilità sono spesso sfumate, le interazioni caotiche e le prove difficili da interpretare definitivamente. Per approfondire la complessità di questi scenari e valutare la fondatezza di tale affermazione, è utile esplorare la storia contemporanea italiana, il diritto penale (in particolare l’analisi dei processi per stragi) e la politologia (studi sui poteri occulti e le deviazioni istituzionali). Autori come Guido Salvini o Miguel Gotor offrono prospettive basate su indagini giudiziarie o analisi storiche che possono aiutare a contestualizzare e criticare questa asserzione.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]