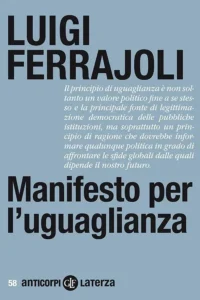Contenuti del libro
Informazioni
“La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans Kelsen” di Luigi Ferrajoli è un libro che ti porta dentro il cuore della teoria del diritto, mettendo sotto la lente d’ingrandimento il pensiero di uno dei giuristi più importanti, Hans Kelsen. Non è un romanzo, non ha personaggi nel senso classico o luoghi fisici, ma i protagonisti sono le idee: le norme giuridiche, la loro struttura (non solo il classico “se… allora…”), come esistono al di là della sanzione o della garanzia dei diritti. Ferrajoli esplora le sfide concettuali, tipo la differenza tra l’esistenza di una norma e la sua validità, o il rapporto complicato tra diritto e logica, specialmente nel pensiero di Kelsen. Un altro tema centrale è la democrazia, analizzata attraverso la lente kelseniana, confrontandola con l’idea moderna di costituzionalismo che si basa sui diritti fondamentali, mostrando come questi non limitino la democrazia, ma la rafforzino. È un viaggio intellettuale che smonta e rimonta i concetti fondamentali del diritto per capire meglio come funziona e dove la teoria di Kelsen, pur geniale, mostra i suoi punti deboli, le sue “aporie”. Se ti interessa capire cosa c’è dietro le leggi e come pensiamo il diritto oggi, questo libro ti offre una prospettiva critica e approfondita sulla logica del diritto.Riassunto Breve
Le norme giuridiche non hanno tutte la stessa struttura logica. Non si limitano alla forma “se si verifica A, allora deve esserci B”, che lega un atto a una conseguenza come una sanzione. Esistono anche norme che stabiliscono direttamente situazioni o status, come i diritti fondamentali o la capacità giuridica; queste sono chiamate norme tetiche. Le norme che legano un atto a un effetto sono invece ipotetiche. Questa distinzione, insieme a quella tra norme che regolano comportamenti (deontiche) e norme che stabiliscono status (costitutive), porta a diverse forme di norme. L’esistenza di una norma deriva dal fatto che è stata prodotta secondo le regole. Questo significa che un comportamento vietato è illecito perché c’è una norma che lo vieta, anche se manca una sanzione. Allo stesso modo, un diritto esiste se è stabilito da una norma, anche se mancano le norme che prevedono i doveri corrispondenti o le sanzioni per la sua violazione. Queste mancanze sono lacune nell’ordinamento, ma non negano l’esistenza della norma o del diritto. Un problema nella teoria del diritto è confondere l’esistenza di una norma con la sua validità. Una norma esiste se è stata creata seguendo certe forme, ma può essere invalida se non rispetta tutte le forme (validità formale) o se il suo contenuto è in contrasto con norme superiori (validità sostanziale). La validità dipende dalla conformità alle norme superiori, non dal fatto che la norma sia effettivamente rispettata o applicata (efficacia). La logica si applica al significato delle norme, non solo all’atto con cui vengono create. Le relazioni tra norme di diverso livello, come la costituzione e una legge ordinaria, sono relazioni logiche di coerenza. La scienza giuridica, pur partendo dalle norme esistenti, non è solo descrittiva; ha un ruolo critico nell’individuare le incoerenze e le lacune nel diritto, suggerendo correzioni. La democrazia rappresentativa si basa sul primato della legge e del Parlamento, visto come luogo di compromesso tra interessi diversi. Tuttavia, una visione puramente formale della democrazia, basata solo sul principio di maggioranza e sulle procedure, non basta. Le costituzioni rigide introducono limiti sostanziali attraverso i diritti fondamentali, che stabiliscono cosa la maggioranza non può fare e cosa deve fare. Questi diritti garantiscono libertà e poteri a tutti, limitando il potere della maggioranza. Il costituzionalismo, con le sue costituzioni rigide e i diritti fondamentali, non limita la democrazia, ma la rafforza e la completa, garantendo le condizioni per l’esercizio dei diritti politici e proteggendo la democrazia stessa da decisioni che potrebbero annientarla. La democrazia ha quindi una dimensione formale (diritti politici) e una sostanziale (diritti di libertà e sociali). Di fronte alle sfide globali, è necessario estendere queste garanzie costituzionali non solo ai poteri pubblici statali, ma anche ai poteri privati e sovranazionali.Riassunto Lungo
1. Oltre il Dover Essere: Le Molteplici Forme delle Norme Giuridiche
Le norme giuridiche si distinguono dalle leggi di natura. Mentre queste ultime descrivono ciò che “è” (un evento che ne causa un altro), le norme giuridiche si basano sul concetto di “dover essere”. Questo legame è specifico del diritto. Secondo una teoria, questo “dover essere” è una categoria fondamentale per capire il diritto. Significa che tra un’azione considerata illecita e la conseguenza prevista (una sanzione) esiste un legame stabilito dalla norma: “se accade A, allora deve accadere B”.Non tutte le norme seguono lo stesso schema
Questa visione, però, tende a generalizzare troppo la struttura delle norme. Non tutte le regole del diritto hanno la forma “se… allora deve essere…”. Questa struttura è tipica delle norme che prevedono un effetto (come una multa o un obbligo) solo se si verifica una certa azione. Esistono anche norme che stabiliscono direttamente una situazione o uno status, senza dipendere da un’azione precedente. Queste sono chiamate norme tetiche. Rientrano in questa categoria le norme che definiscono i diritti fondamentali, che stabiliscono chi ha la capacità di agire legalmente o che impongono semplici divieti.Due modi di stabilire le regole
È importante distinguere tra norme tetiche e norme ipotetiche. Le norme tetiche creano immediatamente una condizione o uno status (ad esempio, stabilire che una persona ha un certo diritto fondamentale o che è legalmente capace). Le norme ipotetiche, invece, prevedono un effetto che si realizza solo se si compie l’azione descritta dalla norma.Regole di comportamento e regole di status
Oltre a questa distinzione, possiamo considerare anche se una norma regola un comportamento o stabilisce uno status. Le norme deontiche regolano i comportamenti, dicendo cosa si deve o non si deve fare. Le norme costitutive stabiliscono status o condizioni.Le quattro forme delle norme
Combinando le due distinzioni (tetica/ipotetica e deontica/costitutiva), si ottengono quattro tipi logici di norme: norme tetico-deontiche, norme tetico-costitutive, norme ipotetico-deontiche e norme ipotetico-costitutive.Perché queste distinzioni contano
Capire queste diverse strutture è fondamentale per comprendere come funziona la logica del diritto. Le norme tetiche, in particolare, sono alla base di principi importanti. Ad esempio, garantiscono la coerenza del sistema legale: le leggi di livello inferiore devono rispettare le norme tetiche di livello superiore, come quelle della costituzione. Assicurano anche la completezza: se esistono diritti fondamentali (norme tetiche), il sistema legale deve prevedere norme che li rendano effettivi. Infine, influenzano il modo in cui i giudici applicano la legge: la qualificazione di un comportamento specifico in un caso concreto deriva logicamente dalla norma generale, spesso una norma tetica.Ma è davvero così netta la distinzione tra norme che “sono” e norme che “devono essere”, e queste nuove categorie risolvono davvero le complessità del diritto?
Il capitolo introduce una classificazione delle norme giuridiche che distingue tra norme tetiche e ipotetiche, presentandola come fondamentale per la logica del diritto. Tuttavia, non si confronta a sufficienza con le sfide teoriche e pratiche che sorgono dall’applicazione di queste categorie. La natura stessa del “dover essere” è oggetto di dibattito filosofico, e la rigidità della distinzione tra norme che creano uno status “immediatamente” e norme condizionali può non riflettere pienamente la complessità dell’interpretazione e applicazione giuridica. Per approfondire, è utile esplorare le opere di teorici del diritto come Kelsen, Hart, e Ross, che offrono prospettive diverse sulla struttura e la logica delle norme.2. L’esistenza delle norme oltre la sanzione e la garanzia dei diritti
Ci si interroga su come esistano le norme e i diritti, e in particolare se la loro validità o la loro piena realtà dipendano dalla presenza di sanzioni in caso di violazione o di garanzie che ne assicurino il rispetto. Questa domanda porta a confrontare diverse prospettive sulla natura del diritto.
La visione che lega norme e diritti a sanzioni e garanzie
Secondo una certa teoria, un’azione è considerata vietata e quindi illecita solo se una norma specifica prevede una conseguenza negativa, una sanzione, per chi la compie. In questa ottica, la sanzione non è solo una conseguenza, ma diventa un elemento fondamentale che definisce l’illiceità stessa. Allo stesso modo, si sostiene che un diritto appartiene veramente a qualcuno (un diritto soggettivo) solo se esiste un obbligo corrispondente per altri e se c’è la possibilità concreta, attraverso un processo legale o una sanzione, di far rispettare tale obbligo. In questa prospettiva, l’esistenza effettiva di un diritto è strettamente legata alla presenza di meccanismi che ne assicurino la tutela.
La prospettiva che non lega l’esistenza a sanzioni e garanzie
Esiste però una visione diversa, tipica del positivismo giuridico, che non lega l’esistenza di una norma o di un diritto alla presenza di una sanzione o di una garanzia. Da questo punto di vista, una norma esiste semplicemente perché è stata regolarmente creata dall’autorità competente, seguendo le procedure stabilite. Se una norma vieta un certo comportamento, quel comportamento è illecito per il semplice fatto di essere vietato dalla norma, indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno una sanzione per la sua violazione. La mancanza di una sanzione per un comportamento vietato non dimostra che il comportamento non sia illecito; piuttosto, segnala una lacuna o un’incompletezza nell’insieme delle norme esistenti.
L’esistenza dei diritti nel diritto positivo
Questo ragionamento si applica anche ai diritti. Un diritto, specialmente se fondamentale e sancito in un testo importante come una costituzione, esiste perché è stato formalmente stabilito da una norma. La sua validità non dipende dalla successiva creazione di altre norme che impongano specifici doveri a carico di altri soggetti o che prevedano sanzioni per chi non rispetta quel diritto. Certo, la logica interna del diritto suggerirebbe che un diritto implichi doveri e la possibilità di tutela; queste garanzie sono, per così dire, logicamente connesse al diritto stesso. Tuttavia, la loro assenza nel corpo delle norme positive esistenti è vista come una mancanza da colmare, un compito per il legislatore, non come una negazione dell’esistenza del diritto fondamentale.
Il diritto come sistema in evoluzione
Il diritto positivo è un sistema in continua evoluzione, dove le norme e i diritti esistono nel momento in cui vengono prodotti. Questo significa che possono benissimo esistere diritti, intesi come aspettative o posizioni giuridiche stabilite da norme, anche se le norme che impongono i doveri correlati o che prevedono le sanzioni necessarie per la loro piena realizzazione non sono ancora state create. Sebbene sia logicamente vero che un diritto “implichi” un dovere, nel contesto di un sistema giuridico in divenire, questa implicazione si configura più come un principio o una direttiva per chi crea le leggi (che dovrebbe prevedere i doveri e le garanzie corrispondenti) piuttosto che come una condizione necessaria per l’esistenza del diritto stesso nel momento in cui viene posto. I diritti fondamentali, in particolare, acquisiscono esistenza e validità semplicemente perché sono stabiliti da norme giuridiche, a prescindere dalla presenza immediata di tutte le loro possibili garanzie attuative.
Se un diritto esiste solo sulla carta, senza alcuna possibilità di tutela o sanzione per chi lo viola, possiamo davvero parlare di ‘esistenza’ nel mondo reale, o è solo una pia intenzione del legislatore?
Il capitolo, pur delineando la posizione positivista che svincola l’esistenza della norma o del diritto dalla sanzione o garanzia, lascia irrisolta la cruciale questione della sua effettività. Affermare che un diritto “esiste” formalmente anche senza i meccanismi per renderlo operativo nel consesso sociale solleva dubbi sulla sua rilevanza pratica e sulla distinzione tra una mera dichiarazione di intenti e una norma giuridica pienamente efficace. Per approfondire questa controversia, è fondamentale esplorare le diverse correnti del positivismo giuridico, confrontandole con teorie che pongono l’accento sull’efficacia sociale del diritto. Utile sarebbe leggere autori come Hans Kelsen o Herbert Hart, che hanno affrontato in modo diverso il rapporto tra validità ed efficacia delle norme.3. Le sfide concettuali della teoria del diritto
Un problema centrale nella teoria del diritto è l’idea di identificare la validità delle norme con la loro semplice esistenza. Questo modo di pensare porta a considerare impensabile che possa esistere un diritto illegittimo, cioè norme che non rispettano le regole stabilite per la loro creazione. Questa visione si scontra con l’idea che un sistema legale sia organizzato su più livelli e con il principio fondamentale che il diritto stesso stabilisce le regole per la propria produzione. Proprio perché il diritto regola la sua creazione, è possibile che tali regole vengano violate. È quindi fondamentale distinguere tra l’esistenza di una norma, la sua validità formale e la sua validità sostanziale. L’esistenza di una norma dipende dal rispetto di alcune forme essenziali nell’atto che la crea. La validità formale richiede invece che siano rispettate tutte le forme previste. La validità sostanziale, infine, richiede che il significato della norma sia coerente con le norme di livello superiore. Una norma può esistere anche se è invalida, sia per vizi di forma (invalidità formale) sia per contrasto con norme superiori (invalidità sostanziale).L’ambiguità del termine “norma”
Una fonte di confusione nella teoria del diritto deriva dall’uso del termine ‘norma’ per indicare due cose molto diverse tra loro. Da un lato, si riferisce all’atto concreto che produce la norma, come una legge votata dal parlamento, che è un fatto osservabile e verificabile. Dall’altro lato, si riferisce al significato prescrittivo di quell’atto, cioè ciò che la norma “dice” che si deve o non si deve fare, che rappresenta un “dover essere”. Questa ambivalenza tra il fatto (l’atto) e il significato (il dover essere) rende difficile distinguere in modo netto tra l’esistenza dell’atto che pone la norma e la validità della norma stessa che da quell’atto deriva. Non avere chiara questa distinzione può portare a sovrapporre piani logici differenti e a complicare l’analisi del sistema giuridico. Chiarire questa ambivalenza è quindi un passaggio fondamentale per una teoria del diritto rigorosa.Validità ed efficacia
Anche il rapporto tra validità ed efficacia di una norma presenta delle difficoltà concettuali. L’efficacia si riferisce al fatto che una norma venga effettivamente osservata dai cittadini o applicata dai giudici e dalle autorità. L’idea che l’efficacia sia una condizione necessaria e sufficiente per la validità porta a confondere completamente i due concetti. Questa confusione finisce per avvicinarsi molto alle posizioni del realismo giuridico, che tende a identificare il diritto con ciò che viene di fatto applicato. Invece, la validità di una norma dipende dalla sua conformità alle norme di livello superiore all’interno del sistema giuridico, non dal suo grado di osservanza o applicazione nella realtà pratica. Distinguere validità ed efficacia è cruciale per comprendere come funziona un ordinamento giuridico che si basa su regole gerarchiche.Il fondamento del sistema giuridico
Un altro punto critico nella teoria del diritto riguarda il fondamento ultimo della validità dell’intero sistema. Alcune teorie pongono alla base una “norma fondamentale” che non è stata creata da nessun atto giuridico positivo. Questa idea, però, contrasta con il principio che il diritto positivo è sempre il risultato di atti di creazione posti in essere da soggetti autorizzati. Un fondamento più concreto e radicato nella realtà giuridica si trova invece nel potere costituente. È l’atto costituente, espressione di questo potere, a dare vita all’ordinamento giuridico e a stabilire le prime norme fondamentali da cui derivano tutte le altre. Concentrarsi sul potere costituente e sull’atto che ne scaturisce offre una base più solida e comprensibile per spiegare l’origine e la validità iniziale di un sistema legale.Persone fisiche e giuridiche
Infine, un’ulteriore confusione concettuale si riscontra nel modo in cui vengono considerate le persone fisiche e le persone giuridiche. A volte, entrambe vengono trattate in modo simile, quasi come “ordinamenti personificati”. Questo approccio, però, ignora la differenza fondamentale che esiste tra i soggetti naturali, come gli esseri umani, e le entità artificiali, come le società o le associazioni, che sono create dal diritto stesso. Le istituzioni artificiali, come le persone giuridiche, possono essere viste in modi diversi: o come soggetti di diritto, titolari di diritti e doveri, oppure come veri e propri ordinamenti giuridici minori all’interno dell’ordinamento generale. Riconoscere la specificità delle persone giuridiche e le diverse prospettive da cui possono essere analizzate è importante per una comprensione completa del sistema legale.Ma come può Kelsen, l’inventore del controllo di costituzionalità, considerarlo una mera “interferenza” e al contempo trascurare la dimensione sostanziale del costituzionalismo, quando proprio quel controllo serve a garantirla?
Questo capitolo presenta una tensione irrisolta nel descrivere la posizione di Kelsen riguardo al controllo di costituzionalità e al rapporto tra forma e sostanza nella democrazia. Affermare che Kelsen veda il controllo come semplice interferenza, pur riconoscendolo come suo meccanismo introdotto, e che non consideri sufficientemente la dimensione sostanziale garantita dalle costituzioni rigide, richiede un approfondimento. La funzione del controllo di costituzionalità, nella visione kelseniana, non è solo formale, ma mira a garantire la superiorità della norma costituzionale (anche se vista come norma superiore nell’ordinamento) sulla legge ordinaria. Per comprendere meglio questa apparente contraddizione e il ruolo del costituzionalismo, è necessario esplorare più a fondo la teoria pura del diritto di Kelsen, i suoi scritti specifici sulla giustizia costituzionale e il dibattito contemporaneo sul rapporto tra democrazia e costituzionalismo.7. Oltre la Forma: La Democrazia Costituzionale e i Suoi Limiti Necessari
Una visione della democrazia che si concentra solo sulle regole formali, come il principio che decide la maggioranza o le procedure per prendere decisioni, non coglie un aspetto essenziale delle democrazie di oggi. Le costituzioni che non possono essere modificate facilmente introducono dei limiti e degli obblighi precisi grazie ai diritti fondamentali. Questi diritti stabiliscono chiaramente cosa una maggioranza non ha il potere di decidere, come nel caso dei diritti di libertà, e cosa invece è tenuta a garantire, riferendosi ai diritti sociali. In questo modo, tutti i cittadini ottengono poteri specifici, e il potere della maggioranza non può diventare illimitato o assoluto.Perché la Sola Forma Non Basta
Ignorare questa dimensione sostanziale, legata ai diritti delle persone, crea diversi problemi. Innanzitutto, non spiega in modo adeguato come funzionano le democrazie nel mondo attuale, dove il potere di chi governa è sempre limitato dalla protezione dei diritti di tutti. In secondo luogo, va contro il riconoscimento che la democrazia stessa ha bisogno di alcune garanzie fondamentali per le libertà, come la libertà di stampa o di associazione, che sono condizioni indispensabili perché i cittadini possano esercitare i loro diritti politici in modo libero e informato. Infine, una democrazia che si basa solo sulle regole formali non ha gli strumenti per impedire che la maggioranza decida di eliminare le regole democratiche stesse, come purtroppo è successo in diversi momenti storici nel secolo scorso.Il Costituzionalismo Rafforza la Democrazia
Il costituzionalismo, con le sue costituzioni rigide e l’importanza data ai diritti fondamentali, non rappresenta un limite alla democrazia, al contrario, la rende più forte e completa. Offre una protezione essenziale contro il rischio che la democrazia venga distrutta dall’interno. Assicura che l’esercizio dei diritti politici, come il voto o la partecipazione alla vita pubblica, avvenga in modo libero e consapevole, proprio grazie alla tutela dei diritti di libertà e sociali. Inoltre, integra la democrazia intesa come semplice sistema di regole politiche con una dimensione più profonda, basata sui diritti che spettano a ogni singola persona. La democrazia si presenta così con due facce: una formale, che riguarda i diritti politici e civili, e una sostanziale, che riguarda i diritti di libertà e sociali.Le Sfide Attuali e la Necessità di Estendere le Garanzie
Oggi, in un mondo sempre più connesso ma spesso privo di regole condivise a livello globale, e con partiti politici che sembrano meno forti, i grandi poteri economici e finanziari globali hanno una capacità crescente di influenzare le decisioni politiche degli stati. Per affrontare questo squilibrio e ripristinare l’equilibrio, il modello costituzionale deve essere ampliato e adattato. Questo significa che le garanzie offerte dalle costituzioni non devono più limitarsi a proteggere i cittadini solo dai poteri pubblici dello stato, ma devono estendersi anche a limitare i poteri privati e quelli che agiscono a livello sovranazionale. È diventato necessario creare nuove separazioni e bilanciamenti, per esempio tra l’attività dei partiti politici e le istituzioni pubbliche, e tra chi detiene il potere politico e chi detiene il potere economico. L’espansione di un costituzionalismo che garantisce i diritti, unendo idealmente i principi del liberalismo e quelli del socialismo nella tutela delle persone, è fondamentale per costruire la pace e assicurare la sopravvivenza stessa dell’umanità di fronte a sfide globali enormi come la crescente disuguaglianza sociale e la crisi ecologica.È davvero sufficiente “ampliare il modello costituzionale” per limitare i poteri globali e assicurare la sopravvivenza dell’umanità, o si tratta di un’aspirazione che ignora la complessità del potere non statale?
Il capitolo propone un’estensione ambiziosa del costituzionalismo per affrontare le sfide globali e i poteri privati. Sebbene l’idea di limitare tali poteri sia cruciale, il capitolo non approfondisce come questo possa avvenire concretamente al di fuori delle strutture statali tradizionali. La transizione da un costituzionalismo statale a uno globale o transnazionale è oggetto di ampio dibattito e presenta enormi sfide pratiche e teoriche. Per comprendere meglio queste complessità, è utile esplorare i campi del diritto internazionale, della teoria delle relazioni internazionali e degli studi critici sul potere economico globale. Autori che si occupano di governance globale o di diritto transnazionale possono offrire spunti fondamentali su quanto sia realistico e su quali strumenti siano effettivamente disponibili per “estendere le garanzie” in un contesto non statale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]