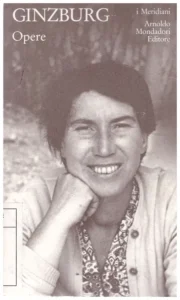Contenuti del libro
Informazioni
“La famiglia Manzoni” di Natalia Ginzburg non è solo la storia del grande scrittore Alessandro Manzoni, ma un ritratto intimo e a volte doloroso della sua famiglia, ricostruito attraverso lettere e documenti. Il libro ci porta dentro la vita quotidiana dei Manzoni, tra Milano, Parigi e la campagna di Brusuglio, mostrandoci i legami complessi e spesso tesi che univano Alessandro alla madre Giulia Beccaria, alle mogli Enrichetta Blondel e Teresa Borri, e ai suoi tanti figli. Vediamo le loro sofferenze, le malattie, i lutti che li colpiscono uno dopo l’altro, le difficoltà economiche dei figli maschi come Enrico e Filippo, e i percorsi di fede, a volte tormentati, come quello di Alessandro stesso. Ginzburg usa uno stile semplice e diretto per raccontare questi affanni privati, le tensioni tra i membri della famiglia, il rapporto difficile di Alessandro con la prole, e il suo bisogno di solitudine. È un modo per conoscere Manzoni non solo come l’autore de “I promessi sposi”, ma come un uomo con le sue fragilità, inserito in un nucleo familiare segnato da drammi e distanze, dove anche figure come il figliastro Stefano Stampa o la figlia Vittoria trovano il loro spazio.Riassunto Breve
La vita di Alessandro Manzoni e della sua famiglia si snoda attraverso un percorso segnato da legami complessi, sofferenze e difficoltà quotidiane. L’infanzia di Alessandro è distante dalla madre Giulia, che vive un matrimonio infelice con Don Pietro Manzoni e trova poi felicità a Parigi con Carlo Imbonati. Solo dopo la morte di Imbonati, Alessandro, ormai diciannovenne, raggiunge la madre a Parigi, dove si crea un legame intenso e improvviso che li porta a tornare insieme in Italia. Alessandro sposa Enrichetta Blondel, un matrimonio inizialmente protestante poi regolarizzato con rito cattolico, che coincide con la sua conversione religiosa. La vita familiare è caratterizzata da numerose gravidanze di Enrichetta, spesso malata, dalle crisi di ansia di Alessandro e dalla gestione di una casa che cresce tra Milano e Brusuglio. Nonostante il successo letterario de *I promessi sposi*, la famiglia affronta continue difficoltà economiche e lutti: muoiono Enrichetta e diverse figlie, tra cui Giulietta, il cui matrimonio con Massimo d’Azeglio è infelice e che muore giovane lasciando una figlia. Dopo la morte di Enrichetta, Alessandro sposa Teresa Borri, vedova con un figlio, Stefano Stampa. Questo secondo matrimonio introduce nuove tensioni in casa, specialmente con la madre di Alessandro, Giulia, e con i figli della prima moglie, che si sentono estranei. I figli maschi, Enrico e Filippo, causano preoccupazioni finanziarie al padre con debiti e difficoltà a trovare lavoro. Vittoria, un’altra figlia, trova serenità solo sposandosi e allontanandosi dalla casa paterna. Le malattie continuano a colpire la famiglia, portando alla morte di nipoti e della stessa Teresa. Alessandro, pur ricevendo riconoscimenti pubblici come la nomina a senatore, vive gli ultimi anni segnato da lutti, preoccupazioni finanziarie e problemi di salute, appoggiandosi al figlio Pietro per l’amministrazione dei beni, ma mantenendo un legame affettuoso con il figliastro Stefano. Dopo la sua morte, i figli sopravvissuti continuano ad affrontare le loro difficoltà, con Enrico che muore in condizioni precarie e Stefano che si dedica alla pittura e alla scrittura. L’esistenza della famiglia Manzoni, ricostruita attraverso documenti come lettere e testamenti, si presenta come una realtà umana fatta di fragilità, isolamento e drammi privati, con Alessandro Manzoni al centro, ritratto con le sue manie e il suo bisogno di solitudine, spesso distante dalle sofferenze di chi gli sta intorno.Riassunto Lungo
1. Un incontro a Parigi
La vita di Giulia Beccaria, figlia del famoso Cesare Beccaria, comincia con difficoltà fin dall’infanzia. Da bambina, è spesso malata e soffre per i lunghi viaggi della madre e per la mancanza di attenzione del padre. Il padre la manda in convento, un luogo che non le è congeniale e dove si sente isolata. Viene poi data in sposa a Don Pietro Manzoni, un matrimonio che si rivela infelice fin da subito. Nonostante le difficoltà, Giulia cerca una sua strada, conducendo una vita sociale vivace e avendo diverse relazioni, tra cui una importante con Giovanni Verri.L’infanzia e l’adolescenza di Alessandro
Dalla sua unione con Don Pietro nasce un figlio, Alessandro, che viene però subito allontanato dalla madre. Alessandro Manzoni cresce lontano da Giulia, affidato prima a una balia e poi mandato in vari collegi. Questi anni sono difficili per lui, in quanto detesta l’ambiente rigido e disciplinato dei collegi. Anche il rapporto con il padre, Don Pietro, è distante e privo di calore umano. Alessandro trascorre la sua adolescenza a Milano, sentendosi spesso a disagio nella casa paterna e desiderando una diversa atmosfera familiare. Nonostante queste difficoltà personali, inizia a dedicarsi con passione alla scrittura e a frequentare ambienti culturali che stimolano la sua intelligenza e la sua sensibilità.Una nuova vita a Parigi
Giulia Beccaria prende una decisione coraggiosa che cambia radicalmente la sua esistenza: si separa dal marito e sceglie di vivere liberamente le proprie relazioni. Inizia una relazione significativa e duratura con Carlo Imbonati e decide di trasferirsi a Parigi insieme a lui. Nella capitale francese, Giulia scopre una felicità e un riconoscimento sociale che non aveva mai provato prima in Italia. Conduce una vita brillante e stimolante, frequentando alcuni degli intellettuali più importanti dell’epoca, come Claude Fauriel e Sophie de Condorcet, che apprezzano la sua intelligenza e il suo spirito. In questi anni di rinnovata libertà e successo personale, il pensiero del figlio lontano in Italia non è una presenza costante nella sua vita quotidiana.L’incontro che cambiò tutto
Il destino porta Alessandro verso la madre a Parigi in un momento cruciale. Poco prima della sua morte, Carlo Imbonati invita il giovane Alessandro a raggiungerlo nella capitale francese. Alessandro accetta l’invito e intraprende il viaggio, ma arriva a Parigi solo dopo la scomparsa di Imbonati. Ha diciannove anni quando finalmente incontra la madre Giulia, che non vedeva da moltissimo tempo. Questo incontro è un momento di profonda emozione e di forte impatto emotivo per entrambi. Madre e figlio, che per anni sono stati quasi degli estranei a causa della distanza e delle diverse vite condotte, scoprono improvvisamente un legame intenso e inaspettato che li unisce profondamente.Un legame ritrovato e il ritorno in Italia
Dopo l’incontro parigino, Alessandro si lega in modo molto forte a Giulia e al suo ambiente intellettuale. Esprime apertamente il suo affetto e la sua ammirazione sia per la madre sia per la figura di Carlo Imbonati, che sente vicino nonostante non l’abbia conosciuto bene di persona. Giulia, superato il dolore per la perdita del compagno, concentra le sue attenzioni sul figlio ritrovato e sulla costruzione del loro nuovo rapporto. Si rende conto che Alessandro, ormai adulto, ha bisogno di costruire una sua vita indipendente e inizia a pensare al suo futuro, progettando il suo matrimonio. Madre e figlio decidono quindi di lasciare Parigi e tornare insieme in Italia per iniziare questo nuovo capitolo delle loro vite. Durante il viaggio di ritorno, ricevono la notizia della morte di Don Pietro Manzoni. Questa scomparsa ha un impatto pratico sulla vita di Alessandro, poiché il padre gli lascia in eredità tutti i suoi beni, modificando la sua posizione economica.Come si può affermare con tanta sicurezza che il pensiero del figlio lontano “non è una presenza costante” nella vita di Giulia Beccaria a Parigi?
Il capitolo, nel descrivere la vita di Giulia Beccaria a Parigi, afferma che il pensiero del figlio Alessandro “non è una presenza costante nella sua vita quotidiana”. Questa affermazione, pur plausibile, manca di un contesto che ne giustifichi la sicurezza, specialmente considerando la complessità delle relazioni familiari e sociali dell’epoca. Per comprendere meglio le dinamiche emotive e le scelte di vita di Giulia, sarebbe utile approfondire la storia sociale e del costume del Settecento e Ottocento, in particolare per quanto riguarda i ruoli femminili, le pratiche educative dell’aristocrazia e della borghesia, e le convenzioni legate alla maternità e alla separazione coniugale. Approfondire la biografia di Giulia Beccaria e di Alessandro Manzoni, magari leggendo studi critici che analizzino le loro lettere e i documenti dell’epoca, può fornire una prospettiva più sfumata sulle loro relazioni e sui loro stati d’animo. Autori come Natalia Ginzburg o Giovanni Getto hanno affrontato la figura di Manzoni e il suo contesto familiare, offrendo spunti per una comprensione più profonda.2. Vita Familiare e Percorsi di Fede
Enrichetta Blondel, proveniente da una famiglia di fede calvinista, sposa Alessandro Manzoni con rito protestante nel 1808 a Milano. Questo matrimonio suscita diverse critiche nell’ambiente milanese dell’epoca. Subito dopo le nozze, la famiglia si trasferisce a Parigi, un cambiamento che vede Enrichetta sentirsi disorientata e spaesata, mentre Giulia, la madre di Alessandro, ritrova invece la sua vivacità. Durante questo periodo parigino, nasce la loro prima figlia, Giulietta, e Enrichetta ha un incontro significativo con l’abate Degola, un prete giansenista che diventa un punto di riferimento fondamentale per la sua crescita spirituale.La Svolta della Conversione
Nel 1810, la famiglia prende la decisione importante di regolarizzare il matrimonio con rito cattolico. Nello stesso anno, in un momento di tumulto a Parigi, Alessandro vive una profonda crisi personale. Cerca rifugio nella chiesa di San Rocco, dove sperimenta un evento intenso che lui stesso considererà una conversione. Questo episodio segna l’inizio delle sue ricorrenti crisi nervose e di un cammino di fede spesso tormentato da dubbi e sensi di colpa. Parallelamente, sia Enrichetta che Giulia intraprendono il loro percorso di conversione al cattolicesimo, sebbene con esperienze interiori e motivazioni diverse. La scelta di Enrichetta di abiurare pubblicamente la sua fede d’origine nel 1810 ha come conseguenza una difficile rottura nei rapporti con la sua famiglia d’origine, segnando un passaggio definitivo nella sua vita e nella sua fede.La Vita in Italia tra Fede e Difficoltà
Dopo il periodo trascorso a Parigi, la famiglia Manzoni rientra in Italia e si stabilisce alternando soggiorni tra Milano e la villa di Brusuglio. La vita quotidiana in questo periodo è segnata da diverse sfide. Enrichetta affronta frequenti gravidanze e problemi di salute che la debilitano, mentre Alessandro è tormentato dalle sue crisi d’ansia. La famiglia cresce e la sua gestione richiede impegno costante. L’abate Degola continua a fornire guida spirituale, affiancato in seguito dal canonico Tosi, proponendo un approccio alla vita religiosa piuttosto severo e rigoroso. Nonostante le difficoltà pratiche e di salute, Alessandro si dedica intensamente alla scrittura, lavorando sia alle sue tragedie che al romanzo che diventerà la sua opera più celebre, il tutto mentre la famiglia deve affrontare anche problemi economici e un clima politico generale piuttosto teso.Legami e Sfide Continue
Alessandro nutre il desiderio di tornare a Parigi, un luogo che considera stimolante per il suo lavoro e i suoi interessi. Tuttavia, questo desiderio viene visto con preoccupazione sia da Enrichetta che dal canonico Tosi, i quali temono che un ritorno nella capitale francese possa rappresentare un rischio per la sua fede appena consolidata. Inoltre, le autorità austriache ostacolano attivamente i suoi progetti di viaggio. La famiglia continua così a vivere in Italia, affrontando una serie continua di problemi di salute, lutti dolorosi dovuti alla perdita di alcuni bambini, e persistenti preoccupazioni finanziarie. L’amicizia con Fauriel, mantenuta viva attraverso un fitto scambio epistolare, rappresenta un legame cruciale con la Francia e il più ampio mondo culturale europeo. Fauriel stesso visita i Manzoni a Milano, rafforzando ulteriormente il legame con tutta la famiglia, inclusi i bambini, che lo accolgono con affetto. Nonostante i progetti di spostamento e il desiderio di cambiamento che a volte emerge, la famiglia rimane radicata nella sua realtà italiana, affrontando giorno per giorno le sfide della vita, della fede e delle relazioni umane che la definiscono.Davvero una “conversione” può essere l’inizio di “ricorrenti crisi nervose”, e un “cammino di fede tormentato” è l’inevitabile esito di una guida “severa e rigorosa”?
Il capitolo, pur descrivendo la conversione di Alessandro come un “evento intenso” seguito dall’inizio delle sue “ricorrenti crisi nervose”, non esplora a fondo la natura di questo legame, né chiarisce come una guida spirituale definita “severa e rigorosa” possa aver interagito con un “cammino di fede spesso tormentato da dubbi e sensi di colpa”. Questa presentazione lascia aperte questioni cruciali sulla psicologia della fede e sull’impatto della direzione spirituale. Per approfondire questi temi, è consigliabile esplorare la psicologia della religione e la storia delle correnti spirituali e teologiche del periodo, come il giansenismo. Letture di autori che hanno studiato le esperienze mistiche o le dinamiche psicologiche legate alla fede, o che hanno analizzato il contesto religioso dell’epoca, potrebbero fornire strumenti critici per valutare queste connessioni.3. Legami e addii
La vita della famiglia Manzoni si divide tra Milano, Brusuglio e altri luoghi di soggiorno. Alessandro Manzoni dedica molto tempo al suo lavoro, in particolare alla stesura del romanzo I promessi sposi. La pubblicazione del libro ottiene un grande successo, portando all’autore riconoscimenti e nuove relazioni. Nonostante i successi letterari, la salute dei membri della famiglia è spesso motivo di preoccupazione. Enrichetta, la moglie di Alessandro, soffre di vari disturbi, tra cui seri problemi agli occhi, che richiedono cure e viaggi, come quelli intrapresi a Livorno e Firenze. Anche i figli affrontano periodicamente malattie che li debilitano.
La vita e il matrimonio di Giulietta
Giulietta, la figlia maggiore della famiglia, mantiene una corrispondenza intensa, specialmente con il suo padrino Fauriel e il cugino Giacomo Beccaria. Nelle sue lettere, Giulietta esprime affetto per i suoi interlocutori e talvolta un senso di malincolia. La sua esistenza prende una piega importante quando riceve una proposta di matrimonio da Massimo d’Azeglio. Inizialmente, Giulietta è incerta e mostra esitazione nell’accettare. Tuttavia, le pressioni familiari la portano ad acconsentire. Il matrimonio viene celebrato, ma la vita coniugale non si rivela felice come sperato. Presto emergono tensioni e gelosie, aggravate anche dalla figura di Louise Maumary, che era la vedova dello zio Enrico Blondel. Anche il rapporto di Giulietta con la suocera, madre di Massimo, si dimostra difficile.
Le prime dolorose perdite
La famiglia Manzoni è colpita da una serie di gravi lutti. Enrico Blondel, fratello della moglie di Alessandro, muore dopo una lunga malattia. Poco dopo, le condizioni di Enrichetta peggiorano progressivamente. La moglie di Alessandro Manzoni si spegne la notte di Natale del 1832. La sua morte è un evento devastante che segna profondamente Alessandro e l’intera famiglia. Il dolore non si placa: nel settembre del 1834, appena due anni dopo la madre, anche Giulietta si ammala gravemente e muore. Lascia la sua bambina piccola, Rina. La nonna Giulia, madre di Alessandro, si assume il compito di prendersi cura della nipote rimasta orfana.
Conseguenze e nuove dinamiche familiari
Dopo la morte di Giulietta, Massimo d’Azeglio decide di risposarsi. La sua scelta ricade su Louise Maumary, la stessa donna che era stata fonte di gelosia durante il suo matrimonio con Giulietta. Questa decisione non è ben accolta dalla famiglia Manzoni e sfocia in una disputa legale per l’affidamento della piccola Rina. La custodia della bambina viene infine assegnata a d’Azeglio. Questo evento crea una frattura significativa nei rapporti tra Alessandro Manzoni e il genero, anche se con il passare degli anni la loro relazione migliorerà gradualmente. Parallelamente, anche l’amicizia storica tra Alessandro Manzoni e Fauriel si affievolisce nel tempo, portando a un lungo periodo di silenzio tra i due.
Altri lutti e la scomparsa della nonna
La serie di lutti che affligge la famiglia continua con la scomparsa di altre due figlie, Cristina e poi Sofia. La nonna Giulia, già segnata dalle perdite della figlia Enrichetta e della nipote Giulietta, risente profondamente dei cambiamenti avvenuti in casa, in particolare dopo il secondo matrimonio del figlio Alessandro con Teresa Borri. Giulia muore nel 1841. La famiglia attraversa così un periodo prolungato di dolore e profonde trasformazioni, causate in gran parte dalla perdita delle figure femminili che avevano rappresentato un punto di riferimento centrale nella loro vita.
Il capitolo descrive le gravi difficoltà economiche dei figli di Manzoni e la frustrazione del padre per le loro continue richieste; ma quali erano le cause profonde di questa miseria persistente, al di là delle semplici “promesse non mantenute”?
Il capitolo documenta efficacemente la situazione di indigenza di Enrico e Filippo e la reazione di Manzoni, ma non approfondisce sufficientemente le ragioni strutturali o personali che impedivano loro di trovare stabilità economica. Comprendere meglio questo aspetto richiederebbe un’analisi più dettagliata del contesto socio-economico dell’epoca per individui della loro estrazione sociale e un’esplorazione più approfondita delle dinamiche familiari e delle personalità individuali. Per colmare questa lacuna, sarebbe utile consultare studi sulla storia sociale del XIX secolo italiano e biografie che analizzino in profondità la vita privata di Manzoni e dei suoi figli.7. Manzoni: Ritratti di Famiglia e Quotidiano
Il libro di Natalia Ginzburg si concentra sulla vita di Alessandro Manzoni e delle persone a lui vicine. Esplora la loro esistenza quotidiana e i loro rapporti familiari. Per farlo, l’autrice usa documenti come lettere, testamenti e biografie, ricostruendo la storia della famiglia in ordine di tempo. Questo modo di raccontare è diverso da un’analisi storica o letteraria classica. Si sofferma sui dettagli piccoli ma importanti della vita dei personaggi, come i loro tratti fisici o la descrizione delle case in cui vivevano. La scrittura è precisa e sembra neutra, lasciando che i fatti parlino da soli. A volte, mette vicini elementi molto diversi tra loro senza aggiungere commenti. Evita sempre toni esagerati o tristi, e a volte inserisce note divertenti, specialmente quando descrive la seconda moglie di Manzoni, Teresa Borri.La vita familiare e i suoi dolori
Anche se il libro guarda a tutta la famiglia, Alessandro Manzoni resta la figura più importante. Vengono raccontate le tensioni e i problemi dentro la famiglia, che esistevano già prima degli eventi più tristi. Si descrivono le tante gravidanze e la salute non buona della prima moglie, Enrichetta Blondel. Si parla delle figlie morte giovani a causa della tubercolosi. Vengono messi in luce anche i problemi economici e personali dei figli maschi, Enrico e Filippo, e i rapporti difficili e spesso lontani di Manzoni con i suoi figli.
Il ritratto di Alessandro Manzoni
Manzoni viene mostrato in modo chiaro, con i suoi lati egoisti e il suo bisogno di stare da solo, specialmente quando era anziano. La sua figura domina la scena familiare, con le sue abitudini fisse e le sue preoccupazioni, come l’ossessione per la lingua fiorentina nelle lettere che scriveva ai parenti. Viene dipinto il quadro di una famiglia segnata dalla sofferenza e dalla solitudine. Manzoni stesso appare spesso chiuso nei suoi pensieri, lontano da quello che succedeva intorno a lui.
Ma un ritratto così intimo e ‘neutro’ non rischia forse di ridurre il grande Manzoni a un semplice padre di famiglia tormentato, perdendo di vista il suo peso intellettuale e storico?
Il capitolo, concentrandosi sul quotidiano e sui rapporti familiari, offre uno spaccato intimo ma rischia di lasciare in ombra la statura di Manzoni come figura centrale della letteratura e della cultura italiana. Una visione che si fermi ai ‘dettagli piccoli ma importanti della vita dei personaggi’ e alle ‘tensioni e problemi dentro la famiglia’ rischia di non rendere giustizia al suo impatto intellettuale e al contesto storico in cui operò. Per un quadro completo, è indispensabile integrare questa prospettiva con l’analisi della sua opera letteraria, del suo pensiero politico e religioso, e del suo ruolo nel Risorgimento. Approfondire la critica letteraria manzoniana e gli studi sulla storia culturale e politica dell’Ottocento italiano, leggendo autori che hanno esplorato questi aspetti, è cruciale per superare i limiti di un ritratto puramente domestico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]