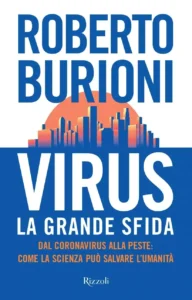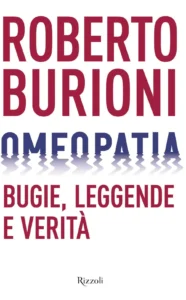1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica” di Roberto Burioni è un libro che ti prende per mano e ti mostra senza giri di parole perché, su certe cose, non puoi semplicemente “pensarla come vuoi”. Partendo dal concetto che la scienza offre una verità provvisoria basata sui dati, l’autore spiega come la nostra stessa mente, con le sue scorciatoie, ci renda vulnerabili a credere a bugie e false correlazioni, come quella tra vaccini e autismo, ignorando l’importanza dell’immunità di gregge o i pericoli reali di malattie come il morbillo. Attraverso esempi concreti, che spaziano da tragedie storiche legate alla negazione scientifica (come l’HIV in Sudafrica) a fenomeni attuali amplificati dai media, il libro sottolinea l’importanza di fidarsi della comunità scientifica, del metodo scientifico e dei dati, piuttosto che dell’intuizione o di singoli individui non verificati. È un invito urgente a capire che la disinformazione ha costi umani altissimi e che, nell’era di internet, studiare e acquisire una vera cultura è l’unico modo democratico per distinguere il vero dal falso e fare scelte consapevoli per sé e per la collettività.Riassunto Breve
La scienza offre una verità provvisoria, non dogmatica, che si basa sui dati e può cambiare nel tempo. Fidarsi della comunità scientifica è fondamentale, anche se gli scienziati sono esseri umani con i loro limiti, perché l’alternativa di rifiutare la scienza porta a conseguenze molto gravi, come dimostrano esempi storici di morti e malattie diffuse a causa della negazione di evidenze scientifiche su cure o vaccini. Molte persone diffondono informazioni false, spesso tramite internet, parlando di argomenti che in realtà non conoscono a fondo. Questo comportamento è amplificato in gruppo e deriva dal modo in cui funziona la mente umana. Evoluta per la sopravvivenza in ambienti diversi da quello attuale, la mente usa scorciatoie cognitive che possono portare a errori nel mondo moderno, ricco di informazioni complesse. Tende a stabilire rapporti di causa-effetto tra eventi solo perché avvengono vicini nel tempo, scambiando una semplice correlazione per una causalità. Esempi classici di questo errore sono la superstizione sulla morte causata dal ventilatore acceso o la falsa convinzione che i vaccini provochino l’autismo, legami che i dati scientifici smentiscono chiaramente. L’intuizione da sola non basta per capire le vere cause; è necessario affidarsi alla scienza, al suo metodo rigoroso, ai dati e alla statistica per evitare errori pericolosi e distinguere la verità dalle bugie. La scienza, pur con le sue imperfezioni, è lo strumento più valido per comprendere la realtà. L’analisi dei dati richiede criteri precisi e non è intuitiva; la mente umana tende a vedere schemi e trarre conclusioni da pochi casi, scambiando variazioni casuali per anomalie significative, come nei presunti cluster di malattie o nel concetto di “mano calda” nello sport, che l’analisi statistica non conferma. L’osservazione iniziale può essere un punto di partenza per la ricerca, ma serve il lavoro metodico della scienza per confermare le ipotesi. Le persone tendono a isolarsi in gruppi che condividono le stesse idee, specialmente online, rifiutando il confronto basato sui dati, il che impedisce il progresso. La scienza non offre verità assolute, ma propone ciò che, con le conoscenze disponibili, è più vicino alla verità. La conoscenza scientifica si costruisce partendo dall’osservazione, ma richiede metodo, esperimenti e la condivisione dei risultati tramite pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione critica da altri esperti. Questo processo di verifica è cruciale per l’affidabilità. Per distinguere informazioni scientifiche affidabili da quelle false, si valuta la reputazione della fonte: scienziati e medici seri sono affiliati a istituzioni riconosciute, pubblicano su riviste scientifiche affidabili e i loro lavori sono citati da altri ricercatori. Un individuo isolato, che pubblica solo online o su riviste di bassa qualità, è spesso inaffidabile. La medicina moderna si basa su dati solidi e studi rigorosi; l’omeopatia, ad esempio, si basa su diluizioni estreme dove non rimane alcuna molecola della sostanza originale e gli studi dimostrano un’efficacia pari al placebo. Anche scienziati insigniti di premi importanti possono sostenere idee infondate fuori dal loro campo di specializzazione o in età avanzata; non si deve fare affidamento sulla singola persona, ma sul consenso della comunità scientifica nel suo complesso. Le accuse di conflitto di interessi sono spesso usate per screditare chi difende le pratiche mediche consolidate, ma non sempre sono fondate e non confutano gli argomenti basati sulla scienza. L’aumento dei casi di morbillo in Italia è legato alla bassa copertura vaccinale. Il morbillo è una malattia grave che causa lesioni permanenti e decessi, soprattutto nei bambini sotto l’anno di età che non possono ancora essere vaccinati e vengono contagiati dai bambini più grandi non vaccinati. La protezione per i bambini non vaccinabili e gli individui vulnerabili è garantita dall’immunità di gregge, un fenomeno dimostrato dove un’alta percentuale di vaccinati impedisce la circolazione del virus. La vaccinazione non è solo una scelta personale, ma un atto di responsabilità sociale; chi non vaccina i propri figli mette a rischio loro stessi, gli altri e la comunità. I bambini sono cittadini che lo Stato deve proteggere, non proprietà dei genitori, e la libertà non include il diritto di danneggiare gli altri basandosi su credenze infondate. Di fronte a tassi di vaccinazione pericolosamente bassi, l’obbligo vaccinale, come quello per l’accesso scolastico, si rende necessario per aumentare rapidamente le coperture e ristabilire l’immunità di gregge. I medici che diffondono informazioni false sull’inefficacia o pericolosità dei vaccini danneggiano i pazienti e la professione e devono essere sanzionati dagli Ordini professionali, come nel caso di Andrew Wakefield che falsificò dati sul legame tra vaccino e autismo. I giornalisti hanno un ruolo importante ma possono anche amplificare le bugie dando spazio a persone senza alcuna competenza scientifica su temi delicati come la salute e i vaccini, trattando la scienza diversamente da altri campi come lo sport, dove si richiede competenza e non si mettono in discussione risultati o regole base. Bilanciare libertà di opinione e necessità di limitare la diffusione di bugie pericolose è complesso; proibire diventa necessario quando i comportamenti creano un pericolo per la società. Saper distinguere le informazioni corrette da quelle senza fondamento è fondamentale ma difficile. Su internet si trova di tutto e la selezione spetta all’individuo. Per questo, è necessario studiare. Le informazioni rapide ottenute da computer o smartphone non bastano senza la cultura, intesa come ciò che rimane dopo aver dimenticato i dettagli appresi. Studiare è un impegno ma è anche uno strumento democratico; non esistono scorciatoie basate su denaro o posizione sociale. Chi studia acquisisce conoscenza, chi non studia no. La conoscenza è la cosa più democratica che esista ed è la base necessaria per un cittadino che deve fare scelte consapevoli, essenziale per una democrazia completa. Anche se la tecnologia facilita l’accesso a dati e rende la vita più comoda, non può insegnare a distinguere la verità dalla bugia.Riassunto Lungo
1. La Mente, le Bugie e la Necessità della Scienza
La scienza ci offre una verità che non è assoluta, ma si basa sui fatti e può cambiare man mano che scopriamo cose nuove. Anche se gli scienziati sono persone con i loro limiti e possono sbagliare, è essenziale fidarsi di quello che la comunità scientifica scopre nel suo complesso. Non farlo può avere conseguenze molto gravi e persino tragiche. La storia ci mostra quanto sia costoso rifiutare la scienza e le sue indicazioni. C’è stato il caso di un bambino morto perché curato solo con rimedi naturali, non con la medicina necessaria. In Germania Ovest, molti si ammalarono gravemente di poliomielite per aver tardato ad usare il vaccino, a differenza della Germania Est che lo adottò subito. E in Sudafrica, la negazione da parte del governo che l’HIV causasse l’AIDS ha portato alla perdita di oltre 300.000 vite umane.Perché le informazioni sbagliate si diffondono e attecchiscono
Oggi, soprattutto su internet, molte persone diffondono notizie false su cose che in realtà non conoscono bene o di cui non hanno studiato le basi. È un comportamento comune, quello di parlare di argomenti complessi senza avere le competenze necessarie. Questo fenomeno si diffonde facilmente e diventa ancora più forte quando le persone si ritrovano in gruppi che condividono le stesse idee sbagliate, creando una sorta di cassa di risonanza per le falsità. Ma perché siamo così portati a credere a queste informazioni sbagliate, anche quando sono palesemente false? Dipende da come funziona la nostra mente. Si è evoluta migliaia di anni fa per aiutarci a sopravvivere in un mondo molto diverso da quello di oggi, un mondo più semplice e immediato. Per farlo, usa delle ‘scorciatoie’ veloci per capire le cose e prendere decisioni rapide. Nel mondo moderno, pieno di informazioni difficili da valutare e spesso contraddittorie, queste scorciatoie possono portarci a sbagliare grossolanamente. È un po’ come i nostri denti, che si rovinano di più con la dieta moderna ricca di zuccheri rispetto a quella dei nostri antenati, o il nostro sistema immunitario, che a volte reagisce troppo in ambienti troppo puliti sviluppando allergie. La nostra mente, allo stesso modo, tende a pensare che due cose siano collegate da un rapporto di causa-effetto solo perché succedono nello stesso momento o una dopo l’altra, senza considerare altre possibili spiegazioni.Quando confondiamo causa ed effetto: Esempi
Un errore tipico e molto diffuso, figlio di queste scorciatoie mentali, è confondere una semplice coincidenza o una correlazione (due cose che accadono insieme) con un rapporto di causa-effetto reale (una cosa che provoca l’altra). La nostra mente cerca schemi e collegamenti, e a volte li trova anche dove non esistono, semplicemente perché gli eventi sono vicini nel tempo o nello spazio. Ad esempio, in Corea esiste la superstizione, fortunatamente in declino, che dormire con un ventilatore acceso in una stanza chiusa possa causare la morte. Questo nasce dal fatto che alcune persone sono morte nel sonno per altre ragioni (problemi cardiaci, ictus, ecc.), mentre il ventilatore era acceso per il caldo. Non c’è un legame di causa diretto dimostrato scientificamente, solo una correlazione temporale. Allo stesso modo, la falsa idea che i vaccini provochino l’autismo è nata perché i vaccini vengono somministrati e i primi sintomi dell’autismo compaiono all’incirca nella stessa fascia d’età della prima infanzia. Questo porta molte persone a collegare erroneamente i due eventi, anche se innumerevoli studi scientifici in tutto il mondo hanno dimostrato chiaramente che non c’è nessuna relazione causale tra vaccinazione e autismo.La scienza come guida
Capire la differenza tra causa ed effetto, e più in generale distinguere la verità dalle bugie, non è qualcosa che possiamo fare solo affidandoci al nostro intuito o alle nostre sensazioni. La nostra percezione può ingannarci facilmente, soprattutto in un mondo complesso e pieno di disinformazione. Per questo, è indispensabile affidarsi alla scienza. Il suo metodo rigoroso, basato sull’osservazione, la sperimentazione, l’analisi dei dati e l’uso della statistica, sono gli strumenti che ci permettono di andare oltre le apparenze e le nostre tendenze a sbagliare. Solo seguendo questi strumenti possiamo davvero evitare conclusioni affrettate e pericolose, e distinguere ciò che è vero da ciò che è falso in modo affidabile. La scienza, anche se non è perfetta e le sue scoperte possono sempre essere riviste alla luce di nuove prove, rimane il modo più affidabile e prezioso che abbiamo per capire il mondo che ci circonda e prendere decisioni informate.Se la scienza è la guida, come si fa a capire chi sono i ‘veri’ scienziati da seguire in un mondo pieno di voci contrastanti?
Il capitolo insiste sulla necessità di fidarsi della ‘comunità scientifica nel suo complesso’, ma non chiarisce come il lettore possa identificare questa entità affidabile in un panorama informativo complesso e spesso contraddittorio, dove diverse voci, anche con credenziali scientifiche, possono presentare posizioni divergenti o contestare il consenso prevalente. Questa lacuna rende difficile applicare concretamente il suggerimento. Per navigare questa complessità, è utile approfondire la filosofia della scienza e la sociologia della scienza. Autori come Karl Popper, Thomas Kuhn, Bruno Latour e Naomi Oreskes offrono prospettive preziose su come funziona la scienza, come si forma il consenso e quali sono i meccanismi sociali ed epistemologici che lo sostengono o lo minano.2. L’intuito inganna, la scienza verifica
Analizzare i dati richiede un approccio rigoroso e non si basa sull’intuito. La mente umana tende a trarre conclusioni affrettate basandosi su pochi elementi, scambiando variazioni del tutto casuali per segnali importanti o anomalie. Questo accade, ad esempio, quando si crede ci siano “cluster” di malattie in certe aree come McFarland o Los Alamos, o quando si parla di “mano calda” nello sport: si vedono schemi dove in realtà c’è solo casualità, come dimostrato dalle analisi statistiche.Perché l’intuizione ci trae in inganno
La nostra tendenza a vedere pattern anche dove non ci sono è una delle ragioni principali per cui l’intuizione può ingannarci. Siamo portati a notare e dare peso a coincidenze o a piccole aggregazioni di eventi, interpretandole come prove di qualcosa di significativo. Questa inclinazione naturale, se non verificata con metodi più oggettivi, porta facilmente a credenze errate e a conclusioni lontane dalla realtà dei fatti, basate più sulla percezione personale che sull’evidenza concreta.L’osservazione non basta: serve il metodo scientifico
Tuttavia, un’osservazione iniziale, anche se basata sull’intuito, può essere il punto di partenza per scoperte importanti. Casi come il mesotelioma a Karin o la scoperta del virus HIV sono nati da osservazioni che hanno poi richiesto un’indagine approfondita. Per distinguere ciò che è una vera anomalia da ciò che è solo un evento casuale, è indispensabile il metodo scientifico. Questo metodo si avvale di numeri, procedure precise e strumenti statistici per verificare le ipotesi e garantire che le conclusioni siano solide e basate su dati affidabili.Come funziona la scienza
Il processo scientifico si sviluppa partendo dall’osservazione di un fenomeno. Da qui si formulano ipotesi, si progettano esperimenti e si raccolgono dati seguendo un metodo rigoroso. I risultati ottenuti vengono poi analizzati e interpretati. Questo lavoro metodico è fondamentale per trasformare una semplice osservazione in conoscenza verificata.La condivisione e la verifica dei risultati
Una tappa cruciale del percorso scientifico è la condivisione dei risultati. Gli scienziati pubblicano il loro lavoro su riviste specializzate, sottoponendolo al giudizio critico di altri esperti del settore (la cosiddetta “revisione paritaria”). Questo meccanismo di verifica e confronto è essenziale per l’affidabilità della conoscenza prodotta. La ricerca di anticorpi contro il virus dell’epatite C è un esempio calzante: un’idea iniziale ha portato allo sviluppo di metodi e esperimenti, alla pubblicazione dei risultati e alla loro verifica da parte della comunità scientifica. Anche se l’obiettivo iniziale (un vaccino) non fu raggiunto, la ricerca ha comunque arricchito la conoscenza e permesso lo sviluppo di cure efficaci.La natura della conoscenza scientifica
La scienza non pretende di fornire verità assolute e immutabili. Piuttosto, propone ciò che, in base alle conoscenze e agli strumenti attuali, rappresenta la spiegazione più plausibile e meno sbagliata di un fenomeno. La conoscenza scientifica è per sua natura provvisoria e in continua evoluzione, pronta a essere modificata o superata da nuove scoperte e verifiche più accurate.L’importanza del confronto e i rischi dell’isolamento
Le persone tendono naturalmente a circondarsi di chi la pensa come loro, una tendenza che internet e i social media amplificano enormemente. Questo isolamento in “bolle” di pensiero e il rifiuto del confronto basato su dati e evidenze oggettive rappresentano un ostacolo significativo al progresso della conoscenza e alla comprensione condivisa della realtà.Affidabilità e progresso scientifico
Non tutti i lavori pubblicati hanno lo stesso grado di affidabilità; la reputazione della rivista scientifica su cui un articolo appare è un indicatore importante della serietà del processo di valutazione a cui è stato sottoposto. Nonostante sia un processo complesso, a volte lento e non esente da errori, la scienza rimane il metodo più efficace e affidabile che abbiamo per acquisire conoscenza sul mondo e promuovere il progresso.Se l’intuizione “inganna” come sostiene il capitolo, come mai è spesso il punto di partenza per le scoperte scientifiche?
Il capitolo contrappone nettamente l’intuizione, vista come fonte di errore, al rigore scientifico. Tuttavia, riconosce che osservazioni iniziali, spesso guidate da una forma di intuizione o “fiuto”, possono innescare indagini scientifiche cruciali. Questa apparente contraddizione solleva un dubbio: l’intuizione è solo un bias cognitivo o può essere anche uno strumento, seppur grezzo, per formulare ipotesi? Per esplorare questa tensione, sarebbe utile approfondire la filosofia della scienza, concentrandosi sul processo di generazione delle ipotesi, e la psicologia della creatività, che studia come emergono le idee innovative.3. Fidarsi della Comunità Scientifica
Per capire se un’informazione scientifica è affidabile, è utile guardare chi la diffonde e come è stata ottenuta. Gli scienziati e i medici di cui fidarsi lavorano di solito per istituzioni importanti come università, ospedali o centri di ricerca riconosciuti. Pubblicano i risultati delle loro ricerche su riviste scientifiche serie, dove altri esperti del settore controllano il loro lavoro prima che venga pubblicato. Inoltre, i loro studi vengono poi citati e usati come base da altri ricercatori. Al contrario, chi lavora da solo, pubblica solo su internet o su riviste poco conosciute, non viene citato da altri e si presenta come un genio incompreso, è spesso una fonte poco affidabile.La scienza si basa sui dati, non sulle opinioni
La medicina moderna si basa su prove concrete e studi fatti in modo rigoroso. Non si affida all’esperienza di una singola persona o a scuole di pensiero specifiche che non hanno verifiche scientifiche. Prendiamo l’omeopatia, ad esempio: si basa su diluizioni così spinte che, secondo le leggi della chimica, nella soluzione finale non rimane più nemmeno una molecola della sostanza di partenza. Gli studi scientifici seri condotti sull’omeopatia dimostrano che i suoi effetti non sono diversi da quelli di una pillola di zucchero (un placebo).L’importanza del consenso scientifico
Anche scienziati molto famosi, che magari hanno vinto premi importanti come il Nobel, possono sostenere idee sbagliate quando parlano di argomenti al di fuori della loro area di specializzazione o quando sono molto anziani. Ci sono stati casi di scienziati noti che hanno diffuso teorie infondate sulla razza, negato malattie virali, ipotizzato che la vita venisse dallo spazio o creduto nella telepatia. Questo dimostra che non bisogna fidarsi ciecamente della singola persona, per quanto brillante, ma piuttosto guardare cosa pensa la maggior parte della comunità scientifica nel suo complesso. Il consenso tra gli esperti, basato su tante ricerche e verifiche, è il segnale più forte di affidabilità.Accuse di conflitto di interessi
Spesso, per mettere in dubbio chi difende le pratiche mediche riconosciute e basate sull’evidenza (come i vaccini), si usano accuse di conflitto di interessi, dicendo ad esempio che sono pagati dalle aziende farmaceutiche. Tuttavia, questa accusa può essere usata in modo strumentale. Pensiamo a un ricercatore che sviluppa farmaci alternativi ai vaccini, come gli anticorpi monoclonali: questa persona avrebbe un interesse economico a sostenere che i vaccini non funzionano, una posizione opposta a quella di chi li difende. Le accuse di conflitto di interessi, a volte, nascono semplicemente perché non si riesce a rispondere con argomenti scientifici validi alle prove presentate.Ma chi stabilisce, e con quali criteri inoppugnabili, quali “idee senza fondamento” vanno zittite per “proteggere la società”?
Il capitolo giustamente sottolinea il pericolo delle falsità diffuse dai media, specialmente in campo scientifico. Tuttavia, la proposta che siano i direttori dei media a decidere quali “idee senza fondamento” non meritano spazio solleva interrogativi complessi. Chi stabilisce con certezza cosa è “senza fondamento”, soprattutto quando la scienza è in evoluzione o esistono dibattiti legittimi? Come si evita che questa selezione si trasformi in censura o nella soppressione di prospettive minoritarie che, in rari casi, potrebbero rivelarsi valide? Per approfondire queste tematiche, è utile esplorare la filosofia della scienza, l’etica della comunicazione e il diritto relativo alla libertà di espressione. Pensatori come Karl Popper o John Stuart Mill hanno offerto spunti fondamentali sul valore del dibattito aperto e sui limiti della conoscenza.6. Studiare per distinguere il vero dal falso
Saper distinguere le informazioni corrette da quelle inventate è fondamentale e non riuscirci può portare a problemi seri. Oggi questa distinzione è particolarmente difficile. Mentre in passato fonti come le enciclopedie avevano persone esperte che controllavano l’affidabilità delle informazioni, su internet si trova di tutto e la responsabilità di selezionare ciò che è vero spetta a ciascuno di noi.Perché studiare è essenziale
Per affrontare questa sfida, è necessario studiare in modo approfondito. Le informazioni veloci che si ottengono da computer o smartphone non sono sufficienti se non si possiede una base culturale solida. La cultura non è solo l’insieme dei dettagli che si imparano, ma è ciò che resta dentro di noi anche dopo aver dimenticato i particolari. Non basta saper leggere o conoscere le lingue straniere; serve un impegno serio e costante nello studio per sviluppare la capacità di giudizio critica.Lo studio come strumento democratico
Impegnarsi nello studio non è solo una fatica, ma è anche uno strumento potentissimo e democratico. Non esistono scorciatoie o privilegi basati sulla ricchezza, sul potere o sulla posizione sociale. Chi studia acquisisce conoscenza, chi non studia resta indietro, indipendentemente da quanto denaro possieda. Anche una persona ricca deve dedicare tempo e impegno sui libri, esattamente come chiunque altro.La conoscenza per una democrazia completa
La conoscenza è forse la cosa più democratica che esista. È la base indispensabile per un cittadino che deve essere in grado di fare scelte consapevoli e informate. Per questo motivo, la conoscenza è essenziale per il funzionamento di una democrazia piena e matura. Anche se l’accesso rapido alle informazioni istantanee può far sembrare lo studio tradizionale meno importante, studiare rimane insostituibile.Tecnologia e conoscenza: ruoli diversi
È vero che i computer e i telefoni rendono la vita più comoda e facilitano l’accesso ai dati. Permettono di trovare strade o informazioni rapidamente e di connettersi con altre persone in tutto il mondo. Tuttavia, la tecnologia da sola non può insegnare a distinguere la verità dalla bugia. Questa capacità si sviluppa solo attraverso lo studio critico e la riflessione profonda che esso richiede.Ma è sufficiente affidarsi unicamente allo studio individuale tradizionale per discernere il vero dal falso nell’era digitale?
Il capitolo sottolinea giustamente la necessità di una base solida, ma la sfida di distinguere le informazioni corrette oggi non riguarda solo la mancanza di cultura generale, bensì anche la comprensione del funzionamento degli ecosistemi digitali, delle logiche algoritmiche e delle dinamiche di disinformazione che vi prosperano. Affermare che la tecnologia è solo uno strumento di accesso rapido ignora la sua complessità come medium e come attore nella diffusione della conoscenza (e della non-conoscenza). Per comprendere appieno il contesto attuale, è utile esplorare le analisi sulla società dell’informazione di autori come Manuel Castells o le riflessioni sulla formazione del giudizio critico nell’era digitale.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]