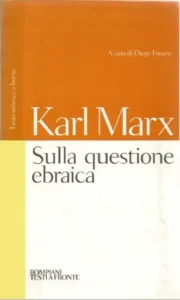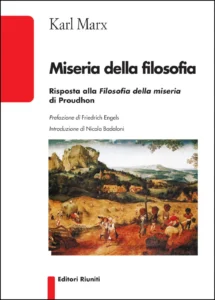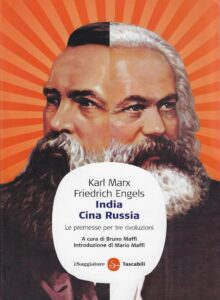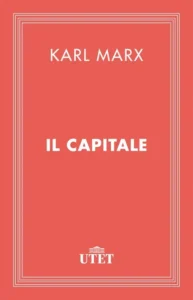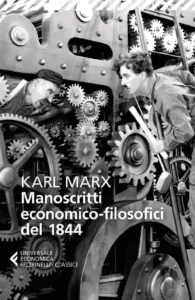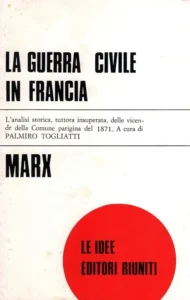1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La Comune di Parigi Marx e il presente” di Karl Marx ti catapulta nel 1871, nel pieno della Comune di Parigi, un evento che per Marx non è solo storia, ma una vera e propria rottura, un primo tentativo di “governo del popolo” che sfida lo Stato borghese tradizionale. Il libro analizza come a Parigi, dopo la sconfitta militare, la popolazione e la Guardia Nazionale si ribellino contro un governo a Versailles guidato da figure come Thiers, più interessato alla lotta di classe contro i lavoratori che alla difesa nazionale. Scoprirai le forme rivoluzionarie di democrazia diretta sperimentate dalla Comune e l’analisi di Marx su perché fosse necessario distruggere il vecchio apparato statale. Ma il testo non si ferma al passato: usa il pensiero politico di Marx per illuminare il nostro presente. Esplora come concetti come rivoluzione sociale, sovranità popolare e la critica allo Stato risuonino oggi, specialmente nel campo del populismo e nell’era digitale. È un libro che collega l’eco della Comune di Parigi alle sfide politiche attuali, mostrandoti come la lotta tra “popolo” ed “élite” e la richiesta di un “ritorno del Politico” abbiano radici profonde e si confrontino ancora con le questioni fondamentali sollevate da Marx sulla lotta di classe e la trasformazione sociale.Riassunto Breve
La Comune di Parigi del 1871 è un momento storico importante, visto come un tentativo di creare un governo del popolo che rompeva con le forme politiche normali. Nasce dopo la sconfitta francese contro la Prussia, quando il governo provvisorio, dominato da gruppi legati alla monarchia e agli interessi economici, firma una pace svantaggiosa. Questo governo, guidato da figure come Thiers, non si preoccupa della difesa nazionale ma di proteggere la proprietà e l’ordine sociale, arrivando a provocare Parigi e a tentare di disarmare la Guardia Nazionale, che era composta da cittadini. Il fallimento di questo tentativo porta all’insurrezione e alla nascita della Comune. La Comune sperimenta una forma di democrazia diretta: i rappresentanti sono eletti e possono essere rimossi, non c’è separazione tra chi fa le leggi e chi le applica, gli stipendi dei funzionari sono bassi. L’obiettivo è superare lo Stato come entità separata e far governare direttamente i produttori, emancipando il lavoro. Per Karl Marx, la Comune è un esempio di potere politico operaio e mostra che per fare una rivoluzione sociale bisogna distruggere il vecchio apparato statale. Marx pensava che la classe operaia fosse il motore del cambiamento per superare il capitalismo e le disuguaglianze, criticando il liberalismo che separa la libertà politica da quella sociale ed economica. La Comune viene sconfitta brutalmente dal governo di Versailles, che usa l’esercito liberato dai Prussiani. La repressione è violentissima e mostra la natura spietata della classe dominante nel difendere i propri interessi. Questa lotta viene descritta come una vera guerra di classe, dove la borghesia si allea anche con il nemico esterno per schiacciare i lavoratori. Questo evento storico serve anche a capire la politica di oggi. Il campo politico attuale è spesso definito populista, basato sulla contrapposizione tra “popolo” ed “élite”, che chiede un ritorno dell’intervento statale. Questa situazione è vista come una fase di passaggio, forse simile a quella che Marx osservò quando la politica passò dalla centralità del “popolo” a quella della “classe”. Le idee attuali di “rivoluzione”, a volte legate alle tecnologie digitali, propongono forme di partecipazione diretta ma spesso non affrontano le disuguaglianze sociali ed economiche, a differenza del progetto della Comune che puntava a una trasformazione profonda della società. La storia della Comune e la sua repressione evidenziano il conflitto permanente tra chi detiene il capitale e chi produce la ricchezza.Riassunto Lungo
1. L’eco della Comune nel pensiero di Marx e nella politica attuale
La Comune di Parigi è un momento storico di grande cambiamento. Ha mostrato la possibilità di un governo gestito direttamente dal popolo, diverso dai modelli parlamentari che i movimenti operai conoscevano. Per Gramsci, la Comune segna l’inizio di un periodo di difficoltà costante per la società di massa. Rappresenta un limite alla capacità della borghesia e del capitalismo di includere tutti. Di fronte a questo limite, le classi dominanti rispondono con forme di potere più chiuse.Come è nata la Comune di Parigi
La Comune nasce dopo la sconfitta della Francia nella guerra contro la Prussia nel 1870. Cade l’imperatore Napoleone III e viene proclamata la Terza Repubblica. Il governo provvisorio, guidato dai monarchici, firma un accordo di pace con la Prussia che molti a Parigi considerano un tradimento. La popolazione parigina, specialmente la Guardia Nazionale che era armata, si sente abbandonata. La classe dirigente non è più vista come legittima, le condizioni di vita sono difficili e la gente si mobilita. Questo porta all’insurrezione del 18 marzo 1871 e alla proclamazione della Comune il giorno dopo, il 19 marzo.Le idee e le azioni della Comune
La Comune era composta da persone diverse, ma con molti operai e membri dell’Internazionale. Hanno provato nuove forme di democrazia diretta. Hanno eliminato la separazione tra chi fa le leggi e chi le applica. I rappresentanti potevano essere revocati e dovevano seguire le istruzioni di chi li aveva eletti. Gli stipendi dei funzionari pubblici sono stati equiparati a quelli degli operai. Sono stati introdotti provvedimenti sociali, come la sospensione degli sfratti. Lo scopo era superare la divisione tra la vita dei cittadini e lo Stato, riducendo lo Stato a semplici funzioni amministrative e dando il potere politico alla società stessa, vista come l’insieme dei produttori.La sconfitta e le riflessioni di Marx
La Comune fu sconfitta, anche a causa di disorganizzazione e indecisioni. Questa sconfitta spinse Marx a pensare che per fare una rivoluzione sociale fosse necessario distruggere completamente il vecchio sistema statale. Pensò anche che fosse necessaria una fase di “dittatura” per sconfiggere definitivamente gli avversari. Per Marx, la Comune divenne un esempio di come il potere politico potesse essere gestito dal proletariato e di come si potesse superare lo Stato borghese.Il pensiero politico di Marx
Il pensiero politico di Marx si basa sulla filosofia della storia moderna e sulla dialettica di Hegel. Vede nella classe operaia il soggetto storico capace di superare il capitalismo. Attraverso l’eliminazione delle classi sociali e la fine dei conflitti, si può arrivare all’emancipazione umana. La rivoluzione non avviene in automatico solo per ragioni economiche, ma richiede che il soggetto rivoluzionario agisca in modo consapevole. Marx critica il liberalismo perché separa la libertà politica da quella sociale. Questo rende la libertà un concetto astratto e subordina il potere politico al capitale. Per Marx, il comunismo significa lo sviluppo libero di ogni individuo e la fine delle ideologie, che lui vede come modi per rappresentare come universali gli interessi di pochi.L’eco della Comune oggi
Oggi, l’idea di “rivoluzione” torna nel linguaggio comune e politico, spesso legata alle tecnologie digitali. Queste tecnologie sembrano anticipare modelli di governo che non si basano più sulla rappresentanza tradizionale. Permettono una partecipazione diretta, ma spesso individuale, e concentrano il potere decisionale. Alcune forze politiche propongono riforme che riducono il ruolo delle istituzioni tradizionali, usando un linguaggio contro la politica simile a quello della Comune. Tuttavia, il progetto di Marx vedeva il superamento dello Stato come una conseguenza di una profonda trasformazione sociale. Le tendenze attuali, invece, propongono un cambiamento politico (o lo presentano come una questione tecnica) senza affrontare il problema della disuguaglianza sociale. Questo potrebbe finire per rafforzare il potere economico esistente.Se l’eco della Comune oggi risuona in linguaggi “rivoluzionari” legati alla tecnologia e all’anti-politica, non si rischia di usare parole forti per evitare di affrontare la disuguaglianza sociale che Marx considerava centrale?
Il capitolo, nel mettere a confronto il progetto di Marx con le tendenze attuali che riprendono il linguaggio “rivoluzionario”, evidenzia giustamente il rischio che queste ultime non affrontino la disuguaglianza sociale. Tuttavia, la questione merita un approfondimento: l’uso di un linguaggio anti-politico e l’enfasi sulla tecnologia come motore di cambiamento non rischiano di essere un modo per evitare il confronto diretto con le strutture di potere economico che il progetto di Marx intendeva superare? Per esplorare a fondo questa problematica, è utile consultare studi sulla sociologia della tecnologia, la critica del capitalismo contemporaneo e la storia del pensiero politico, leggendo autori che analizzano l’evoluzione delle forme di potere e disuguaglianza nell’era digitale.2. Il Campo Populista e la Richiesta di Politica
Nella storia moderna, è tornata spesso l’idea che la politica non sia più necessaria. Si è creduto potesse sparire, sostituita da altre forze come la tecnologia, la scienza, il mercato o grandi cambiamenti sociali. Sia nel pensiero di Marx, che vedeva una società senza classi dopo una trasformazione profonda, sia nel liberismo, con l’idea di un mercato capace di regolarsi da solo e uno Stato che interviene pochissimo, si immagina un mondo senza conflitti interni. Nel caso del liberismo, si descrive una società ideale dove le differenze sociali non contano più e il successo dipende solo dal talento e dal merito di ognuno. Se si immagina una società senza conflitti, allora si pensa anche che lo Stato e la politica diventino meno importanti.Il contesto attuale e la nascita del populismo
Oggi la situazione politica è complicata e delicata. I grandi cambiamenti di oggi, come quelli legati al digitale e alla distanza tra la vita di tutti i giorni e le istituzioni, dipendono da chi ha più forza nella società. In questo scenario, lo spazio politico attuale è spesso chiamato populista. Chi sfida i potenti si presenta come “popolo”, non più come “classe”. Molti partiti e movimenti nati di recente vengono definiti populisti perché mettono l’accento sulla divisione tra “popolo” ed “élite” e chiedono che il popolo abbia il potere di decidere. Il populismo non è solo un tipo di attore politico, ma è diventato lo spazio principale in cui si fa politica e si cercano voti.Caratteristiche del campo populista
Questo spazio populista crea una divisione netta tra democrazia e potere di pochi. Ricorda vecchie idee di scontro tra chi sta “in basso” e chi sta “in alto”, tra il “popolo” e chi governa. Il successo di chi agisce in questo spazio indica un cambiamento nel modo di fare politica, da una “guerra di posizione” a una più veloce e diretta, che mette in discussione le regole generali della politica e dell’economia. L’economia ha reso la politica meno capace di agire, e questo ha aperto uno spazio per chi si oppone al potere di pochi.Cosa offre il populismo e a chi si rivolge
Chi agisce nel populismo risponde al desiderio di vedere la politica tornare a contare, offrendo sicurezza, un’identità chiara e un senso di comunità. Chiedere che il popolo decida può voler dire cose diverse, dal dare importanza alla nazione al chiedere più intervento dello Stato nell’economia, ma è sempre una richiesta che lo Stato agisca. Le persone mostrano atteggiamenti contrastanti: vogliono partecipare direttamente, ma anche fidarsi di un leader, e allo stesso tempo sono ribelli. In questo scenario, la politica si rivolge a tutti (come “cittadini” o “popolo”) invece che a gruppi specifici con interessi particolari (come “lavoratori” o “classi”).Il populismo come fase di transizione
Il fatto che il populismo sia così centrale oggi fa pensare che stiamo passando da un modo di fare politica a un altro. Il populismo è una fase che non durerà per sempre. Rimanere fuori da questa contrapposizione tra chi vuole il potere al popolo e chi rappresenta il potere di pochi rende difficile essere visti come attori politici che contano. Questa situazione ha punti in comune con l’epoca di Marx, che vide il passaggio dal “popolo” alla “classe” come soggetto politico principale. Non si sa ancora se questa divisione populista lascerà il posto a un nuovo scontro basato sulle classi sociali.Se il capitolo descrive il populismo come il “campo principale” della politica attuale, non si rischia di ridurre la complessità del dibattito pubblico e delle altre forme di conflitto sociale e politico?
Il capitolo presenta il populismo come lo spazio politico dominante, basato sulla contrapposizione tra “popolo” ed “élite”. Tuttavia, questa lettura, pur diffusa, potrebbe non cogliere appieno la varietà delle dinamiche politiche contemporanee, che includono anche conflitti di interesse, differenze ideologiche non riducibili a questa dicotomia, e l’azione di attori non direttamente inquadrabili nel “campo populista”. Per approfondire queste sfumature e comprendere meglio le diverse interpretazioni del fenomeno, è utile esplorare gli studi sulla teoria politica contemporanea e la sociologia dei movimenti sociali. Si possono consultare autori come Laclau, che ha elaborato la teoria del populismo come logica egemonica, o Mudde, che propone una definizione più restrittiva, ma anche autori che analizzano le trasformazioni dei partiti politici tradizionali e l’emergere di nuove forme di partecipazione.3. Parigi e il Governo di Classe
Il 4 settembre 1870, a Parigi viene proclamata la repubblica. Un gruppo di politici, tra cui Thiers e Favre, prende il potere. Questo governo, però, non ha ricevuto un mandato dal popolo. Il suo scopo principale non è difendere la nazione, ma proteggere gli interessi delle classi dominanti e riportare sul trono la monarchia. Uomini come Trochu confessano subito che difendere Parigi è impossibile e iniziano a pianificare la resa, anche se in pubblico promettono di resistere con forza. Figure importanti del governo, come Favre e Picard, sono coinvolte in scandali e casi di corruzione che ne minano la credibilità. Thiers, noto per la sua lunga carriera politica fatta di opportunismo, tradisce i suoi alleati e cerca solo di arricchirsi, mostrando un profondo disprezzo per chi produce ricchezza con il proprio lavoro.La resa e le sue conseguenze
La capitolazione di Parigi ai Prussiani, negoziata proprio da questo governo, contiene clausole che sembrano studiate apposta per far scoppiare una guerra civile. L’assemblea nazionale che viene eletta a Bordeaux è composta in gran parte da monarchici, chiamati “rurali”, che accettano le dure condizioni di pace imposte da Bismarck. Il governo guidato da Thiers provoca di proposito la popolazione di Parigi con leggi ingiuste e cerca di disarmare la Guardia Nazionale. In particolare, tenta di requisire i cannoni che i cittadini avevano comprato con i propri soldi per difendere la città.La rivolta del 18 marzo e la nascita della Comune
Il tentativo di prendere i cannoni a Montmartre fallisce il 18 marzo. La Guardia Nazionale si oppone e i soldati inviati per l’operazione si uniscono al popolo. Il governo, spaventato, fugge a Versailles. A Parigi si forma così la Comune, che diventa il governo della classe operaia. La Comune prende decisioni importanti per cambiare la società. Abolisce l’esercito regolare, sostituendolo con la Guardia Nazionale composta dai cittadini armati. La polizia viene sostituita da agenti che sono responsabili verso il popolo e che possono essere eletti e rimossi. Tutti i funzionari pubblici, inclusi giudici e magistrati, diventano elettivi e possono essere revocati dai cittadini. La chiesa viene separata dallo stato. La vera essenza della Comune è l’idea di liberare il lavoro e i lavoratori dallo sfruttamento.Il conflitto con Versailles
Il governo di Versailles, sotto la guida di Thiers, scatena una guerra estremamente violenta contro Parigi. Per farlo, usa anche i prigionieri di guerra francesi che i Prussiani hanno liberato apposta. Durante questo assedio, le truppe di Versailles commettono atrocità contro la popolazione parigina. Nonostante l’attacco e la violenza subita, Parigi sotto il governo della Comune vive un periodo di ordine e sicurezza interna. La Comune rappresenta la vera Francia, quella fatta anche dalla classe media e dai contadini, a differenza del governo di Versailles, che appare corrotto e interessato solo ai propri privilegi. La Comune è un governo che pensa alla nazione, ma è anche aperto al mondo, accogliendo e rappresentando tutti i lavoratori, senza distinzione di nazionalità.[/membership]È storicamente sostenibile una narrazione che dipinge il governo di Versailles unicamente come una congrega di corrotti e traditori, interessati solo ai propri privilegi?
Il capitolo, pur offrendo un quadro vivido degli eventi, adotta una prospettiva fortemente schierata che rischia di semplificare eccessivamente la complessa realtà politica e sociale dell’epoca. Attribuire unicamente motivazioni venali o reazionarie agli attori del governo di Versailles ignora le pressioni politiche, militari e sociali che essi subivano, così come la diversità di opinioni e interessi al loro interno. Per ottenere una comprensione più completa, è fondamentale esplorare le molteplici sfaccettature di quel periodo, studiando la storia politica della Terza Repubblica, le dinamiche delle classi sociali in Francia e le diverse interpretazioni storiografiche degli eventi. Approfondire autori che offrono analisi più sfumate può aiutare a cogliere la complessità di un momento storico cruciale.4. La Guerra di Classe e la Vendetta di Versailles
Nominato capo del governo, Thiers cerca subito di reintrodurre le vecchie tasse protettive contro l’Alsazia. Sfrutta la situazione di controrivoluzione per abbassare i salari e la divisione del territorio francese per far aumentare i prezzi. A Francoforte, Thiers e Favre trattano con Bismarck.L’accordo con Bismarck e la preparazione dell’attacco
Bismarck pone un aut aut: o si ripristina l’Impero, oppure la Francia deve accettare le sue condizioni di pace. Queste condizioni includono la riduzione dei tempi per pagare l’indennità di guerra e l’occupazione dei forti di Parigi fino a quando Bismarck non sarà soddisfatto della situazione interna francese. In cambio, Bismarck offre di liberare l’esercito bonapartista prigioniero per usarlo contro Parigi e di aiutare con le truppe prussiane. Thiers accetta queste condizioni e firma il trattato di pace il 10 maggio. Prima che i prigionieri liberati arrivino, Thiers finge di voler trovare un accordo, promettendo perdono per tutti tranne per chi ha ucciso i generali. Tuttavia, rassicura l’Assemblea nazionale che l’azione decisiva arriverà presto.La repressione brutale a Parigi
Quando il generale Mac-Mahon è pronto, Thiers annuncia che entrerà a Parigi con la forza della legge e che chiederà una punizione completa. Dichiara che sarà “senza pietà” e dà ai soldati il permesso di vendicarsi. Il 21 maggio, un tradimento apre le porte di Parigi alle truppe di Versailles. Il giorno dopo, il 22, Thiers proclama la “vittoria dell’ordine, della giustizia e della civiltà”. La repressione che segue mostra la vera natura della civiltà borghese: una violenza estrema e una vendetta immediata e senza regole. Le atrocità commesse nel 1871 superano quelle del 1848. Nonostante tutto, la popolazione di Parigi resiste con grande coraggio per otto giorni. Le azioni di Thiers e del suo esercito vengono paragonate alle antiche persecuzioni romane di Silla, ma rese peggiori dall’uso delle mitragliatrici e dalla giustificazione basata sulla “legge” e sulla “civiltà”.La verità sulle azioni della Comune
Mentre Parigi viene massacrata, la borghesia festeggia nei caffè e nei ristoranti. Questa è la “Parigi della decadenza”, quella tornata da Versailles. La borghesia accusa la Comune di aver complottato contro la civiltà, di essere un abuso di potere, di aver trasformato le donne in persone feroci e di aver nascosto la sua crudeltà. L’incendio dei monumenti da parte dei lavoratori viene definito vandalismo, mentre il bombardamento di Parigi da parte di Thiers e gli incendi appiccati dai governi in guerra sono considerati azioni legittime. La Comune usa il fuoco come estremo mezzo di difesa, per bloccare le strade e coprire la ritirata, solo dopo che le truppe di Versailles hanno iniziato i massacri. La Comune aveva minacciato di seppellirsi sotto le rovine di Parigi, proprio come aveva promesso il governo di difesa nazionale.Le esecuzioni degli ostaggi
L’esecuzione dei sessantaquattro ostaggi da parte della Comune, tra cui l’arcivescovo, è una risposta all’abitudine ripresa dalla borghesia nel 1848 di fucilare i prigionieri disarmati e alla pratica prussiana di prendere ostaggi. La Comune adotta questa misura per cercare di proteggere i prigionieri. Le continue fucilazioni da parte delle truppe di Versailles rendono inevitabile la sorte degli ostaggi. Thiers è considerato il vero responsabile della morte dell’arcivescovo, perché ha rifiutato di scambiarlo con Blanqui, sapendo che un arcivescovo morto gli sarebbe stato più utile per i suoi scopi. Le bugie diffuse contro la Comune dimostrano che la borghesia si considera l’erede dei signori feudali, per i quali ogni arma contro il nemico era accettabile, mentre qualsiasi arma in mano al nemico era vista come un crimine.L’alleanza contro il proletariato
I massacri di Parigi sono il punto più alto di un piano della classe dominante per distruggere la rivoluzione con l’aiuto degli invasori. Bismarck si compiace della distruzione di Parigi e dei cadaveri dei lavoratori, vedendo in ciò la fine della Francia. La Prussia, pur non essendo in guerra con la Comune, agisce come un soldato pagato da Versailles. Questa alleanza tra conquistatori e vinti per massacrare il proletariato dimostra che la società borghese è ormai esaurita e che le guerre tra nazioni sono un inganno per ritardare la lotta tra le classi sociali. Tutti i governi nazionali si uniscono contro il proletariato.Il ruolo dell’Internazionale e il futuro della lotta
Dopo il maggio 1871, non c’è pace tra i lavoratori francesi e chi li sfrutta. La lotta riprenderà, e l’esito di questa battaglia tra la minoranza che accumula ricchezza e la maggioranza che produce non è incerto. I lavoratori francesi sono all’avanguardia del proletariato moderno. I governi europei, vedendo il carattere internazionale della lotta di classe a Parigi, attaccano l’Associazione Internazionale dei Lavoratori, considerandola la causa dei disastri. L’Internazionale non è un’organizzazione segreta, ma un legame tra i lavoratori più avanzati. I suoi membri sono in prima linea ovunque la lotta di classe diventa importante. L’Internazionale ha radici profonde nella società moderna e non può essere eliminata finché esiste il potere del capitale sul lavoro. Parigi dei lavoratori, con la sua Comune, è un esempio di una nuova società. I suoi martiri sono onorati dalla classe operaia, mentre chi li ha uccisi è condannato dalla storia.Il capitolo non rischia di presentare una visione eccessivamente semplificata e ideologicamente orientata di eventi storici complessi come la Comune di Parigi?
Il capitolo offre una narrazione molto netta e schierata degli eventi, interpretandoli quasi esclusivamente attraverso la lente della lotta di classe tra una borghesia monolitica e malvagia e un proletariato eroico e vittima. Questa prospettiva, pur legittima come chiave di lettura, tende a ridurre la complessità delle motivazioni, delle fazioni interne (sia a Versailles che nella Comune) e del contesto politico nazionale e internazionale, che andava oltre il mero scontro di classe. Per ottenere una comprensione più completa e sfaccettata, sarebbe utile esplorare interpretazioni storiografiche diverse, che considerino anche altri fattori come le dinamiche politiche interne francesi post-Impero, le diverse correnti ideologiche presenti nella Comune stessa, e le paure e le ragioni (per quanto discutibili) del governo di Versailles. Approfondire le opere di storici che hanno analizzato la Comune da prospettive non strettamente marxiste può aiutare a bilanciare il quadro.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]