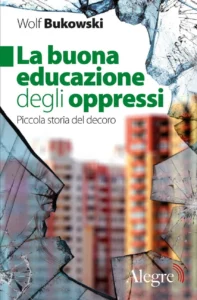Contenuti del libro
Informazioni
“La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro” di Wolf Bukowski ti porta in un viaggio attraverso le città, da New York a Milano e Bologna, per smascherare come i concetti di decoro urbano e sicurezza siano diventati armi contro i più deboli. Il libro analizza l’origine della tolleranza zero e la teoria delle finestre rotte, mostrando come queste idee, nate per combattere il disordine, finiscano per criminalizzare la povertà e la marginalità, colpendo immigrati, senzatetto e chi non si conforma. Scoprirai come il neoliberismo sfrutti la paura e le disuguaglianze sociali, riducendo il welfare e promuovendo una meritocrazia che legittima i privilegi esistenti. Bukowski ti fa vedere come la retorica del decoro, apparentemente innocua, sia in realtà uno strumento di controllo sociale ed estetizzazione della politica, usato per allontanare i poveri dagli spazi pubblici e favorire interessi economici, trasformando la sicurezza in un business e la città in un luogo sempre più esclusivo. È una piccola storia che ti farà guardare il “decoro” con occhi diversi, capendo chi ci guadagna davvero e chi viene schiacciato in nome dell’ordine.Riassunto Breve
Le politiche neoliberiste confondono le classi sociali, isolando gli individui e promuovendo il nazionalismo, e sostituiscono i rapporti economici con quelli comportamentali, definendo le classi inferiori in base alle condotte e non alle condizioni materiali, rendendo la povertà una colpa individuale. La meritocrazia legittima i privilegi esistenti, applicando il concetto di merito alle classi inferiori per modulare il welfare in chiave disciplinare, come nei sistemi a punti per le case popolari o nel Daspo urbano, che negano diritti in nome del decoro. Le istituzioni stesse adottano logiche meritocratiche che premiano chi è già ricco. La teoria delle finestre rotte sostiene che la percezione di insicurezza derivi dal disordine urbano, non dai crimini reali, portando a perseguire il disordine e la “gente disordinata” per placare le ansie della classe media, anche se i fatti smentiscono la teoria e la percezione diviene più importante della realtà. La paura nei cittadini viene manipolata con discorsi allarmistici e ostentazione di forza per spingere verso politiche autoritarie, distraendo dai problemi reali e favorendo chi sfrutta la paura per consenso. La repressione del “disordine” diventa prioritaria, negando l’utilità dei dati reali. La tolleranza zero, nata a New York negli anni Novanta applicando la teoria delle finestre rotte, si concentra sulla punizione severa di infrazioni minori, colpendo in modo sproporzionato minoranze etniche, poveri e marginalizzati, come mendicanti e senzatetto. Questa strategia si diffonde anche in Italia, aggirando sentenze che tutelano il diritto di chiedere l’elemosina e usando infrazioni minori in modo mirato nei quartieri poveri. La tolleranza zero si rivela ingiusta e inefficace, aumentando brutalità della polizia e criminalizzando comunità impoverite, senza affrontare le cause profonde del crimine come povertà e instabilità sociale. La narrazione che attribuisce alla tolleranza zero il calo dei reati a New York è infondata, poiché la diminuzione era già in atto per altri fattori come la fine dell’epidemia di crack e politiche di controllo delle armi. La tolleranza zero alimenta un clima di paura che incrementa la domanda di armi, creando un circolo vizioso, e studi smentiscono il legame tra repressione dei piccoli reati e diminuzione della criminalità grave. Il concetto di “qualità della vita” è distorto in chiave securitaria, rivendicato dalle classi medie per ottenere politiche di pulizia e polizia, teorizzato dal Manhattan Institute per promuovere un decoro urbano basato sull’esclusione dei marginali e la privatizzazione degli spazi pubblici (BID). Parallelamente, il welfare subisce tagli drastici, giustificati dalla narrazione del “non ci sono i soldi”, che maschera la crescente concentrazione della ricchezza. Securitariismo e decoro diventano strumenti di controllo sociale in un contesto di ritiro dello stato dall’economia e inasprimento del suo intervento penale. Negli anni Novanta in Italia, nonostante il calo dei reati, si diffonde un sentimento di insicurezza legato all’immigrazione, promosso dalle destre e non contrastato efficacemente dalla sinistra che abbandona l’analisi di classe e indirizza la paura generata dalle politiche neoliberali verso falsi obiettivi prossimali. L’enfasi sui sindaci, economicamente depotenziati, li spinge a concentrarsi su ordine pubblico e decoro a scapito di interventi sociali. Eventi come la costruzione europea e Tangentopoli contribuiscono a un clima che trasforma la paura in merce politica. A Milano e Bologna, la paura diviene strumento politico per distogliere l’attenzione da problemi sociali e promuovere interessi economici, spostando il focus dai problemi politici ai marginali e agli immigrati. La sicurezza diviene sinonimo di controllo e repressione, anche nel realismo di sinistra che cede alla retorica della limitatezza delle risorse. Negli anni Zero, la politica italiana converge su sicurezza e immigrazione, con una “schizofrenia legislativa” che protegge i potenti e reprime i marginali. Emerge una logica di “sacralizzazione” di alcuni gruppi e “disprezzo” per altri, con il decoro centrale per escludere i non abbienti dagli spazi pubblici. Il Partito Democratico adotta il “legalitarismo” come feticcio, abbandonando le questioni di classe e usando la legalità per colpire i poveri e i marginali. Questa deriva legalitaria e securitaria porta a una progressiva “fascistizzazione” della vita urbana, reprimendo dissenso e marginalità in nome di un ordine pubblico orientato al controllo. Il decoro emerge come concetto chiave, indefinito e sfuggente, legato a sicurezza e civiltà ma definito circolarmente, operando come “idea senza parole” basata su un passato mitico. Si manifesta nella gestione dello spazio urbano (rimozione graffiti, panchine anti-bivacco) per cancellare espressioni non conformi e controllare comportamenti “indecorosi”, colpendo i marginalizzati. La retorica del decoro giustifica politiche repressive, militarismo, limitazione dei diritti e criminalizzazione delle lotte sociali, portando a una depoliticizzazione autoritaria e al rifiuto di spiegazioni sociali a favore di soluzioni poliziesche. Il decoro si rivela uno strumento ideologico di destra che, sotto la maschera di valori condivisi, persegue controllo sociale e difesa degli interessi dominanti, imponendo un ordine fittizio. Il decoro urbano si modella sulla “Quality of Life” delle classi agiate, legato alla proprietà immobiliare, promuovendo militarizzazione e repressione della vita di strada a vantaggio degli operatori immobiliari. Diventa un’ideologia che inganna i cittadini, spingendoli a sostenere politiche che peggiorano le loro condizioni, come la riqualificazione dei mercati che genera profitti per pochi ma problemi per i residenti. La risposta istituzionale al “degrado post-riqualificazione” è repressiva e orientata a una selezione classista della clientela. La socialità spontanea viene repressa, mentre il “bello” e l'”autenticità” diventano strumenti per estrarre valore attraverso il turismo. Il confine tra “bello” e “brutto” è definito dalla classe sociale, creando una gerarchia di accesso alla città decorosa dove i diritti civili non bastano più e si richiede un “comportamento adeguato” che si traduce in adeguato consumo. Chi non consuma o è marginalizzato viene allontanato o sanzionato. Il decoro si configura come estetizzazione della politica, che mira a conservare le disuguaglianze esistenti e a mettere a reddito ogni aspetto della vita urbana, in una guerra silenziosa contro le fasce più deboli.Riassunto Lungo
1. La fabbrica del decoro e della paura
Decoro, sicurezza e cancellazione delle classi sociali
L’idea di decoro e sicurezza viene usata per cancellare le differenze tra le classi sociali. Questa operazione crea confusione tra le diverse classi, portando all’isolamento delle persone e unendole sotto il nazionalismo, che è un elemento centrale del neoliberismo. In questo modo, i rapporti economici vengono sostituiti da quelli comportamentali. Le espressioni “lower-class” e “underclass” non descrivono più condizioni economiche, ma comportamenti. Di conseguenza, la povertà non è più vista come un problema della società, ma come una colpa del singolo individuo.La meritocrazia e i privilegi
La meritocrazia viene presentata come un’alternativa ai privilegi ereditari, ma in realtà serve a proteggere i privilegi esistenti. Il concetto di merito viene applicato soprattutto alle classi più povere, modificando il sistema di assistenza sociale in modo punitivo. Per ricevere aiuto, il povero deve dimostrare di meritarlo, rinunciando ai propri diritti fondamentali. Alcuni esempi di questo sistema sono i meccanismi a punti per ottenere una casa popolare, che distorcono il diritto all’abitazione e creano ostilità sociale, e il Daspo urbano, che nega ai senzatetto il diritto di vivere in città in nome del decoro. Anche le istituzioni pubbliche seguono logiche meritocratiche nell’assegnazione delle risorse, favorendo chi è già ricco e potente.La teoria delle finestre rotte e la percezione di insicurezza
Secondo la teoria delle finestre rotte, l’insicurezza che le persone percepiscono è causata dal disordine nelle città, più che dai crimini veri e propri. Perciò, si interviene contro il disordine e le “persone disordinate” – come i mendicanti, gli ubriachi e i giovani – nel tentativo di calmare le paure della classe media. Questo avviene anche se i fatti dimostrano che questa teoria è sbagliata. In questo contesto, ciò che le persone percepiscono diventa più importante della realtà oggettiva.La manipolazione della paura e le politiche autoritarie
La paura viene utilizzata per influenzare i cittadini attraverso discorsi allarmistici e mostrando la forza militare, creando un senso generale di insicurezza. Lo scopo di questa strategia è spingere le persone a cercare protezione in politiche autoritarie, allontanando l’attenzione dai problemi reali. Questo sistema favorisce chi usa la paura per ottenere consenso politico. La repressione del “disordine” diventa la priorità principale, anche se questo significa compiere azioni senza senso e eccessive. In questo modo, si rifiuta di considerare i dati concreti e si preferisce governare manipolando la paura delle persone.Ma è davvero così lineare la sostituzione dei rapporti economici con quelli comportamentali, come descritto nel capitolo?
Il capitolo presenta una visione netta della manipolazione del decoro e della sicurezza per fini di controllo sociale, ma non approfondisce le sfumature di tale processo. Per comprendere appieno la complessità di questa dinamica, sarebbe utile esaminare le teorie sociologiche sul cambiamento sociale e culturale, studiando autori come Pierre Bourdieu, per capire come i comportamenti e le percezioni individuali siano influenzati da fattori economici e sociali in maniera meno deterministica e più interattiva di quanto suggerito.2. La Tolleranza Zero: Dalle ‘Finestre Rotte’ alla Criminalizzazione della Marginalità
Nascita e diffusione della Tolleranza Zero
La tolleranza zero nasce a New York negli anni Novanta. Il commissario William Bratton la introduce ispirandosi alla teoria delle finestre rotte di Wilson e Kelling. Questa teoria dice che se si ignorano piccoli problemi urbani, come i graffiti o i mancati pagamenti dei mezzi pubblici, aumenta la criminalità grave. Bratton diventa capo della polizia della metropolitana nel 1990 e poi sindaco di New York nel 1994. In questi ruoli applica la tolleranza zero, prima nella metropolitana e poi in tutta la città.Cosa significa Tolleranza Zero
La tolleranza zero vuol dire punire severamente anche le piccole infrazioni. Ad esempio, saltare i tornelli della metro o bere alcolici in pubblico. Con questo sistema, chiunque può essere arrestato per piccole violazioni. Però, a essere colpiti di più sono le minoranze etniche, i poveri e le persone marginalizzate. Un manuale della polizia di New York del 1996, chiamato “breviario”, spiega quali comportamenti sono punibili. Questo manuale conferma che l’obiettivo sono i comportamenti tipici delle persone che si vogliono criminalizzare, cioè la “gente disordinata”. Mendicanti, lavavetri e senzatetto diventano i principali bersagli. Vengono multati o arrestati se chiedono l’elemosina o se hanno coperte per strada.La Tolleranza Zero in Italia
Questa strategia arriva anche in Italia. Alcuni amministratori locali iniziano ad applicare politiche simili. Alcune sentenze provano a limitare gli eccessi della tolleranza zero, come il diritto di chiedere l’elemosina. Ma le leggi vengono cambiate per superare questi limiti e continuare a criminalizzare la povertà. Anche le piccole infrazioni stradali, come attraversare la strada fuori dalle strisce, vengono usate contro i poveri in alcuni quartieri.Inefficacia e conseguenze negative della Tolleranza Zero
La tolleranza zero si dimostra ingiusta e anche inutile. Aumentano i casi di violenza e abuso da parte della polizia, soprattutto contro afroamericani e latinos. Questa strategia, invece di diminuire la criminalità, sembra peggiorare le disuguaglianze sociali. Intere comunità povere e marginalizzate vengono criminalizzate. Queste persone sono vittime sia della tolleranza zero sia delle politiche economiche che hanno aumentato la povertà. Il legame tra disordine e crimine grave viene messo in dubbio. La povertà e i problemi sociali sembrano essere cause più importanti della criminalità. La tolleranza zero quindi non risolve il problema alla radice. Colpisce in modo ingiusto le persone più deboli.La “tolleranza zero” è stata davvero l’unico approccio possibile per affrontare il problema della criminalità urbana negli anni ’90, o esistevano alternative più efficaci e meno discriminatorie che il capitolo ignora?
Il capitolo presenta una critica radicale della “tolleranza zero”, concentrandosi sugli aspetti negativi e le conseguenze indesiderate. Per avere un quadro più completo, sarebbe utile esplorare se esistevano altre teorie o politiche alternative all’epoca, e perché la “tolleranza zero” fu preferita nonostante i rischi evidenziati. Approfondire studi di sociologia urbana e criminologia, leggendo autori come David Garland o Loïc Wacquant, potrebbe offrire una prospettiva più ampia sulle diverse strategie di controllo della criminalità e sulle loro implicazioni sociali.3. La Crisi Fabbricata e il Business della Paura
La narrazione sulla tolleranza zero e la realtà dei fatti
La credenza che la politica di tolleranza zero abbia causato la diminuzione dei reati a New York dal 1994 è sbagliata. La diminuzione dei crimini era già iniziata in tutti gli Stati Uniti e a New York, con un calo importante di rapine e omicidi già prima dell’arrivo di Giuliani. Questa riduzione è stata causata da diversi fattori, come la fine dell’epidemia di crack e le politiche di controllo delle armi del sindaco Dinkins. È paradossale che proprio le politiche di Dinkins contro le armi abbiano reso New York più sicura, ma il merito sia stato dato alla tolleranza zero, un modello che si adatta meglio alle idee neoliberali.La diffusione della tolleranza zero e le sue conseguenze negative
La tolleranza zero si è diffusa in tutto il mondo, creando un clima di paura che aumenta la richiesta di armi. Questo crea un circolo vizioso di insicurezza. Gli Stati Uniti, con leggi sulle armi più permissive, hanno molti più omicidi rispetto a paesi con leggi più severe. Nonostante questo, la politica della sicurezza continua ad essere popolare, anche in Italia, dove molti chiedono la tolleranza zero. A New York, invece, si sta capendo che non funziona. Infatti, studi scientifici hanno dimostrato che non c’è un legame tra la repressione dei piccoli reati e la diminuzione della criminalità grave. La criminalità cambia strategia per adattarsi alle azioni repressive.La distorsione del concetto di “qualità della vita”
L’idea di “qualità della vita”, all’inizio legata al benessere sociale, è stata cambiata in un’ottica di sicurezza. Negli anni ’80, le classi medie hanno iniziato a chiedere una “loro” qualità della vita, ottenendo politiche che si concentravano sulla pulizia e sulla polizia. Questa visione che favorisce le classi più ricche è stata teorizzata dal Manhattan Institute. Questo istituto ha promosso l’idea di un decoro urbano che si basa sull’esclusione delle persone più povere. Fred Siegel descrive una New York decadente a causa delle minoranze e dei poveri, e propone di “salvare” la città privatizzando gli spazi pubblici e con l’intervento dei cittadini ricchi. Così sono nati i “Business Improvement Districts” (BID), zone private delle città dove la sicurezza e il decoro sono gestiti da privati, spesso con metodi violenti contro i senzatetto.Il ridimensionamento del welfare e l’aumento del controllo sociale
Mentre avanzava l’idea del “decoro”, il welfare ha subito un forte ridimensionamento. Sono stati fatti tagli ai servizi pubblici e sono aumentati i carcerati e i senzatetto, spinti ai margini della società. La crisi economica è stata usata come scusa per giustificare questi tagli, dicendo che “non ci sono i soldi”. Questa idea, promossa da politiche neoliberali, fa credere che la mancanza di soldi per il welfare sia inevitabile. In questo modo, si nasconde il fatto che la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi. Anche servizi fondamentali come i bagni pubblici sono stati colpiti da questa logica di riduzione delle spese, nonostante la grande ricchezza di Wall Street. La frase “non possiamo più permettercelo” nasconde la scelta politica di favorire i guadagni privati a danno del benessere di tutti. Quindi, la sicurezza e il decoro diventano strumenti per controllare la società quando lo stato si ritira dall’economia ma aumenta il suo intervento nel sistema penale. Tutto questo serve a mantenere la situazione di potere esistente.Se il decoro è solo uno strumento ideologico di destra, come si spiega l’uso di concetti simili in politiche di diversa orientazione politica?
Il capitolo presenta il decoro come un concetto univocamente legato a politiche di destra. Tuttavia, è importante considerare se questa interpretazione sia esaustiva. Per rispondere a questa domanda, si potrebbe approfondire la sociologia politica e la filosofia politica, esplorando come diversi autori, come Michel Foucault, hanno analizzato il rapporto tra potere, discorso e controllo sociale. Comprendere come concetti simili al decoro siano stati utilizzati in contesti politici diversi potrebbe arricchire l’analisi e fornire una visione più complessa.8. La Fabbrica del Decoro Urbano
Il concetto di decoro urbano e le classi agiate
Il decoro urbano nasce dall’idea di “Quality of Life” tipica delle classi più ricche. Questo concetto è strettamente legato al valore degli immobili. Le campagne per promuovere il decoro urbano ottengono spesso il sostegno delle persone comuni, che credono che queste iniziative aumentino il valore delle loro case. In realtà, queste campagne favoriscono soprattutto gli interessi degli operatori immobiliari di alto livello, portando alla militarizzazione e alla repressione della vita nelle strade.L’ideologia del decoro urbano e la riqualificazione
Il decoro urbano diventa quindi un’ideologia che inganna i cittadini. Li convince a sostenere politiche che peggiorano la loro vita, aumentando i costi e riducendo i servizi sociali. Un esempio chiaro è la riqualificazione dei mercati rionali. In questi casi, si smette di parlare di “degrado” e si inizia a parlare di “movida” e di “potenzialità”. L’obiettivo è attrarre investimenti e turismo. Questi processi portano grandi guadagni per pochi e fanno aumentare i prezzi delle case. Allo stesso tempo, creano problemi per chi vive nel quartiere, a causa del rumore notturno e dei cambiamenti nel modo di vivere della zona.La risposta delle istituzioni e la selezione sociale
Quando il “degrado” si ripresenta dopo la riqualificazione, le istituzioni reagiscono con misure repressive e cercando accordi con i ristoratori. L’obiettivo è scegliere in modo rigido i clienti, basandosi sulla classe sociale. La socialità spontanea e poco costosa viene ostacolata o vista in modo negativo. La “bellezza” e l'”autenticità” diventano strumenti per guadagnare dalle città, soprattutto grazie al turismo. Le città che ricevono il titolo UNESCO intensificano le campagne per il decoro. In questo modo, si crea una pressione per un “bello” standardizzato, che esclude tutto ciò che non rientra in questo modello.La classe sociale e la definizione di bello e brutto
La classe sociale determina ciò che viene considerato “bello” o “brutto”. Esiste una scala di importanza nell’accesso alla città decorosa: i turisti sono al primo posto, mentre i migranti poveri sono all’ultimo. Non è più sufficiente rispettare i diritti civili tradizionali. Viene richiesto un “comportamento adeguato”, che significa consumare in un certo modo. Chi non consuma secondo le regole, o chi è considerato marginale, viene allontanato o punito. Il decoro si rivela quindi come un modo di usare l’estetica per fare politica. Attraverso l’esaltazione di un passato idealizzato e di una “bellezza” superficiale, si cerca di mantenere le disuguaglianze esistenti e di sfruttare ogni aspetto della vita urbana per guadagno. Questa è una lotta silenziosa contro le persone più deboli della società.Ma il decoro urbano è davvero solo una fabbrica di disuguaglianze, o non c’è spazio per un dibattito più articolato sulle sue diverse sfaccettature?
Il capitolo presenta il decoro urbano come un’ideologia monolitica al servizio delle classi agiate, ma è plausibile che la questione sia più complessa. Si potrebbe indagare se esistono forme di decoro urbano che, pur nate da istanze borghesi, possano essere ripensate o riorientate per includere e beneficiare una gamma più ampia di cittadini. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire studi di sociologia urbana e teorie politiche sulla gestione degli spazi pubblici, magari partendo dalle opere di autori come Richard Sennett, per comprendere meglio le dinamiche e le ambivalenze del concetto di decoro.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]