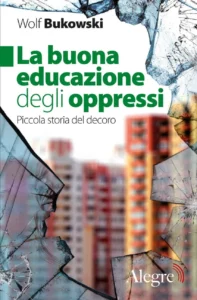1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La buona educazione degli oppressi” di Wolf Bukowski ti sbatte in faccia come il nostro mondo, soprattutto nelle città, usa il `decoro urbano` e la `sicurezza` per nascondere un sacco di ingiustizie. Partendo da esempi come la `tolleranza zero` a `New York` negli anni ’90 e arrivando all’Italia di oggi, il libro mostra come concetti tipo la `meritocrazia` vengano usati per dire che la `povertà` è colpa dei poveri, criminalizzando i `marginali` e i `senzacasa` invece di affrontare le vere cause sociali ed economiche. Non è la `criminalità` reale a guidare le politiche, ma la `paura` percepita, spesso manipolata per giustificare il `controllo sociale` e favorire la `gentrificazione` e gli interessi dei più ricchi. Il libro analizza come lo `spazio pubblico` venga privatizzato e come la crisi dei `servizi pubblici` non sia per mancanza di soldi, ma una scelta politica per non toccare la ricchezza. È un libro che ti fa capire come la `sicurezza urbana` sia diventata uno strumento per mantenere le `gerarchie urbane` e proteggere la proprietà, escludendo chi non rientra nell’idea di “cittadino perbene” e trasformando la città in un posto dove solo chi consuma ha diritto di esistere.Riassunto Breve
Il controllo sociale si basa sulla ridefinizione delle classi non per ricchezza ma per comportamento, presentando la povertà come colpa individuale e applicando la meritocrazia ai poveri. Il welfare diventa uno strumento per disciplinare, limitando l’accesso ai “meritevoli” e sanzionando comportamenti minimi, come si vede nelle “patenti a punti” per le case popolari o nel Daspo urbano che allontana i senzacasa. La teoria delle “finestre rotte” sposta l’attenzione dal crimine reale alla percezione di insicurezza, sostenendo che il disordine visibile favorisce il crimine. Questo porta a reprimere il “disordine” e la “gente disordinata” (mendicanti, vagabondi) per soddisfare la percezione della classe media, anche quando non corrisponde ai dati sulla criminalità. La paura dei cittadini viene manipolata per giustificare misure di controllo e ottenere consenso. La politica di tolleranza zero, o Broken Windows Policing, interviene contro piccole infrazioni per prevenire crimini maggiori, ma colpisce in modo mirato gruppi specifici come maschi neri o latini, malati di mente, poveri e marginali, usando leggi su “molestie” o “ostruzione”. Questa politica è inefficace contro i crimini gravi, la cui correlazione con il disordine scompare considerando fattori sociali come la povertà e la stabilità del quartiere. La povertà è un fattore determinante nei reati, ma la tolleranza zero criminalizza le vittime dell’impoverimento senza affrontare le cause profonde. La diminuzione dei reati a New York non è dovuta alla tolleranza zero, ma a fattori come cambiamenti demografici, occupazione e declino del consumo di crack. Nonostante ciò, la tolleranza zero riceve il merito e si diffonde globalmente, alimentando la paura e aumentando la domanda di armi. L’espressione “Quality of Life” cambia significato, passando dal benessere e servizi pubblici al decoro e sicurezza per le classi medie e i proprietari, descrivendo la presenza dei marginali come una “caduta”. L’attivismo civico per la cura degli spazi pubblici porta a richieste di esclusione e alla privatizzazione dello spazio pubblico, come nei Business Improvement Districts (BID). Mentre decoro e sicurezza avanzano, il welfare arretra drasticamente, con meno posti letto negli ospedali, servizi psichiatrici e alloggi popolari, e un aumento della popolazione carceraria. La crisi dei servizi pubblici è prodotta da un “frame” politico che afferma la mancanza di risorse, impedendo di prelevare ricchezza dai ricchi. Securitarismo e decoro diventano necessari nel ritiro dello stato dall’economia, aumentando l’intervento penale per rassicurare la classe media, creare business e criminalizzare l’organizzazione politica. In Italia, un calo dei reati negli anni Novanta si accompagna a un forte senso di insicurezza, spiegato in parte dall’immigrazione presentata come minaccia e dall’abbandono del riferimento alla classe sociale. L’esperienza sotto il neoliberismo sposta l’attenzione dai problemi sistemici ai fastidi quotidiani, rendendo il securitarismo fertile. La sicurezza e il decoro nascondono i meccanismi dell’ingiustizia, rendendo i poveri colpevoli. L’elezione diretta dei sindaci li orienta verso la repressione per consenso e valorizzazione capitalistica della città. La categoria del “degrado” equipara reati e “inciviltà”, alimentando la richiesta di sicurezza. Il rigore economico imposto da Maastricht e la delusione di Tangentopoli portano a una richiesta di rigore poliziesco verso i marginali, aprendo la strada al concetto di “decoro”. La paura per la criminalità è usata da politici e media per scopi propri, creando ansia e identificando colpevoli nei marginali e immigrati. Comitati cittadini per la sicurezza spostano l’attenzione su questi gruppi, mascherando interessi di classe. Anche la sinistra adotta il tema della sicurezza, promuovendo la repressione e legando la sicurezza al contrasto del “disordine” e alla valorizzazione economica urbana. Prevale la prevenzione situazionale, abbandonando il welfare e aumentando la sospettosità. La politica privilegia l’approccio repressivo e le richieste delle classi più ricche, accettando l’idea che non ci siano risorse per il welfare. Le preoccupazioni delle classi popolari e dei migranti vengono ignorate a favore di un’agenda securitaria che serve interessi economici. Negli anni Duemila, l’attenzione per la sicurezza aumenta, legata al controllo dell’immigrazione, favorendo la destra. I governi Berlusconi proteggono imputati ricchi e aumentano la repressione per piccoli reati e immigrazione. Si crea una distinzione tra gruppi “sacralizzati” (cittadini autoctoni, benestanti) e “non persone” (immigrati, poveri), basata sulla difesa della proprietà. Il decoro urbano protegge gli spazi e gli stili di vita dei consumatori, anche dal semplice fastidio dei poveri. Eventi come l’omicidio Reggiani portano a misure contro comunità specifiche, dichiarando lo “stato di emergenza” per gli insediamenti nomadi. Decreti legge danno ai sindaci poteri speciali per sicurezza e decoro, creando la categoria del “disordinato”: chi disturba l’ordine percepito per la sua condizione sociale. La paura sociale spinge a segnalare comportamenti prima tollerati. Anche la sinistra adotta il decoro e un legalismo staccato dalle questioni di classe, usato per reprimere le classi popolari e i poveri, ad esempio nelle proteste o contro i venditori ambulanti. La legalità e la fiscalità vengono usate contro l’economia informale, mentre il sistema favorisce le classi alte. L’applicazione rigida della legge contribuisce a una “progressiva fascistizzazione” della vita urbana. Le istituzioni controllano eventi popolari con regole di decoro e sicurezza, a volte collegando il “disordine” di strada alla “mafia”, distogliendo l’attenzione dalla criminalità economica. L’insistenza sulla legalità formale contro i margini soffoca la capacità della democrazia di evolversi. Decoro e sicurezza sono concetti centrali ma vaghi, usati in modo indefinito nelle leggi. Funzionano come “idee senza parole”, valori non discussi che distinguono il “civile” dal “barbaro”. Questo si vede nel trattamento dei graffiti, dove la decisione su cosa è “bello” o “brutto” decide chi ha diritto di esprimersi nello spazio pubblico, spesso legando il “bello” alla valorizzazione economica. Le panchine “antibivacco” sono un esempio di architettura ostile per escludere i marginali, giustificate con pretesti deboli. L’idea che sicurezza e decoro siano “né di destra né di sinistra” è falsa; le pratiche con cui si impongono (uso militari, restrizione diritti, trattamento marginali come problemi di ordine pubblico) sono storicamente legate a posizioni di destra. Queste azioni mantengono l’ordine sociale e il dominio della classe privilegiata, spesso in risposta al disordine causato dal capitalismo. L’obiettivo è imporre un ordine sociale che protegga i privilegi economici. Il decoro urbano si basa sulla percezione delle classi medio-alte e dei proprietari, legato alla speranza di aumento del valore immobiliare, un beneficio raro per i piccoli proprietari. Il decoro è un’ideologia che maschera interessi economici e causa danni, come l’aumento del costo della vita. La riqualificazione urbana giustificata dal “degrado” porta alla gentrificazione e a nuovi problemi come la “movida”, gestiti con ulteriori misure repressive. La socialità non legata al consumo viene stigmatizzata o repressa. Installazioni urbane e il concetto di “bello” sono usati per estrarre valore e definire chi può vivere la città. La valorizzazione del passato e i riconoscimenti UNESCO contribuiscono a creare un’immagine semplificata della città per il branding turistico, portando a campagne di decoro che colpiscono i marginali e le attività a basso reddito. La distinzione tra “bello” e “brutto” segue una linea di classe. Si crea una gerarchia di accesso alla città basata sul consumo: migranti poveri, cittadini poveri, cittadini che consumano, turisti. Il decoro e il bello diventano strumenti per la totale messa a reddito della vita urbana. Questa estetizzazione della politica, che mira a preservare le disuguaglianze, è una forma di conflitto in atto.Riassunto Lungo
1. Il Controllo Sociale tra Merito e Disordine Percepito
Un aspetto centrale per creare ordine e sicurezza nella società è cambiare il modo in cui si definiscono le classi sociali. Non si guarda più solo ai soldi, ma ai comportamenti e agli atteggiamenti delle persone. Autori come Edward Banfield e Charles Murray descrivono le classi più povere (lower-class, underclass) concentrandosi su come si comportano, parlando di mancanza di progetti per il futuro o di tendenza al degrado. In questa visione, la povertà non è una mancanza di risorse, ma una conseguenza di questi comportamenti.La Povertà come Mancanza di Merito
Questa prospettiva porta a considerare la povertà come una colpa. Chi è povero non si è “meritato” di essere ricco. Di conseguenza, il sistema di assistenza sociale (welfare) cambia. Diventa uno strumento per controllare le persone, dove l’aiuto viene dato solo a chi si dimostra “meritevole”. Questo riduce il numero di persone che ricevono sostegno. Si vedono esempi pratici di questo approccio, come i sistemi che danno punti per le case popolari e penalizzano anche piccoli comportamenti, rischiando di far perdere l’alloggio. Oppure il Daspo urbano, che allontana i senzatetto perché la loro presenza è vista come un fastidio per l’ordine pubblico, anche se non hanno commesso reati.Il Disordine che Fa Paura
In parallelo, la teoria delle “finestre rotte”, proposta da James Q. Wilson e George L. Kelling, sposta l’attenzione dalla lotta ai crimini veri e propri alla gestione di come le persone percepiscono la sicurezza. Questa teoria suggerisce che vedere segni di disordine (come una finestra rotta o sporcizia) crea una sensazione di insicurezza. Questa sensazione, a sua volta, si crede possa favorire il crimine. Per questo motivo, le risorse vengono usate per contrastare il “disordine” e le persone considerate “disordinate”, come mendicanti o vagabondi, invece di concentrarsi sui reati più gravi.Gestire la Percezione per il Consenso
L’obiettivo principale diventa soddisfare la percezione di sicurezza della classe media, anche quando i dati sulla criminalità non mostrano un aumento reale. La paura dei cittadini viene usata in modo strategico attraverso discorsi che creano allarme e mostrando spesso le forze dell’ordine in pubblico. Questo crea un clima di insicurezza diffusa che serve a giustificare misure di controllo più severe e a ottenere l’appoggio politico.Ma davvero la lotta al ‘disordine percepito’ rende le nostre città più sicure, o finisce solo per colpire i più deboli?
Il capitolo descrive come l’attenzione si sia spostata dalla criminalità reale alla gestione della percezione del disordine, suggerendo che affrontare piccoli segnali di degrado possa prevenire reati più gravi. Tuttavia, questa prospettiva solleva dubbi fondamentali sulla sua efficacia e sulle sue conseguenze sociali. Concentrarsi sul “disordine” e sulle persone considerate “disordinate” rischia di criminalizzare la povertà e la marginalità, senza affrontare le cause profonde della criminalità o dell’insicurezza. Per approfondire questa critica e comprendere le alternative, è utile esplorare la criminologia critica e la sociologia urbana. Autori come Loïc Wacquant offrono prospettive che mettono in discussione l’efficacia e la giustizia di approcci basati sulla gestione del disordine.2. Ordine e disordine sociale
La politica di tolleranza zero, nota anche come Broken Windows Policing, si basa sull’idea che intervenire contro le piccole infrazioni aiuti a prevenire crimini più gravi. Questa strategia viene applicata a New York City a partire dagli anni ’90, inizialmente nella metropolitana e poi estesa all’intera città. Lo scopo dichiarato di questa politica è contrastare il degrado urbano. Si interviene su comportamenti come graffiti, evasione dei biglietti dei trasporti pubblici e mendicità.L’applicazione mirata della politica
L’applicazione di questa politica porta all’arresto e alla detenzione, anche per brevi periodi, per una serie di comportamenti. Tra questi ci sono saltare i tornelli della metro, bere alcolici in pubblico, fare pipì nei parchi o attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali. È importante notare che questi provvedimenti non colpiscono in modo casuale. Sono diretti in modo mirato verso gruppi specifici della popolazione. I principali bersagli sono maschi neri o latini, persone con problemi di salute mentale, poveri e marginali. Le direttive interne della polizia di New York (NYPD) mostrano come usare leggi su “molestie” o “ostruzione” per sanzionare mendicanti o lavavetri. Anche il divieto di tenere materassi o scatole di cartone colpisce direttamente chi è senzatetto. Ci sono state iniziative legali per difendere i diritti dei poveri, come il diritto di chiedere l’elemosina, ma hanno ottenuto vittorie limitate. Le autorità aggirano le sentenze dettagliando ulteriormente le condotte proibite, rendendo più facile colpire le richieste di aiuto in luoghi frequentati. La persecuzione si manifesta anche in pratiche quotidiane, come le multe per attraversamento pedonale irregolare, che sono concentrate nei quartieri più poveri.Efficacia e cause sociali dei crimini
Questa politica non solo è percepita come ingiusta, ma si dimostra anche inefficace nel contrastare i crimini più gravi. I dati mostrano che la correlazione tra piccoli disordini e crimini seri come aggressione o furto con scasso scompare. Questa relazione non esiste quando si prendono in considerazione fattori sociali importanti. Tra questi fattori determinanti ci sono la povertà del quartiere, la stabilità residenziale degli abitanti e la composizione razziale. La povertà nei quartieri è un elemento chiave che contribuisce alla produzione di reati. La tolleranza zero si concentra sui segnali visibili del degrado sociale. In questo modo, criminalizza le persone che sono vittime dell’impoverimento e delle politiche economiche neoliberiste. Non si affrontano le cause profonde della criminalità.Se la teoria delle “finestre rotte” suggerisce che il degrado visibile di per sé favorisce il crimine, è sufficiente dimostrare che la povertà è un fattore determinante per dichiarare la politica inefficace?
Il capitolo, pur evidenziando correttamente il ruolo cruciale dei fattori socio-economici nella genesi del crimine, sembra liquidare troppo frettolosamente la premessa teorica alla base della tolleranza zero. La teoria originale non si limita a postulare una correlazione statistica, ma suggerisce che il disordine visibile crei un ambiente in cui i legami sociali si indeboliscono e il senso di controllo collettivo diminuisce, rendendo il quartiere più vulnerabile a crimini più gravi. Per comprendere appieno questa complessità e valutare criticamente l’efficacia (o inefficacia) della politica, è fondamentale approfondire le teorie criminologiche che legano ambiente, disordine e comportamento sociale. Approfondire il lavoro di autori come Kelling e Wilson, ma anche le successive ricerche empiriche e le critiche che hanno affinato o contestato il loro modello, è essenziale per andare oltre una lettura puramente correlazionale e considerare le dinamiche sociali e psicologiche in gioco.3. Decoro, Sicurezza e la Crisi dei Servizi
A New York, i reati sono diminuiti, ma non per via della politica di tolleranza zero iniziata nel 1994. Già prima di quell’anno, rapine e omicidi erano in calo. Questa riduzione sembra dovuta a cause diverse, come i cambiamenti nella popolazione e più posti di lavoro. Un fattore importante è stato anche il minor uso di crack, che ha ridotto gli scontri tra chi spacciava droga. Anche le azioni del sindaco Dinkins per limitare le armi hanno aiutato a diminuire gli omicidi con pistole o fucili. Nonostante i fatti, la tolleranza zero è vista come la causa del miglioramento, si è diffusa in tutto il mondo e ha aumentato la paura. Questa paura spinge le persone a comprare più armi, creando una vera insicurezza. Confrontando i dati, si vede che negli Stati Uniti ci sono molti più omicidi, specialmente con armi da fuoco, rispetto a paesi con regole più severe sulle armi. A New York, l’idea che punire i piccoli reati riduca quelli gravi non si è dimostrata vera; a volte, concentrarsi sul disordine peggiora le cose perché i criminali cambiano modo di agire.Il concetto di ‘Qualità della Vita’
L’espressione “Quality of Life”, usata per la tolleranza zero, una volta significava benessere e buoni servizi per tutti. Dopo il 1975, con meno soldi pubblici a disposizione, il suo senso è cambiato. Ha iniziato a significare soprattutto ordine e sicurezza, specialmente per chi aveva case o faceva parte della classe media. Gruppi di esperti hanno spinto questa nuova idea, dicendo che vedere persone povere, malate o che appartengono a minoranze nei luoghi pubblici era un segno che le cose andavano male rispetto a un tempo passato che sembrava migliore. Hanno iniziato a usare parole che mettevano paura per parlare di cose normali o di problemi sociali, facendoli sembrare pericoli.Ordine e controllo dello spazio pubblico
Il miglioramento, secondo questa visione, arriva quando i cittadini ricchi si occupano di curare i luoghi pubblici, come i parchi. Questo porta a chiedere di allontanare le persone ai margini della società, usando anche strutture fisiche che le rendano scomode (“architettura ostile”) e accordi tra enti pubblici e privati. Questo tipo di impegno da parte dei cittadini ricchi è un modo per rendere privati gli spazi che dovrebbero essere di tutti. Si lega anche ai Business Improvement Districts (BID), zone gestite da privati per mantenere l’ordine e il decoro per i negozi, dove purtroppo avvengono atti violenti contro chi non ha una casa.Il ritiro dello Stato sociale e l’aumento della sicurezza
Mentre si dà molta importanza all’ordine e alla sicurezza, i servizi pubblici diminuiscono fortemente. Ci sono meno posti letto negli ospedali pubblici, meno aiuto per chi ha problemi di salute mentale e meno case popolari. Allo stesso tempo, sempre più persone finiscono in prigione. Chi non ha una casa viene allontanato dalle zone centrali e spesso arrestato anche per piccole infrazioni. La mancanza di cura per i servizi pubblici, come i parchi, è un problema che si vede ancora oggi.Perché i servizi diminuiscono?
Questa situazione difficile per i servizi pubblici non dipende dal fatto che non ci siano abbastanza soldi in generale. Dipende piuttosto da come la politica presenta le cose, usando idee come quella di abbassare le tasse e dicendo che “non ci sono i soldi”. Questo modo di pensare, diffuso dai politici e dai mezzi di comunicazione, fa credere che non si possa cambiare come la società è organizzata e come la ricchezza è distribuita. In questo modo, diventa difficile prendere soldi da chi ne ha molti, cioè dai ricchi. In un sistema dove lo Stato si occupa meno dell’economia, puntare sulla sicurezza e sull’ordine diventa fondamentale. Serve a tranquillizzare la classe media, a creare nuove occasioni per fare affari e a punire chi, non avendo nulla, cerca di organizzarsi politicamente.È davvero così certo che decoro e sicurezza siano sempre e solo concetti vuoti usati per escludere, o esistono contesti in cui hanno significati diversi e funzioni non meramente repressive?
Il capitolo presenta una critica serrata e convincente sull’uso strumentale dei concetti di decoro e sicurezza per fini di esclusione sociale e mantenimento dei privilegi. Tuttavia, l’argomentazione potrebbe guadagnare in profondità esplorando se e come questi termini possano assumere significati o funzioni differenti in altri contesti normativi o sociali, al di là della specifica applicazione polemizzata. Per una comprensione più completa, sarebbe utile approfondire la storia delle politiche urbane, studiare la sociologia dello spazio pubblico e analizzare le diverse interpretazioni legali di “decoro” e “sicurezza” in vari ordinamenti. Autori come Foucault, o studiosi di sociologia urbana e diritto pubblico, possono offrire prospettive più ampie su come questi concetti si sono evoluti e sono stati applicati, permettendo di valutare se l’analisi del capitolo, pur acuta, non rischi di generalizzare eccessivamente.8. Decoro, Valore Immobiliare e Gerarchie Urbane
Il concetto di decoro urbano si basa sulla percezione della qualità della vita da parte delle classi medio-alte e dei proprietari di immobili. Il consenso verso le iniziative che promuovono il decoro, spesso accompagnate da misure repressive e di controllo degli spazi pubblici, è strettamente legato alla speranza che queste azioni portino a un aumento del valore immobiliare. Tuttavia, questo beneficio si realizza raramente per i piccoli proprietari, mostrando come il decoro funzioni spesso come un’ideologia. Questa ideologia serve a nascondere i veri interessi economici che spingono tali politiche e finisce per causare danni concreti, come l’aumento del costo della vita, proprio a coloro che non traggono alcun profitto da queste trasformazioni.Decoro come giustificazione del cambiamento urbano
Un esempio chiaro di questo meccanismo si manifesta nei processi di riqualificazione delle aree urbane. La narrazione pubblica tende a concentrarsi sul presunto “degrado” per giustificare interventi profondi che, di fatto, innescano processi di gentrificazione. Una volta che queste aree vengono trasformate e “riqualificate”, diventano spesso centri nevralgici della “movida”, generando una serie di nuovi problemi per i residenti storici, tra cui rumore eccessivo e disturbo della quiete. La liberalizzazione del commercio ha giocato un ruolo significativo in questo scenario, contribuendo a creare zone della città dedicate quasi esclusivamente al divertimento e al consumo, concentrando così gli impatti negativi in spazi limitati. La risposta delle istituzioni a questi nuovi disagi si traduce frequentemente in ulteriori misure repressive o in accordi con le attività commerciali, senza però affrontare le cause strutturali che hanno generato la situazione.Controllo sociale e l’uso politico del “bello”
Parallelamente, le forme di socialità che non sono legate a un elevato livello di consumo, come il semplice incontrarsi in una piazza pubblica, vengono spesso stigmatizzate o attivamente represse. Installazioni urbane specifiche, come i container posizionati in Piazza Verdi a Bologna, agiscono di fatto come strumenti di controllo mirati a scoraggiare la presenza di studenti e di persone con basso potere d’acquisto in determinati spazi. Il concetto stesso di “bello” viene strategicamente utilizzato per estrarre valore dagli spazi urbani e persino dai movimenti culturali che vi si sviluppano. Questa “bellezza” non è un dato oggettivo, ma una costruzione profondamente politica ed economica che serve a definire chi ha il diritto di accedere e vivere pienamente la città, escludendo di fatto tutto ciò che non rientra nei canoni estetici funzionali agli interessi del mercato e alla valorizzazione immobiliare.Turismo, patrimonio e distinzioni di classe
La valorizzazione del passato e l’ottenimento di riconoscimenti internazionali, come l’inclusione nelle liste dei siti UNESCO, contribuiscono in modo significativo a creare un’immagine della città che appare semplificata e priva di conflitti interni. Questa immagine è estremamente utile per le strategie di branding orientate al turismo di massa. Le città che godono dello status UNESCO si trovano spesso in prima linea nelle campagne per il decoro urbano, le quali tendono a colpire in modo sproporzionato i marginali urbani e le attività commerciali a basso reddito. Esempi di questa dinamica sono visibili nelle normative “anti-suk” implementate in città come Roma, che limitano o vietano determinate forme di commercio di strada. La distinzione tra ciò che è considerato “bello” e ciò che viene etichettato come “brutto” segue una linea di classe chiara e definita, riflettendo le disuguaglianze socio-economiche esistenti.La gerarchia di accesso alla città basata sul consumo
Questa logica porta alla creazione di una vera e propria gerarchia nell’accesso e nell’uso della città, basata sulla capacità di consumo degli individui. Al livello più basso di questa gerarchia si trovano i migranti poveri, che spesso non hanno accesso neanche ai servizi essenziali. Seguono i cittadini poveri che, pur possedendo diritti civili formali, vengono di fatto esclusi dagli spazi urbani vitali per il loro sostentamento e la loro socialità non legata al consumo. Sopra di loro si posizionano i cittadini che partecipano attivamente al consumo, il cui comportamento negli spazi pubblici è regolato e accettato solo se conforme alle logiche del consumo adeguato; il loro voto è attivamente ricercato dalle amministrazioni promettendo benefici derivanti dal turismo. Al vertice di questa piramide si colloca il turista, considerato il consumatore ideale per eccellenza, un non-cittadino la cui immagine e le cui aspettative vengono utilizzate per giustificare politiche urbane che favoriscono l’estrazione massima di valore dagli spazi. Il decoro e la promozione di un’estetica specifica diventano, in questo contesto, strumenti potenti per la totale messa a reddito della vita urbana in ogni sua sfaccettatura. Questa estetizzazione della politica, che mira a preservare e rafforzare le disuguaglianze sociali ed economiche, rappresenta una forma concreta e pervasiva di conflitto che si manifesta quotidianamente nello spazio della città.Ma il “decoro” è davvero solo un’ideologia che maschera interessi economici e danneggia tutti tranne i grandi speculatori?
Il capitolo dipinge un quadro molto netto, in cui il decoro urbano è quasi esclusivamente uno strumento di oppressione economica e sociale. Per cogliere appieno la complessità del fenomeno, sarebbe utile esplorare studi che analizzano le motivazioni dietro le politiche urbane anche da prospettive diverse, considerando ad esempio il ruolo della percezione del rischio, le dinamiche di coesione sociale o le diverse concezioni di “qualità” dello spazio pubblico che possono esistere al di fuori della mera logica del profitto. Approfondire autori che si occupano di sociologia urbana o di studi sul paesaggio e l’estetica potrebbe offrire chiavi di lettura alternative.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]