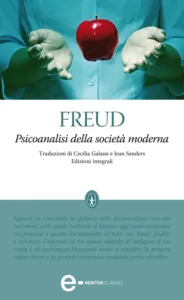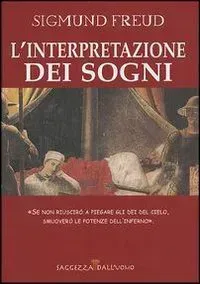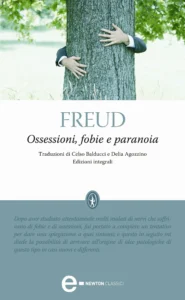1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“La battuta umoristica e la sua relazione con l’inconscio” di Sigmund Freud ti porta nella Vienna di fine Ottocento, un’epoca super moralista dove parlare di certi argomenti era tabù. È qui che Sigmund Freud, il pioniere della psicoanalisi, inizia a rivoluzionare la comprensione della mente umana. Invece di usare l’ipnosi, scopre il potere dell’ascolto e delle libere associazioni, aprendo la porta sull’inconscio, quella parte nascosta di noi piena di pensieri e desideri rimossi. Ma Freud non si ferma qui. Con la sua analisi geniale, si mette a studiare le battute umoristiche, quelle che ci fanno ridere o pensare. Scopre che dietro una battuta non c’è solo un gioco di parole, ma un meccanismo psichico profondo, legato a come funziona il nostro inconscio. Le battute, specialmente quelle “tendenziose”, ci danno piacere perché ci permettono di aggirare le nostre inibizioni e la repressione sociale, risparmiando energia psichica. È affascinante vedere come le tecniche usate nelle battute, come la condensazione e lo spostamento, siano le stesse che troviamo nel lavoro onirico, nei sogni. Freud esplora come il piacere della battuta derivi da questo “risparmio” e come sia diverso dal piacere del comico o dello humor, ma sempre legato a un ritorno a stati mentali più semplici, quasi infantili. Questo libro è un viaggio incredibile nella mente, che ti fa guardare l’umorismo non solo come qualcosa di divertente, ma come una chiave per capire noi stessi e il nostro inconscio.Riassunto Breve
Lo studio della battuta umoristica si lega all’esplorazione della mente inconscia, un deposito di pensieri e ricordi non accessibili direttamente. Questo approccio nasce osservando come i disturbi psicologici possano essere compresi ascoltando il paziente, portando alla scoperta di processi mentali nascosti e del ruolo della sessualità, temi allora trascurati. Si identificano tecniche specifiche nella creazione delle battute, come errori di ragionamento, l’unificazione di idee o parole, e la rappresentazione indiretta tramite allusioni o l’uso del contrario. Queste tecniche mostrano una forte somiglianza con i meccanismi che operano durante il sonno per formare i sogni, come la condensazione e lo spostamento, suggerendo un legame tra i processi psichici che generano sogni e battute. Le battute si distinguono in innocue, il cui piacere deriva dalla tecnica stessa, e tendenziose, subordinate a scopi come l’aggressione o l’evocazione sessuale. Le battute tendenziose generano un piacere più intenso perché permettono di superare inibizioni sociali o interiori. La battuta tendenziosa coinvolge chi la dice, l’oggetto e l’ascoltatore; il piacere si manifesta principalmente nell’ascoltatore. Questo piacere deriva dal soddisfacimento di impulsi repressi e dal risparmio di energia psichica che altrimenti sarebbe usata per mantenere le inibizioni. La risata dell’ascoltatore è vista come lo scarico di questa energia liberata. L’autore della battuta non ride della propria creazione perché l’energia è stata usata per superare la propria inibizione; cerca conferma e partecipa al piacere attraverso la reazione dell’ascoltatore. La battuta richiede un pubblico che condivida le inibizioni superate per completare il processo e manifestare il piacere. La formazione della battuta implica un pensiero preconscio che viene elaborato temporaneamente a livello inconscio, simile all’attività mentale infantile che trae piacere dal gioco di parole e dall’assurdo tramite la condensazione, spiegando la brevità tipica della battuta. A differenza del sogno, che è asociale e può deformare molto per eludere la censura, la battuta è sociale, richiede comprensibilità e limita la deformazione, mirando al piacere recuperando il piacere infantile del gioco verbale. Il sogno serve principalmente a evitare dispiacere. La capacità di creare battute è legata alla facilità di accesso all’inconscio, facilitata da stati d’animo o tendenze forti. Il piacere nella comicità, nella battuta e nello Humor deriva da un risparmio di energia psichica, riportando a uno stato euforico infantile. La comicità nasce dal risparmio di energia nel comprendere l’altro o da situazioni che rendono qualcuno “inferiore”. L’ingenuità è comica perché si risparmia l’energia inibitoria che l’osservatore possiede. La battuta risparmia energia inibitoria superando la censura. Lo Humor risparmia energia emotiva evitando affetti spiacevoli. L’unificazione negli indovinelli è diversa dalla battuta; l’indovinello nasconde, la battuta rivela. Le battute assurde mostrano il “senso nell’assurdo”; il piacere umoristico ha un nucleo di piacere di gioco e un guscio di piacere di liberazione. Le “stupidaggini apparentemente spiritose” creano l’illusione di senso nell’assurdo, liberando piacere per un attimo. Lo spostamento è una tecnica umoristica, come cambiare argomento per evitare una domanda; funziona meglio se velato. Personaggi comici come Falstaff generano piacere perché si risparmia l’indignazione, trasformandola in piacere comico, legato alla sicurezza di un Io che accetta i propri difetti. Don Chisciotte produce piacere perturbando l’aspettativa comica iniziale.Riassunto Lungo
1. Le tecniche della battuta e i suoi scopi nascosti
Nella Vienna di fine Ottocento, un’epoca segnata da un forte moralismo e dalla repressione, si fa strada un nuovo modo di affrontare i disturbi della mente. Questo approccio rivoluzionario si basa sull’ascolto attento del paziente. Sigmund Freud, dopo aver studiato le malattie del sistema nervoso e l’uso dell’ipnosi, mette a punto il metodo delle libere associazioni, superando i limiti che aveva riscontrato nella suggestione ipnotica. Usando questa nuova tecnica, scopre l’esistenza dell’inconscio, una parte nascosta della mente dove vengono messi da parte pensieri e ricordi scomodi. Questo percorso porta anche a riconoscere quanto sia importante la sessualità nello sviluppo dei disturbi psicologici, un tema che all’epoca la medicina tendeva a ignorare completamente.Come funzionano le battute: le tecniche
Analizzando il meccanismo delle battute umoristiche, si possono individuare diverse tecniche che le rendono divertenti. Una di queste riguarda gli errori di ragionamento: possono essere “sofistici”, cioè basati su una logica che sembra corretta ma nasconde un inganno, oppure “automatici”, quando l’abitudine prende il sopravvento sull’intenzione di chi parla. Un’altra tecnica è l’unificazione, che crea collegamenti inaspettati e sorprendenti tra idee o parole apparentemente lontane. C’è poi la rappresentazione indiretta, che include l’allusione: si sostituisce un concetto con qualcosa che gli è collegato per il suono, per una piccola modifica o perché viene omesso un pezzo. Un’altra forma di rappresentazione indiretta è usare il contrario, affermando l’opposto di ciò che si vuole realmente intendere. Anche la similitudine può essere una tecnica, anche se il suo effetto comico è più sottile e difficile da definire. Queste tecniche usate nelle battute mostrano una forte somiglianza con i meccanismi che lavorano nella nostra mente quando sogniamo, come la condensazione (unire più idee in una sola) e lo spostamento (trasferire un sentimento da un’idea a un’altra). Questa somiglianza fa pensare che ci sia un legame profondo tra i processi mentali che creano i sogni e quelli che danno vita alle battute.Perché facciamo battute: gli scopi
Le battute si distinguono anche per lo scopo che hanno. Esistono battute innocue, il cui piacere deriva soprattutto dalla bravura tecnica con cui sono costruite. Altre battute sono invece “tendenziose”, cioè servono a raggiungere obiettivi specifici. Questi intenti possono essere l’aggressione, dando vita a battute ostili, o la “denudazione”, tipica delle battute oscene. Le battute tendenziose provocano un piacere più forte e intenso. Questo suggerisce che l’intento che sta dietro, spesso legato al superamento di divieti o inibizioni sociali, contribuisca in modo significativo all’effetto comico. La battuta oscena, in particolare, può essere vista come un tentativo di seduzione o un’aggressione fatta a parole. Il piacere che ne deriva nasce dall’idea di provocare eccitazione o imbarazzo nell’altra persona, e affonda le sue radici nell’impulso infantile di guardare (voyeurismo).Ma queste affascinanti connessioni tra battute, sogni e impulsi infantili hanno un reale fondamento scientifico al di fuori della teoria psicoanalitica?
Il capitolo presenta una visione affascinante, ma è fondamentale ricordare che si basa sui principi della psicoanalisi, una teoria che, pur storicamente importantissima, ha suscitato e continua a suscitare dibattiti accesi riguardo alla sua validità empirica e alla sua applicabilità universale. Per approfondire e formarsi un’opinione più completa, è utile esplorare le diverse branche della psicologia, in particolare la psicologia cognitiva e sociale, che offrono spiegazioni alternative sui meccanismi e le funzioni dell’umorismo. È altresì cruciale confrontarsi con le critiche metodologiche rivolte alla psicoanalisi e considerare i contributi di autori che hanno studiato la mente e il comportamento umano da prospettive differenti.2. La Battuta: Aggirare Ostacoli Psichici per il Piacere Condiviso
La battuta, specialmente quella con un doppio senso o un intento nascosto, coinvolge sempre tre figure: la persona che la dice, la persona o la cosa di cui si parla, e l’ascoltatore. Lo scopo principale di una battuta è quello di creare piacere, e questo piacere si manifesta in modo più forte nella terza persona, cioè in chi ascolta. La battuta riesce a raggiungere questo obiettivo permettendo di superare blocchi o impedimenti interni, come desideri o pensieri che normalmente teniamo a freno, magari legati a temi sessuali o aggressivi. Aggirando queste barriere, la battuta attinge a fonti di piacere che altrimenti rimarrebbero inaccessibili. Superare questi blocchi genera piacere perché si risparmia l’energia mentale che di solito usiamo per mantenerli attivi.Il Piacere e il Ruolo di chi Ascolta e di chi Parla Il piacere che si prova con una battuta “tendenziosa” deriva quindi dal soddisfare un desiderio che di solito è bloccato e dal risparmiare l’energia che servirebbe per tenerlo bloccato. Chi ascolta sente questo piacere in modo più chiaro, spesso manifestandolo con la risata. La risata può essere vista come lo sfogo dell’energia mentale che si libera nel momento in cui il blocco interno, che l’ascoltatore era pronto a mantenere, non serve più grazie alla battuta. Chi crea la battuta, invece, pur provando soddisfazione, non ride della propria creazione. Questo accade perché l’energia mentale usata per inventare la battuta e superare il proprio blocco non è più disponibile per sfogarsi nella risata. Per questo motivo, chi fa la battuta la comunica ad altri: cerca una conferma che sia riuscita e vuole partecipare al piacere che l’ascoltatore prova. La battuta funziona pienamente e il piacere si manifesta del tutto solo se chi ascolta ha gli stessi blocchi interni che la battuta è riuscita a superare.Davvero il complesso fenomeno della battuta e del piacere che ne deriva può essere ridotto a un semplice meccanismo di risparmio energetico psichico?
Il capitolo propone una visione specifica del piacere legato alla battuta, focalizzata sul superamento di blocchi interni e sul conseguente risparmio di energia mentale. Tuttavia, questa prospettiva, che affonda le sue radici in una specifica scuola di pensiero psicologico (come quella di S. Freud), potrebbe non cogliere la totalità e la complessità del fenomeno umoristico. Esistono altre teorie sul perché ridiamo e troviamo piacere nell’umorismo, che considerano aspetti cognitivi (come l’incongruenza), sociali (come la coesione di gruppo o l’espressione di superiorità) o linguistici. Per avere un quadro più completo, sarebbe utile esplorare le diverse discipline che studiano l’umorismo, dalla psicologia cognitiva alla sociologia, dalla linguistica alla filosofia, confrontando il modello qui presentato con approcci alternativi.3. Le Radici Inconsce dell’Umorismo
Le battute si formano usando tecniche come il concentrare più idee in una (condensazione), lo spostare l’attenzione da un punto all’altro (spostamento) e il rappresentare qualcosa in modo indiretto. Questi modi di lavorare della mente sono molto simili a quello che succede mentre sogniamo. Quando sogniamo, la mente trasforma i pensieri nascosti del sogno in quello che poi ricordiamo attraverso processi come la condensazione, lo spostamento e il tornare indietro a un modo di pensare più legato alle immagini. Questo lavoro del sogno è influenzato dai desideri che non sappiamo di avere e da una specie di censura interna.Come la mente crea le battute
Si pensa che creare una battuta funzioni in modo simile al sogno: un pensiero che è quasi cosciente viene per un po’ elaborato dalla parte più nascosta della mente, quella inconscia. Il risultato di questo lavoro inconscio poi riemerge nella coscienza. Questa elaborazione inconscia è vista come simile al modo in cui pensano i bambini, specialmente per come riescono a trovare piacere nei giochi di parole e nelle cose assurde, proprio grazie a quel meccanismo di condensazione. Il fatto che le battute siano spesso molto brevi è un effetto diretto di questa condensazione, proprio come succede nei sogni.Battute e sogni: somiglianze e differenze
Nonostante queste tecniche simili, le battute e i sogni hanno funzioni diverse nella nostra vita. Il sogno è qualcosa di privato, che riguarda solo la persona che sogna, e serve a soddisfare desideri o semplicemente a farci continuare a dormire. Il sogno può deformare molto la realtà per evitare la censura, e per questo a volte non lo capiamo affatto. La battuta, invece, è qualcosa che facciamo con gli altri, ha bisogno di qualcuno che ascolti e deve essere capita. Questa necessità di essere compresa limita quanto si può deformare la realtà, anche se usa comunque processi che vengono dall’inconscio. Lo scopo principale della battuta è dare piacere, spesso recuperando quel piacere che provavamo da bambini con i giochi di parole o le situazioni strane. Il sogno, invece, serve più che altro a evitare sensazioni spiacevoli. La capacità di inventare battute dipende da quanto facilmente i pensieri riescono ad accedere a quel livello inconscio. Questo accesso è più facile se siamo di buon umore o se abbiamo una certa predisposizione personale. Inoltre, se ci sono idee o sentimenti forti che spingono da sotto, specialmente nelle battute che vogliono dire qualcosa di più (le battute tendenziose), questo dà una spinta notevole al processo inconscio che le crea.Ma su quali basi teoriche poggiano le affermazioni sul piacere umoristico, così nettamente distinto e legato a presunte repressioni?
Il capitolo espone una visione del piacere umoristico che distingue nettamente tra gioco di parole e gioco di pensieri, collegando quest’ultimo a meccanismi di liberazione da blocchi o inibizioni. Questa distinzione e l’enfasi sul ruolo della repressione richiamano specifiche teorie psicologiche del passato, che tuttavia non vengono esplicitate né contestualizzate. Per comprendere meglio la complessità del piacere umoristico e valutare la solidità di tali affermazioni, sarebbe utile approfondire le diverse teorie psicologiche e cognitive sull’umorismo. Si possono esplorare le opere di autori come Sigmund Freud, Henri Bergson, Arthur Koestler, o studi più recenti nell’ambito della psicologia cognitiva e della linguistica.6. Spostamenti e Personaggi Comici
La tecnica umoristica usa lo spostamento per creare battute divertenti. Funziona quando si risponde a una domanda cambiando argomento. Spesso si fa per evitare la domanda stessa o per anticipare quella successiva. Pensiamo all’esempio di chi, chiesto dell’età, risponde “A Brünn”. Qui l’attenzione viene spostata sul luogo di nascita. L’umorismo funziona meglio quando questo spostamento non è troppo evidente. Richiede un piccolo sforzo per essere colto. Se lo spostamento è troppo chiaro, l’intenzione umoristica si capisce subito e l’effetto è minore. Esistono anche le “domande scherzose”, come chiedere cosa sia un cannibale che ha mangiato i genitori e rispondere “Un orfano”. Anche queste usano lo spostamento. Però non sono vere battute nello stesso senso, perché la risposta spiritosa non è qualcosa che si può intuire come in altre tecniche umoristiche basate sullo spostamento.L’umorismo nei personaggi
L’effetto comico non deriva solo dalle tecniche usate nelle battute. Può nascere anche dai personaggi stessi. Consideriamo Sir John Falstaff. Genera piacere perché non proviamo il disprezzo o l’indignazione che forse meriterebbe per le sue azioni. Questo accade per diversi motivi. Si percepisce che lui stesso si giudica con arguzia. La sua condizione fisica rende difficile giudicarlo severamente. Le sue azioni sono spesso innocue e colpiscono persone sciocche. Si arriva quasi a provare una forma di compassione per lui. L’indignazione che riusciamo a non provare si trasforma in piacere comico. L’umorismo di Falstaff nasce dalla sicurezza di un Io che non si lascia abbattere dai propri difetti o dalle critiche.Il caso di Don Chisciotte
Don Chisciotte offre un tipo di piacere che può sembrare umoristico, ma funziona in modo diverso. All’inizio può apparire come un personaggio puramente comico e ridicolo. Col tempo, però, diventa meno una figura da cui ridere e più un simbolo di idealismo e saggezza. Il piacere che proviamo con lui non deriva dal non provare un’emozione negativa, come l’indignazione per Falstaff. Nasce invece dal fatto che la nostra aspettativa iniziale di un piacere solo comico viene in qualche modo perturbata o cambiata. Questi esempi di personaggi mostrano come l’umorismo possa manifestarsi in forme più complesse. Non si basano solo su battute semplici o tecniche immediate.Ma l’umorismo di un personaggio complesso come Falstaff si riduce davvero solo alla soppressione dell’indignazione?
Il capitolo propone una spiegazione interessante per l’umorismo di Falstaff, legandola al non provare un’emozione negativa. Tuttavia, ridurre la comicità di un personaggio letterario a un singolo meccanismo psicologico potrebbe trascurare altre sfaccettature cruciali. Per approfondire, sarebbe utile esplorare diverse teorie psicologiche sull’umorismo e considerare analisi critiche più ampie dei personaggi letterari. Discipline come la Psicologia e la Critica Letteraria offrono strumenti per comprendere meglio questi fenomeni. Autori come Bergson o Freud hanno proposto visioni differenti sulla natura del comico, mentre numerosi critici hanno analizzato in profondità figure come Falstaff e Don Chisciotte.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]