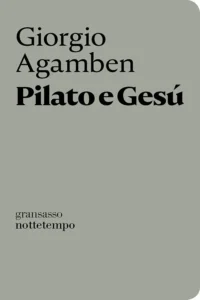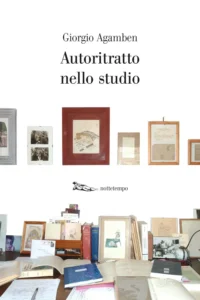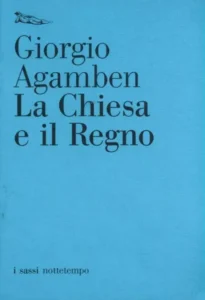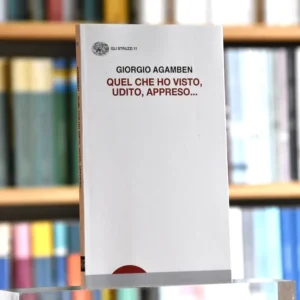Contenuti del libro
Informazioni
“Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il gesto” di Giorgio Agamben è un libro che ti prende e ti fa riflettere su concetti che sembrano scontati ma non lo sono affatto. Agamben scava a fondo nelle origini di idee come l’azione, la colpa e la responsabilità, mostrandoci come sono nate e cambiate nel tempo, attraversando il diritto antico, la filosofia greca, la teologia cristiana e persino il pensiero indiano sul karman. Il punto di partenza è spesso la legge e la sua sanzione, che non punisce la colpa, ma in un certo senso la crea, definendo cosa è sbagliato. Poi si passa a capire come abbiamo iniziato a pensare che la responsabilità dipenda dalla nostra volontà, un’idea che non c’era nell’antica Grecia ma è diventata centrale col cristianesimo, portando a dibattiti infiniti sul libero arbitrio. Il libro esplora le difficoltà nel legare l’azione a un soggetto preciso e a un fine, mettendo in crisi l’idea che facciamo sempre qualcosa “perché vogliamo” o “per uno scopo”. Alla fine, Agamben ci propone un’altra prospettiva: quella del gesto, un’attività che non ha un fine esterno, un “mezzo puro” che sfugge alla logica dell’imputazione e apre uno spazio diverso, quasi di “inoperosità”, che sfida il nostro modo solito di pensare l’azione e la colpa. È un viaggio intellettuale che smonta le nostre certezze su chi siamo quando agiamo e perché ci sentiamo in colpa.Riassunto Breve
La legge stabilisce una connessione diretta tra un’azione e una conseguenza, la pena. Non è la pena a seguire la colpa, ma la sanzione stessa a definire l’atto come colpevole. Non esiste colpa senza pena. Un atto è illecito solo perché la legge lo prevede come condizione per applicare una sanzione. La sanzione non solo crea l’illecito, ma dà autorità alla legge. Nelle leggi antiche, la colpa come stato interiore non appare; l’imputabilità è generica e legata alla conseguenza subita. Il concetto di azione sanzionata (*crimen* o *karman*) è fondamentale, legando l’azione a conseguenze. Nella cultura greca, la responsabilità si basa sulla capacità oggettiva di agire, non sulla volontà soggettiva, e il male deriva dall’ignoranza. La tragedia greca mostra il conflitto tra azione e destino. La ricerca di un fondamento stabile per la responsabilità porta, soprattutto nella teologia cristiana, al concetto di volontà. Partendo dall’analisi della potenza di agire, si introduce la necessità di un principio che decida il passaggio all’atto, identificato nella volontà. Il termine “libero arbitrio” viene usato per indicare la capacità di decidere le proprie azioni e spiegare l’origine del male e la responsabilità del peccato. C’è uno spostamento dal predominio del “posso” (potenza) a quello del “voglio” (volontà). La volontà diventa il principio di imputabilità, orientata al bene o al male, e si afferma la sua sovranità sulla potenza. La volontà vuole se stessa per potersi imputare l’azione. Anche la creazione divina è vista come un atto libero di volontà, non necessità naturale. Questo si riflette sull’uomo, che agisce per volontà libera. Il primato della volontà sulla potenza si realizza separando e limitando la potenza per renderla governabile dalla volontà. La politica e l’etica occidentali si basano sul primato dell’azione e della volontà, strettamente legati all’idea di fine. L’azione umana è definita come orientata verso un bene supremo, creando una struttura mezzo-fine dove l’azione è il mezzo per raggiungere lo scopo. Questo modello è rafforzato dalla teologia cristiana e dal diritto, dove il concetto di “persona” come fine in sé serve a creare un soggetto imputabile per le azioni. Il dispositivo del fine crea il soggetto come centro di imputazione. Un’alternativa a questo paradigma è il “gesto”, un’attività che si distingue dal fare e dall’agire orientati a un fine. Il gesto è un “mezzo puro” che si emancipa dalla relazione con uno scopo, disattivando le opere legate a un fine ed esponendo l’azione in sé. Questa “inoperosità” è uno spazio che si apre quando i legami di fini, mezzi, imputazione e colpa vengono sospesi, rendendo difficile fissare il gesto come azione imputabile a un soggetto definito.Riassunto Lungo
1. La Legge e la Creazione della Colpa
I concetti di causa e colpa sono fondamentali per capire come un evento o un’azione entri nel mondo del diritto. Entrambi i termini non hanno un’origine etimologica certa. La “causa”, nel linguaggio legale, indica ciò che dà il via a una controversia, la questione al centro di un processo, la res de qua agitur. Con il tempo, questo significato si è allargato fino a comprendere l’idea di “motivo” o “ragione”, ma mantiene forte il suo legame originale con l’ambito giuridico, come ciò che rende le persone coinvolte nella legge. La “colpa”, invece, all’inizio si riferiva all’idea generale che un fatto potesse essere attribuito a qualcuno, che ne subiva le conseguenze, la noxa. Solo più tardi ha assunto un significato tecnico, definendo la negligenza e distinguendola dal dolo, cioè l’intenzione di fare del male. Questo concetto tecnico di colpa non indica una responsabilità totale, ma piuttosto una sua limitazione, legata a quanto il soggetto ha partecipato all’azione. L’evoluzione storica ha spostato l’attenzione sulla colpa non più come semplice azione, ma come qualcosa che riguarda la volontà e l’interiorità della persona.La Colpa nelle Leggi Antiche
Nelle leggi più antiche, l’idea di colpa come stato d’animo o intenzione non esisteva. La legge creava un legame diretto e automatico tra un’azione specifica e una conseguenza, ovvero la pena. Non era la pena a derivare dalla colpa, ma era la sanzione stessa a stabilire che un certo atto era da considerarsi colpevole. In altre parole, il principio che conosciamo oggi “non c’è pena senza colpa” era rovesciato: si diceva piuttosto “non c’è colpa senza pena”. Questo significa che la sanzione, la punizione, era l’elemento centrale e determinante della legge stessa. Era la minaccia o l’applicazione della pena a conferire significato e autorità al divieto o al comando legale.La Visione di Hans Kelsen
Secondo il pensiero di Hans Kelsen, un atto viene considerato illecito, cioè contrario alla legge, solo perché è previsto come condizione necessaria per l’applicazione di una sanzione. Per Kelsen, non esistono azioni che siano sbagliate “di per sé”, intrinsecamente malvagie (mala in se), ma esistono solo azioni proibite dalla legge (mala prohibita). Il crimine, quindi, non è visto come una trasgressione che avviene al di fuori del sistema legale, ma è una condizione che esiste all’interno del diritto stesso, definita e determinata dalla sanzione che gli viene associata. La sanzione, in questa prospettiva, non si limita a creare l’atto illecito, ma afferma la propria necessità, giustificando l’uso della violenza da parte dello Stato, purché questa violenza sia legittima, cioè prevista dalla legge.Il Potere della Sanzione
La “santità” o l’inviolabilità della legge deriva proprio dalla sanzione (sanctio) che ha il compito di proteggerla da qualsiasi offesa o violazione. È la sanzione che rende la legge forte e rispettata, segnando un confine chiaro tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Definendo quali comportamenti attivano una conseguenza negativa, la sanzione identifica e classifica tali azioni come “colpe”. In questo modo, la legge, attraverso il meccanismo della sanzione, non solo stabilisce regole, ma acquisisce la sua autorità e la sua concretezza nel mondo reale.Se, come suggerisce il capitolo riprendendo Kelsen, un atto è illecito solo perché sanzionato, cosa distingue la “colpa” legale da un mero comportamento sanzionato per ragioni di pura opportunità o controllo sociale?
Il capitolo offre una prospettiva che, pur evidenziando il ruolo cruciale della sanzione nella definizione dell’illecito, rischia di apparire riduttiva se non integrata da una riflessione sul “perché” sociale, etico o morale che spinge un ordinamento a sanzionare determinati comportamenti. Concentrarsi esclusivamente sul meccanismo formale della sanzione può lasciare irrisolta la questione della legittimità sostanziale della norma. Per approfondire questo aspetto e comprendere le basi non solo formali ma anche giustificative del diritto e della pena, è consigliabile esplorare la filosofia del diritto, le teorie della giustizia e confrontarsi con autori che hanno analizzato il rapporto tra diritto, morale e potere, come H.L.A. Hart.2. L’azione sanzionata e l’ombra del carattere
Nel diritto romano, il concetto di crimen si riferisce all’azione in quanto sanzionata, ovvero imputabile e legata a precise conseguenze. Similmente, nel pensiero indiano, il karman indica l’azione con le sue ripercussioni. Questa idea di azione sanzionata è cruciale per il diritto e l’etica, sia nel mondo occidentale che in India. In India, in particolare, il karman è strettamente legato alla trasmigrazione delle anime, e si crede che le azioni compiute con intenzione portino frutti, positivi o negativi, in questa vita o in quelle future, influenzando il destino dell’individuo attraverso le reincarnazioni.La prospettiva greca classica
Nella cultura greca classica, la comprensione della responsabilità è diversa dalla nostra. Non esiste una nozione di volontà come la intendiamo oggi. La responsabilità non dipende dall’intenzione soggettiva, ma dalla capacità concreta di compiere un’azione, chiamata hekousion. L’etica greca tende a essere intellettualistica: si pensa che il male derivi dall’ignoranza, non da una volontà malvagia. L’uomo agisce sempre mirando a ciò che ritiene essere un bene. Questa prospettiva si manifesta nella tragedia greca, dove l’azione sanzionata rivela una profonda scissione. L’eroe tragico appare contemporaneamente libero nelle sue scelte e vincolato da necessità divine. La sua azione sembra voluta e non scelta allo stesso tempo, mostrando un conflitto irrisolvibile tra l’idea di responsabilità personale e il peso del destino.
Le risposte della filosofia greca: Platone e Aristotele
I filosofi greci hanno cercato di superare questa tensione. Platone, ad esempio, si oppone alla visione tragica e cerca il fondamento dell’etica non tanto nell’azione, ma nella conoscenza. Per lui, l’agire correttamente deriva dalla comprensione del bene. Aristotele, pur criticando l’approccio di Socrate e sottolineando l’importanza dell’azione imputabile (adikema), introduce il concetto di proairesis, che possiamo tradurre come ‘scelta’. Con la proairesis, Aristotele cerca di collegare più strettamente l’azione all’agente che la compie. Tuttavia, anche Aristotele riconosce che l’etica riguarda non solo le singole azioni, ma anche un certo modo di essere o una disposizione (hodi echontas). Questo dimostra che il rapporto profondo tra l’azione compiuta e l’essere della persona che agisce resta un punto complesso e problematico.
La riflessione moderna: Kant e Schopenhauer
In epoca moderna, pensatori come Kant e Schopenhauer hanno proposto un approccio diverso. Essi hanno cercato di fondare la responsabilità non tanto sulle singole azioni concrete che compiamo, ma piuttosto su qualcosa di più profondo: il carattere intelligibile o l’essere stesso della persona. Secondo questa prospettiva, l’uomo è considerato responsabile per chi è, non solo per ciò che fa. Questo spostamento dell’attenzione, tuttavia, non risolve completamente la questione. Anzi, in un certo senso, trasforma l’idea di libertà in qualcosa di misterioso e l’essere in una sorta di destino predeterminato. La fondamentale tensione tra l’azione compiuta e il carattere o l’essere dell’individuo continua a persistere, anche quando si tende a sostituire la nozione di azione con quella più ampia di evento.
Ma è davvero così semplice liquidare la responsabilità basata sul carattere come un mero “mistero” o “destino”?
Il capitolo, nel presentare la prospettiva moderna, sembra liquidare con eccessiva rapidità le complesse posizioni di pensatori come Kant e Schopenhauer, definendo la libertà un “mistero” e l’essere un “destino”. Questa visione, pur cogliendo una tensione, rischia di non rendere giustizia ai sofisticati tentativi di questi filosofi di conciliare responsabilità morale e natura del carattere o della volontà. Per comprendere meglio questo dibattito, è fondamentale approfondire la filosofia morale e la metafisica, studiando autori come Immanuel Kant e Arthur Schopenhauer, ma anche esplorando i dibattiti contemporanei sul libero arbitrio.3. La Volontà: Nuovo Centro dell’Agire Umano
La teologia cristiana pone la ricerca di un fondamento stabile per la libertà e la responsabilità delle azioni umane al centro del concetto di volontà. Questa idea non nasce isolata, ma si sviluppa grazie all’elaborazione dei Padri della Chiesa, che attingono a spunti già presenti nella filosofia classica e in correnti di pensiero come la gnosi. In alcune forme di gnosi, come quella valentiniana, la volontà appare addirittura come la prima manifestazione della divinità stessa, segno della sua importanza concettuale fin dalle origini.Dalla Potenza all’Atto: Il Contributo Classico
Aristotele analizza l’agire umano attraverso la relazione tra potenza e atto, ovvero la capacità di fare qualcosa e la sua effettiva realizzazione. Per poter attribuire un’azione a una persona, è necessario che quella persona abbia la possibilità sia di fare sia di non fare quella determinata cosa. A differenza della potenza naturale, che si manifesta in modo necessario (come il fuoco che brucia), la potenza logica o razionale è capace di produrre effetti opposti. Questa dualità nella capacità di agire richiede un principio che decida quale delle possibilità si realizzerà concretamente. Aristotele individua questo principio nel desiderio o nella scelta, affermando che il pensiero si trasforma in azione “quando vuole”, introducendo così un elemento che ha una sorta di sovranità sulla semplice capacità di fare.Platone, in un suo dialogo, esplora le complicazioni che sorgono quando si cerca di fare della volontà l’unico criterio per valutare un’azione. Mostra come, spingendo questa idea all’estremo, si potrebbe arrivare alla conclusione paradossale che chi compie un’azione malvagia volontariamente sia in qualche modo “migliore” di chi la compie involontariamente. Sebbene Aristotele critichi questa specifica tesi platonica, anche la sua analisi, che richiede un principio che guidi la potenza, sottolinea la necessità di un elemento decisivo nell’agire umano, aprendo la strada a riflessioni successive sulla natura di questo principio.Il Libero Arbitrio nella Pensiero Cristiano
Il termine “libero arbitrio” (liberum arbitrium) viene adottato dai pensatori cristiani per tradurre espressioni greche che si riferiscono alla capacità di una persona di decidere le proprie azioni. L’attenzione si sposta in modo significativo sull’aspetto dell’imputabilità, sia morale che giuridica, delle azioni compiute. Già a partire dal III secolo, questo concetto è utilizzato per affrontare questioni fondamentali come l’origine del male nel mondo e la responsabilità individuale per il peccato commesso. Mentre filosofi come Alessandro di Afrodisia si concentravano sull’ambiguità intrinseca della potenza (la capacità di fare cose opposte), i teologi si dedicano a identificare nella volontà il principio ultimo che rende un’azione attribuibile a un soggetto e, di conseguenza, meritevole di lode o biasimo.L’analisi dei verbi modali come “posso”, “voglio”, e “devo” rivela la loro importanza cruciale, pur essendo privi di significato se considerati isolatamente. Un cambiamento fondamentale nel modo di concepire l’uomo e il suo agire si verifica nel passaggio dall’antichità alla modernità, segnato dal predominio progressivo del “voglio” (la volontà) rispetto al “posso” (la potenza). Se l’uomo antico tende a concepire la sua azione principalmente nella dimensione della sua capacità e possibilità, l’uomo nel pensiero cristiano è definito sempre più come un essere che è caratterizzato dalla sua capacità di volere e decidere.La Volontà di Fronte al Peccato: Agostino e Pelagio
I trattati dedicati al libero arbitrio da figure centrali come Agostino e Anselmo evidenziano le complessità nel voler fondare la responsabilità del peccato esclusivamente sulla volontà, cercando al contempo di superare l’idea di ambiguità legata alla potenza. Questi autori, pur negando che il libero arbitrio consista nella semplice capacità di scegliere tra peccare e non peccare, lo utilizzano poi per giustificare perché gli esseri umani sono puniti per le loro trasgressioni. La volontà assume così il ruolo di uno strumento concettuale fondamentale per garantire l’imputabilità delle azioni, essendo intrinsecamente orientata verso il bene o, per sua scelta, verso il male. Emerge l’idea che la volontà debba in qualche modo volere sé stessa (“voglio volere”) per poter essere considerata il principio da cui scaturisce l’azione e a cui questa può essere imputata.La celebre polemica tra Agostino e Pelagio mette in luce in modo netto la necessità, per Agostino, di affermare con forza la sovranità della volontà rispetto alla mera potenza. Pelagio sosteneva che l’uomo possedesse una potenza naturale innata che lo rendeva capace di non peccare con le proprie forze. Agostino, al contrario, insiste con decisione sul fatto che sia il peccato sia la giustizia dipendono in ultima analisi dalla volontà dell’individuo, e, dopo la caduta, dalla grazia divina. L’azione umana, anche prima dell’introduzione del peccato nel mondo, viene dunque interpretata come mossa e determinata dalla volontà.Il primato della volontà sulla potenza si afferma pienamente attraverso un processo che separa la potenza dalla sua realizzazione nell’atto. Questo processo “denaturalizza” la potenza, sottraendola alla necessità intrinseca delle leggi naturali, e la limita in modo che possa essere governata e orientata dalla volontà. L’esperienza descritta dall’apostolo Paolo, quella scissione interiore tra il volere il bene e il compiere il male, viene interpretata da Agostino non come una semplice divisione nella capacità di agire, ma come una vera e propria “malattia” della volontà stessa, una profonda divisione interna causata dagli effetti del peccato originale. Ciò che per i filosofi greci era una questione legata alla dualità della potenza, per i pensatori cristiani diventa un conflitto che si manifesta all’interno della volontà. La volontà interviene attivamente per trasformare un “non posso” che potrebbe apparire come non imputabile in un “non voglio” che invece è chiaramente peccaminoso e colpevole.La Volontà nella Creazione e nella Teologia Post-Agostiniana
Un altro ambito cruciale in cui il concetto di volontà assume un ruolo centrale è quello della creazione divina. L’idea cristiana di una creazione che avviene per arbitrium voluntatis, cioè per una libera decisione della volontà divina, distingue radicalmente l’azione creatrice di Dio dalla necessità che caratterizza i processi naturali. La creazione è vista come un atto libero, non dovuto, e gratuito della volontà di Dio. Questa “denaturalizzazione” della potenza divina, che non agisce per una necessità intrinseca ma per una scelta libera, si riflette direttamente sull’antropologia, sul modo di concepire l’uomo. L’essere umano, creato a immagine di Dio, agisce non per una determinazione naturale, ma per una volontà libera, legando così l’azione umana alla contingenza, alla possibilità di essere diversa, e inserendola pienamente nella dimensione della storia. Pensatori successivi, come Duns Scoto, portano questa idea alle sue estreme conseguenze, definendo la volontà come una potenza che è stata completamente denaturalizzata, rendendola il principio ultimo della libertà umana e della contingenza del mondo creato.Il problema dell’onnipotenza divina, cioè del potere illimitato di Dio, porta a un’importante distinzione teologica tra potentia absoluta e potentia ordinata. La potentia absoluta si riferisce al potere incondizionato di Dio, alla sua capacità di fare qualsiasi cosa non implichi una contraddizione logica. La potentia ordinata, invece, si riferisce al potere di Dio esercitato secondo l’ordine che Egli stesso ha stabilito liberamente con la sua volontà. Questa distinzione sottolinea ancora una volta come sia la volontà divina a porre un limite alla potenza, stabilendo un ordine stabile e governabile. In modo analogo, per poter governare la propria potenza e le proprie capacità, anche l’uomo deve possedere la facoltà di volere.Una Prospettiva Alternativa: La Volontà in Dio
Una visione differente emerge in un testo mistico noto come la Theologia deutsch. Secondo questa prospettiva, la vera volontà nell’uomo non è qualcosa di suo proprio, ma appartiene in realtà a Dio stesso. Il peccato fondamentale consiste nell’appropriarsi di questa volontà divina, considerandola come una “eigen will”, una volontà propria e separata da quella divina. Questa volontà propria, separata da Dio, è vista come la condizione stessa dell’inferno interiore. Francesco d’Assisi sembra fare riferimento a un’idea simile quando afferma che chi si appropria della propria volontà, separandola da quella di Dio, mangia dall’albero della conoscenza del bene e del male, scegliendo l’autonomia che porta alla separazione e al peccato.[/membership]Ma questo primato della volontà, così come viene delineato nel capitolo, è ancora sostenibile di fronte alle scoperte della psicologia e delle neuroscienze contemporanee?
Il capitolo traccia un percorso affascinante che porta il concetto di volontà dal pensiero classico alla teologia cristiana, evidenziandone il ruolo cruciale per l’imputabilità e la libertà. Tuttavia, la trattazione si concentra quasi esclusivamente su una prospettiva storico-filosofica e teologica, trascurando completamente le sfide e le riformulazioni che il concetto di volontà e di agire umano hanno subito nel contesto scientifico e filosofico moderno e contemporaneo. Le discipline che studiano il cervello e il comportamento umano offrono visioni spesso molto diverse e complesse dei processi decisionali, che mettono in discussione l’idea di una volontà unitaria e sovrana come principio ultimo dell’azione. Per comprendere appieno la rilevanza (o l’obsolescenza) di questa concezione, sarebbe fondamentale confrontarsi con la filosofia della mente, la psicologia cognitiva e le neuroscienze, esplorando autori che si occupano del problema del libero arbitrio da queste prospettive.4. Il Gesto oltre il Fine
La politica e l’etica occidentali si trovano spesso in difficoltà a causa dell’importanza data al concetto di azione e volontà, strettamente legate all’idea di un fine da raggiungere. Il termine “azione” (actio, praxis) ha origini che risalgono più al diritto e alla religione che alla filosofia.L’idea di fine nella filosofia antica
Aristotele distingue due tipi di attività: la poiesis, che è la produzione di qualcosa con uno scopo esterno all’attività stessa, e la praxis, che è un’azione il cui scopo è interno all’azione stessa (energeia). L’attività umana (ergon) è definita dalla praxis, orientata verso il bene più alto, la felicità, intesa come fine ultimo. Questo imposta una relazione di mezzo-fine, dove l’azione è vista come lo strumento per arrivare al bene. In questa visione, l’etica si concentra sull’agire e non sull’essere, e l’essere umano è come in debito verso il suo scopo finale.Platone propone un punto di vista diverso. Per lui, il bene è un principio fondamentale che non dipende da ipotesi e può essere raggiunto con la conoscenza, non principalmente attraverso l’azione. Platone suggerisce di considerare la vita umana come un “gioco” divino, un’attività che ha valore in sé. Questo supera la logica del mezzo-fine; per esempio, la guerra non è vista come uno strumento per ottenere la pace, ma l’attività stessa del “gioco” (in questo contesto, la vita o anche la guerra) è considerata un’attività seria e significativa.Gli stoici, riflettendo sul concetto di scopo, fanno una distinzione tra lo skopos, che è uno scopo esterno all’azione, e il telos, che è il fine interno, l’azione stessa compiuta in modo virtuoso. Gli epicurei, invece, non riconoscono una finalità intrinseca nelle cose naturali o nelle azioni.Il primato del fine nel pensiero cristiano e moderno
La teologia cristiana, in particolare con Tommaso d’Aquino, rafforza il modello in cui ogni cosa tende a un fine, con Dio come fine ultimo di tutto. Anche attività che sembrano non avere uno scopo immediato, come il gioco o i gesti fatti senza intenzione, vengono ricondotte a una finalità, seppur indiretta o legata a un ordine superiore.Immanuel Kant cerca di superare la divisione tra mezzo e fine introducendo l’idea che l’uomo sia un “fine in sé” e anche un “fine ultimo”. Tuttavia, il concetto di “fine in sé” presenta delle difficoltà e appare contraddittorio. Per giustificare la moralità e mantenere una struttura basata sulla gerarchia mezzo-fine, Kant reintroduce l’idea di un fine ultimo, collegandolo a un legislatore morale supremo.Il fine nel diritto e il soggetto imputabile
Nel campo del diritto, la “legge del fine” proposta da Jhering sostiene che la volontà e l’azione sono sempre orientate verso uno scopo. Il concetto di “persona” nel diritto, vista come un “fine in sé”, serve a creare un soggetto a cui possono essere attribuite le azioni e le relative responsabilità. Questo rafforza il legame tra volontà, azione e l’attribuzione di colpa o merito.La struttura basata sul fine crea l’individuo come punto di riferimento per l’attribuzione delle azioni. Il pensiero buddhista offre una prospettiva diversa, separando il karman (l’azione e il suo risultato) dall’Atman (l’agente, l’io). Questa separazione mette in discussione il legame automatico tra chi agisce e l’azione compiuta, suggerendo che l’idea di un agente fisso e definito sia un’illusione.Il gesto come alternativa alla logica del fine
Un modo diverso di pensare l’attività umana, alternativo al modello basato sulla finalità, è il concetto di “gesto” (gerere). Il gesto può essere visto come un terzo tipo di attività, distinto dal semplice fare (facere) o dall’agire orientato a uno scopo (agere). Il gesto implica un sostenere, un trattenere o un mostrare l’azione stessa, senza necessariamente puntare a un risultato esterno.Il gesto è un “mezzo puro”, una “medialità pura”, perché si libera dalla necessità di essere in relazione con un fine. È un tipo di attività che “disattiva” le opere che sono legate a uno scopo, rendendole disponibili per usi nuovi e inaspettati. Proprio come la danza o il mimo mettono in mostra la pura capacità del corpo di muoversi e esprimersi senza produrre un oggetto o raggiungere un obiettivo esterno, il gesto rende “inoperosa” la finalità, mostrando l’azione per quella che è in sé.Questa “inoperosità” crea uno spazio nuovo, che si apre quando i legami che uniscono fini, mezzi, attribuzione di responsabilità e colpa vengono sospesi. Pensare in termini di “gesto” o “mezzi puri” suggerisce una politica che rende difficile fissare il gesto come un’azione definita e attribuibile in modo univoco a un soggetto specifico.Ma una politica che “disattiva” i fini e rende difficile l’attribuzione, come può affrontare le sfide concrete del vivere insieme?
Il capitolo propone il “gesto” come alternativa alla logica del fine, suggerendo una politica che sfugge all’attribuzione rigida. Tuttavia, non chiarisce come un’azione politica possa essere efficace o persino comprensibile se svincolata da scopi definiti e dalla responsabilità di chi la compie. Per esplorare questa tensione, sarebbe utile approfondire la filosofia politica contemporanea, in particolare gli autori che si confrontano con i limiti del pensiero teleologico e con le teorie dell’azione collettiva. Autori come Agamben o pensatori che criticano o sviluppano le sue idee potrebbero offrire spunti. Anche studi sulla sociologia dell’azione e sulla teoria delle istituzioni potrebbero fornire il contesto necessario per valutare la praticabilità di un tale approccio.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]