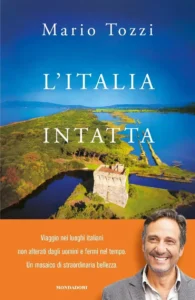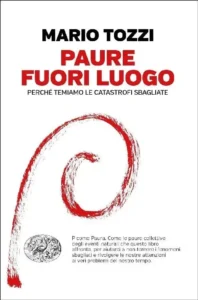Contenuti del libro
Informazioni
“Italia segreta viaggio nel sottosuolo da Torino a Palermo” di Mario Tozzi ti porta in un’esplorazione incredibile sotto i nostri piedi, rivelando che l’Italia non è solo quella che vediamo in superficie. Questo libro scende nel profondo del “sottosuolo italiano”, un mondo nascosto fatto di strati geologici millenari e dell’incessante lavoro dell’uomo. È un viaggio affascinante attraverso le “città sotterranee”, dalle “cave di tufo” di Napoli che hanno dato forma alla città, agli “acquedotti antichi” e alle “catacombe” di Roma che raccontano storie di ingegneria e fede. Scoprirai i “bottini di Siena”, capolavori medievali per l’acqua, i “qanat di Palermo”, eredità araba per sfuggire al caldo, e il “patrimonio archeologico” nascosto in luoghi come la Sardegna con le sue “Domus de Janas” e miniere. Tozzi ci mostra come questo mondo sotterraneo, tra “grotte naturali” e strutture artificiali, non sia solo storia, ma influenzi ancora la nostra vita, dalla stabilità degli edifici ai problemi di inquinamento, ma offra anche risorse e segreti inaspettati. È un invito a guardare oltre l’ovvio e a capire il legame profondo tra la geologia del territorio e le civiltà che vi sono sorte, un vero “viaggio nel sottosuolo” che cambia la prospettiva sull’Italia.Riassunto Breve
Sotto le città e le strade italiane esiste uno strato complesso formato da processi geologici e dall’attività umana nel corso di migliaia di anni. Questo sottosuolo è la base fisica delle aree urbane e contiene parte della loro storia. È fatto di rocce, terreni e acque, modificato da scavi, costruzioni ed eventi naturali. Gran parte di questo mondo sotterraneo è poco conosciuto e può causare problemi come l’apertura di voragini nelle strade. A Napoli, il sottosuolo è stato molto usato, soprattutto per estrarre il Tufo Giallo Napoletano, materiale da costruzione principale. Questo ha creato una vasta rete di cave, cisterne e cunicoli, usati per sepolture, raccolta d’acqua e rifugi. L’estrazione del tufo, a volte fatta in modo non sicuro, ha indebolito la città, insieme a terremoti e problemi alle reti idriche. Il sottosuolo campano è stato anche usato per smaltire rifiuti tossici, causando inquinamento. Nonostante i problemi, il sottosuolo di Napoli e altre città conserva un patrimonio storico e archeologico. A Roma, sotto la città c’è un mondo nascosto di opere antiche. Esistono laghi sotterranei e sistemi idrici importanti come l’acquedotto Vergine e la Cloaca Maxima, usati per l’acqua e le fognature. La città è costruita con materiali estratti dal sottosuolo come tufo e travertino. Colline artificiali come il Monte dei Cocci mostrano l’economia antica. Il sottosuolo romano ospitava anche luoghi per la morte, come catacombe e colombari, e per la religione, come i mitrei, oltre a luoghi di detenzione. La stabilità delle costruzioni a Roma dipende dal terreno sottostante; il Colosseo ha problemi dove c’era un laghetto, mentre la Colonna Traiana è più stabile sul tufo. La città ha tracce preistoriche con fossili di grandi animali. A Torino, il sottosuolo ha gallerie usate per difesa e depositi di ghiaccio. Bologna ha nascosto il torrente Àposa in canali sotterranei, usati per energia e trasporto, poi come fognatura e infine interrati. Siena usa ancora una rete idrica sotterranea medievale chiamata “bottini”. Orvieto sorge su una rupe di tufo instabile e ha cavità etrusche e opere come il Pozzo di San Patrizio. Il sottosuolo delle città è un archivio di storia naturale e umana. Gli Etruschi erano abili a scavare necropoli nel tufo e a gestire l’acqua. In Sardegna, le Domus de Janas sono tombe scavate nella roccia antiche, e la collina di Tuvixeddu a Cagliari ha una grande necropoli fenicio-punica. Il sottosuolo sardo ha una lunga storia mineraria. A Matera, la civiltà rupestre ha sfruttato grotte naturali e scavato cisterne per l’acqua, creando abitazioni complesse. Gravina di Puglia ha canyon carsici e cavità artificiali usate come cantine e sepolture. A Trinitapoli, antichi ipogei erano usati per riti e sepolture. Le Murge mostrano come le civiltà rupestri si sono adattate alla scarsità d’acqua. Venezia ha poco sottosuolo a parte la cripta di San Marco. Trieste ha problemi di acqua nonostante il carsismo e ha cavità artificiali come la “Kleine Berlin”. Treviso ha una rete sotterranea medievale per difesa. Il carsismo crea grotte e fiumi sotterranei. Milano, costruita sull’acqua, ha sviluppato navigli poi coperti; il suo sottosuolo di sabbie e ghiaie non ha permesso una vasta città ipogea, ma conserva tracce dei canali e rifugi. L’Appennino ha insediamenti rupestri e città come Fermo e Amelia conservano cisterne romane. L’Aquila ha cunicoli sotto il castello. Narni ha storia archeologica sotterranea. Genova ha una vasta rete sotterranea. Le grotte naturali offrono benefici per la salute, come nella speleoterapia. L’aria nelle grotte umide è pulita e utile per problemi respiratori. A Palermo, gli arabi hanno creato i *qanat*, canali sotterranei per l’acqua, e le “camere dello scirocco” per rinfrescarsi. Il sottosuolo conserva storie e misteri, come passaggi segreti. L’uso del sottosuolo per rifugi, estrazione di materiali e gestione dell’acqua mostra un legame profondo tra la geologia e lo sviluppo delle civiltà. L’Italia si basa su strati geologici che hanno influenzato architettura e vita quotidiana. Preservare questi ambienti è importante per ricordare il passato in cui l’uomo viveva a contatto con la terra.Riassunto Lungo
1. Le fondamenta nascoste d’Italia
Sotto le città e le strade italiane si trova uno strato complesso formato da processi geologici e dall’attività umana nel corso dei millenni. Questo sottosuolo costituisce la base fisica delle aree urbane e una parte della loro storia culturale. È un insieme di rocce, terreni e acque, modificato da scavi, costruzioni e eventi naturali come eruzioni e terremoti. Gran parte di questo mondo sotterraneo non è conosciuto, generando sia fascino che timore. Le cavità nascoste sono state immaginate come luoghi di leggende e rifugi per attività illecite. Lo stato del sottosuolo contribuisce a problemi come l’apertura di voragini nelle strade, un fenomeno che può causare danni e incidenti. Nonostante la conoscenza geologica di alcune aree, il sottosuolo italiano presenta ancora molto da esplorare e comprendere per affrontare queste sfide.
Napoli: Un caso esemplare di interazione con il sottosuolo
A Napoli, ad esempio, il sottosuolo è stato intensamente lavorato per secoli. Il Tufo Giallo Napoletano, formatosi da ceneri vulcaniche dei Campi Flegrei, è stato il principale materiale da costruzione. Questo ha portato alla creazione di un’estesa rete di cave, cisterne e cunicoli. Queste cavità sono state usate per vari scopi nel corso della storia della città. Hanno servito come luoghi di sepoltura, come nel Cimitero delle Fontanelle, dove si praticava la “sculatura” dei corpi e il culto delle “anime pezzentelle”. Sono state fondamentali per la raccolta e distribuzione dell’acqua attraverso sistemi come l’acquedotto Bolla. Durante i conflitti, hanno offerto rifugi antiaerei alla popolazione.
Conseguenze dell’uso e dell’incuria
L’estrazione del tufo, inizialmente attenta, è diventata nel tempo una “cavatura a rapina”, specialmente sotto gli edifici, indebolendo la struttura della città. La stabilità del sottosuolo è compromessa anche dalla sismicità tipica dell’area, dall’incuria delle reti idriche e fognarie che causano infiltrazioni, e dallo scarico di rifiuti che altera la composizione del terreno. La città ha perso la memoria del suo profondo rapporto con il sottosuolo e del suo fiume storico, il Sebeto, ora completamente interrato e dimenticato dalla maggior parte degli abitanti. Più recentemente, il sottosuolo campano è stato tristemente noto per lo smaltimento illegale di rifiuti tossici, causando grave inquinamento ambientale e rischi per la salute pubblica.
Un patrimonio da riscoprire e proteggere
Nonostante i problemi e l’inquinamento, il sottosuolo di Napoli e di altre città italiane offre anche un patrimonio storico e archeologico di inestimabile valore. I continui ritrovamenti e la possibilità di visitare antiche strutture sotterranee testimoniano la ricchezza di questo mondo nascosto. La valorizzazione di questo patrimonio richiede un impegno serio e coordinato. Sono necessari studi geologici approfonditi per comprendere la struttura e la stabilità del sottosuolo, censimenti precisi delle cavità esistenti per mapparne la posizione e lo stato, e il ripristino delle infrastrutture idriche e fognarie per eliminare le cause di degrado. È fondamentale evitare soluzioni dannose e irreversibili, come i riempimenti in cemento delle cavità, che distruggono il patrimonio e possono creare nuovi problemi.
Considerato il millenario e vitale rapporto tra Napoli e il suo sottosuolo, come è stato possibile che la città abbia “perso la memoria” di questa relazione fondamentale, arrivando a livelli di incuria e degrado così critici?
Il capitolo descrive efficacemente l’importanza storica del sottosuolo napoletano e le gravi conseguenze della sua incuria, ma non esplora a fondo le dinamiche socio-culturali ed economiche che hanno portato a questa “perdita di memoria” e al distacco da un patrimonio così cruciale. Per comprendere meglio questo paradosso, è utile approfondire la storia urbana, la sociologia delle città e l’antropologia urbana, esaminando come i processi di modernizzazione, crescita demografica e cambiamento sociale influenzino la percezione e la gestione dello spazio urbano, sia in superficie che nel sottosuolo. Approfondire autori che hanno studiato la trasformazione delle città italiane e il rapporto tra comunità e ambiente costruito può offrire chiavi di lettura fondamentali.2. Il Mondo Sotterraneo di Roma
Sotto la città di Roma si estende un vasto mondo nascosto, fatto di opere antiche e strutture dimenticate. Questo sottosuolo rivela aspetti fondamentali della vita romana, dall’ingegneria all’organizzazione sociale e religiosa.La gestione dell’acqua
La gestione dell’acqua era centrale per la vita romana. Esistono laghi sotterranei, come quello sotto l’ospedale Forlanini, che faceva parte di cavità usate come magazzini e rifugi. L’acquedotto Vergine, ancora attivo dopo duemila anni, dimostra l’abilità romana nel captare e distribuire risorse idriche, alimentando oggi la fontana di Trevi. Grandi cisterne, come le Sette Sale sul Colle Oppio, potevano immagazzinare milioni di litri d’acqua per le necessità della città.Il sistema fognario
Il sistema fognario, dominato dalla Cloaca Maxima, rappresenta un’opera idraulica monumentale. Fu iniziata per bonificare le aree paludose del centro di Roma e, nonostante le condizioni igieniche dell’epoca, con latrine pubbliche e scarichi diretti nel Tevere, funziona ancora in parte. Resti organici trovati in collettori sigillati sotto il Colosseo offrono uno spaccato delle abitudini alimentari e di svago degli spettatori che frequentavano l’anfiteatro.Materiali e struttura urbana
La città stessa è costruita con materiali estratti dal sottosuolo. Tufo, travertino e lava vulcanica venivano usati per realizzare strade importanti come la via Appia e per i caratteristici sanpietrini che pavimentano ancora oggi molte vie. L’uso dei materiali estratti dal sottosuolo si lega anche alla gestione dei rifiuti e al riuso. Colline artificiali, come il Monte dei Cocci, si sono formate dall’accumulo di frammenti di anfore da trasporto, testimoniando l’economia dell’epoca e la pratica del riciclo.Luoghi di morte, culto e detenzione
Il sottosuolo romano non era solo infrastruttura, ma ospitava anche luoghi legati alla morte, alla religione e alla giustizia. Le catacombe erano vasti sepolcreti usati dai primi cristiani per seppellire i loro defunti. I colombari, invece, erano sepolcreti pagani dove venivano conservate urne cinerarie in ambienti spesso decorati. Culti misterici, come quello del dio Mitra, si svolgevano in templi sotterranei chiamati mitrei, ambienti che ricreavano simbolicamente il cosmo. Anche luoghi di detenzione, come il carcere Tullianum, si trovavano sotto terra ed erano usati per brevi periodi prima dell’esecuzione dei condannati. Queste strutture sotterranee, dalle opere idrauliche ai luoghi di culto e sepoltura, mostrano una dimensione complessa e spesso invisibile che è parte integrante della storia e della struttura fisica di Roma.Il capitolo descrive un “mondo sotterraneo”, ma spiega perché Roma ne ha sviluppato uno così complesso, o si limita a elencare ciò che vi si trova?
Il capitolo elenca una serie affascinante di strutture sotterranee, dalla gestione idrica ai luoghi di culto e sepoltura. Tuttavia, la semplice giustapposizione di questi elementi non chiarisce appieno come essi si integrassero nella vita romana quotidiana o perché abbiano assunto tale importanza e complessità. Per comprendere meglio il significato profondo di questo “mondo”, sarebbe utile esplorare la relazione tra lo spazio visibile della città e il suo sottosuolo, considerando aspetti funzionali, simbolici e sociali. Approfondire la storia urbana, l’archeologia del paesaggio e la storia delle religioni può offrire chiavi di lettura più complete. Autori come Andrea Carandini o Filippo Coarelli hanno esplorato il rapporto tra la topografia di Roma e la sua storia sociale e religiosa, offrendo spunti su come il sottosuolo non fosse solo uno spazio fisico, ma anche un elemento attivo nella costruzione dell’identità urbana e religiosa.3. Sotto la Città: Strati di Storia e Natura
Il sottosuolo delle città italiane nasconde una realtà complessa, fatta di diversi strati. Qui si mescolano la geologia del terreno e le tracce lasciate dall’uomo nel corso del tempo. Questa dimensione nascosta racconta storie antiche e mostra come la natura influenzi ancora la vita urbana.La città sotterranea di Roma
A Roma, per esempio, la stabilità degli edifici dipende molto dal terreno sottostante. Il Colosseo ha subito danni perché costruito sopra un antico laghetto. La Colonna Antonina, invece, ha risentito di più dei terremoti rispetto alla Colonna Traiana, che poggia su una base solida di tufo. La città ha conosciuto terremoti potenti, come quello del 1349. Anche il Vulcano Laziale, pur non essendo più attivo come un tempo, mostra ancora segni di vita con gas e variazioni di temperatura nelle acque. Sotto Roma si trovano anche resti molto antichi, come fossili di grandi animali preistorici, ad esempio l’Elephas antiquus trovato a Casal de’ Pazzi e La Polledrara. La parte sotterranea di Roma è enorme e in gran parte sconosciuta. Ci sono monumenti imperiali sepolti da centinaia di anni di accumuli. Questo spazio nascosto è stato usato anche per incontri importanti.Il sottosuolo di Torino
Anche a Torino, il sottosuolo ha avuto ruoli importanti nella storia. Ci sono gallerie scavate per la difesa, come quelle rese famose da Pietro Micca. C’erano anche depositi di ghiaccio usati nel passato. Esistono leggende su una Torino magica e su presunte grotte segrete legate all’alchimia, ma gli scavi moderni non le hanno confermate. Un esempio attuale è la comunità di Damanhur, che ha costruito parte della sua vita e delle sue attività sotto terra, seguendo un modello che cerca di rispettare l’ambiente e vivere in modo ecosostenibile.Bologna e il fiume nascosto
Bologna ha un rapporto particolare con l’acqua sotterranea. Il torrente Àposa è stato nascosto nel sottosuolo, trasformando la città. Quella che un tempo era una città con canali visibili è diventata una città con corsi d’acqua sepolti. Questi canali sotterranei sono stati usati nel tempo per produrre energia, per il trasporto, poi come fognatura e infine sono stati interrati. Oggi, alcune parti del torrente Àposa sotto la città possono essere visitate, rivelando questa dimensione nascosta.I “bottini” di Siena
Siena dipende da una notevole rete idrica sotterranea costruita nel Medioevo, chiamata i “bottini”. Questo ingegnoso sistema è composto da gallerie scavate a mano per chilometri sotto la città. Fu creato per assicurare l’approvvigionamento costante di acqua, vitale per la vita urbana. Sorprendentemente, questo antico sistema funziona ancora oggi. È anche possibile visitarlo per ammirare l’abilità degli ingegneri medievali che lo realizzarono.Orvieto e la rupe scavata
Orvieto si trova su una rupe fatta di tufo, un tipo di roccia vulcanica. Questa rupe è però instabile e minacciata dall’erosione degli strati di argilla che si trovano sotto. Il sottosuolo di Orvieto è pieno di cavità. Ci sono pozzi e cisterne scavati dagli Etruschi, oltre ai “butti” usati per gettare i rifiuti. Più tardi sono state realizzate altre opere, come il Pozzo di San Patrizio, un esempio notevole di come l’uomo abbia saputo gestire l’acqua e costruire in modo intelligente, dimostrando un’ingegneria idraulica e architettonica avanzata.Ma cosa ci dicono, in fin dei conti, tutti questi ‘segreti’ e ‘acque’ messi insieme?
Il capitolo presenta una carrellata di esempi interessanti, ma la loro semplice elencazione non basta a costruire una vera argomentazione. Si rischia di avere un catalogo di curiosità anziché un’analisi che spieghi perché questi fenomeni sono importanti e come si collegano tra loro. Per dare spessore al tema, occorrerebbe un’indagine più approfondita che integri storia, geografia e ingegneria idraulica, cercando di individuare le logiche comuni o le differenze significative nell’approccio umano al sottosuolo e all’acqua nelle diverse epoche e contesti italiani. Approfondire autori che trattano la storia del paesaggio o l’evoluzione delle infrastrutture potrebbe fornire gli strumenti concettuali necessari.6. Il respiro e i segreti del sottosuolo italiano
Il sottosuolo italiano è un mondo affascinante, fatto di grotte naturali e cavità scavate dall’uomo, che ha plasmato la storia e la vita delle comunità. Questa dimensione nascosta non è solo un elemento del paesaggio, ma un luogo che offre benefici, conserva memorie antiche e testimonia l’ingegno umano nel rapportarsi con la terra. Il legame tra la geologia profonda e lo sviluppo delle civiltà in Italia è visibile in molti aspetti, dall’architettura all’agricoltura, dimostrando come il territorio sotterraneo abbia sempre influenzato la vita quotidiana.Il respiro curativo del sottosuolo
Le grotte naturali, in particolare quelle caratterizzate da elevata umidità, offrono un’aria di qualità eccezionale. L’ambiente sotterraneo umido è quasi privo di allergeni, rendendo l’aria particolarmente benefica per l’apparato respiratorio. Questa osservazione ha dato origine alla speleoterapia, una pratica che sfrutta le condizioni uniche delle grotte per migliorare la respirazione, specialmente in chi soffre d’asma. Esempi noti di luoghi dove si praticano terapie respiratorie sotterranee includono le gallerie del respiro in Sud Tirolo e la Grotta Giusti in Toscana, quest’ultima celebre anche per le sue acque termali calde che aggiungono un ulteriore elemento di benessere.L’acqua e l’ingegno umano
Oltre alle formazioni naturali, il sottosuolo italiano rivela l’antica capacità dell’uomo di adattare l’ambiente alle proprie esigenze. A Palermo, per esempio, l’eredità della sapienza araba si manifesta nei qanat, un sofisticato sistema di canali scavati nella tenera roccia calcarenite. Questi canali sotterranei erano progettati per raccogliere e convogliare l’acqua di sorgente, essenziale per irrigare i giardini e per un ingegnoso sistema di climatizzazione. L’acqua che scorreva nei qanat alimentava le “camere dello scirocco”, stanze sotterranee dove l’aristocrazia palermitana trovava rifugio dal caldo estivo, sfruttando l’evaporazione dell’acqua e l’isolamento termico naturale della roccia per mantenere l’ambiente fresco e piacevole.Storie antiche e risorse nascoste
Il sottosuolo è anche un custode di storie, alcune avvolte nel mistero, come i presunti passaggi segreti che si dice fossero usati dalle monache per spostarsi in città, o la grotta legata alla leggenda dei Beati Paoli. L’uso del sottosuolo per rifugi, l’estrazione di materiali preziosi come la marna di Cottanello, impiegata persino per le imponenti colonne di San Pietro a Roma, e la gestione strategica dell’acqua attraverso sistemi sotterranei, evidenziano un legame profondo e duraturo tra la conformazione geologica del territorio e lo sviluppo delle civiltà che vi si sono succedute. L’Italia, con i suoi strati geologici formatisi in milioni di anni, ha visto la sua struttura sotterranea influenzare l’architettura, le pratiche agricole e la vita quotidiana in modi significativi. Preservare questi ambienti sotterranei significa mantenere viva la memoria di un passato in cui l’uomo viveva in stretta connessione con la terra e le sue risorse nascoste.Quanto c’è di scientificamente provato e quanto di suggestione nei presunti benefici curativi dell’aria sotterranea e della “speleoterapia”?
Il capitolo, pur presentando in modo affascinante la pratica della speleoterapia e i benefici attribuiti all’aria delle grotte, non approfondisce il dibattito scientifico sulla sua efficacia. La medicina moderna richiede prove rigorose, spesso basate su studi clinici controllati, per validare l’efficacia di una terapia. Non è sempre chiaro se i miglioramenti riportati siano direttamente attribuibili alle specifiche condizioni ambientali sotterranee (umidità, assenza di allergeni) o se altri fattori, come l’effetto placebo o l’integrazione con altre forme di cura, giochino un ruolo significativo. Per comprendere meglio la questione, è fondamentale esplorare la letteratura scientifica disponibile sulla speleoterapia, cercando studi pubblicati su riviste mediche peer-reviewed. Approfondire le discipline della pneumologia, della fisiologia respiratoria e della medicina basata sull’evidenza è essenziale per valutare criticamente le affermazioni terapeutiche.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]