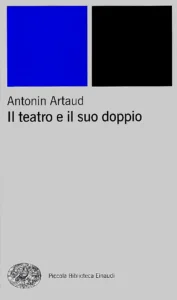1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il teatro e la crudeltà” di Antonin Artaud non è solo un libro sul teatro, è una scossa. Artaud, un visionario tormentato dalla malattia che ha vissuto tra Parigi e l’internamento, vedeva il teatro occidentale in crisi, ridotto a chiacchiere e testi noiosi, lontano dalla vita vera. Con questo testo fondamentale, che include i saggi raccolti in “Il teatro e il suo doppio”, propone una rivoluzione: un “Teatro della Crudeltà”. Non significa violenza fisica, ma un rigore e un’intensità pazzeschi, un’esperienza totale che colpisce i sensi e l’anima, non solo la mente. Vuole un teatro fisico, fatto di gesti, suoni, luci, spazio, un vero linguaggio scenico che superi la parola per affrontare temi universali e primordiali. Artaud critica anche la cultura europea, vista come superficiale e mercantile, e invoca una rivoluzione culturale e spirituale che riconnetta corpo e spirito. Questo libro è un manifesto potente per un teatro vivo, magico, capace di trasformare lo spettatore e la società stessa, un invito a risvegliare le energie sopite contro l’abulia culturale.Riassunto Breve
Il teatro di oggi sembra aver perso la sua forza, ridotto a una cosa noiosa che non riesce più a coinvolgere davvero le persone. Si è concentrato troppo sulle parole, sui dialoghi, dimenticando che il teatro è fatto anche di spazio, gesti, suoni, luci, un linguaggio fisico che parla direttamente ai sensi. È diventato solo un modo per mettere in scena testi scritti, perdendo la sua natura di evento vivo e potente. Serve un teatro che sia un’esperienza totale, che ti scuota dentro, che crei un mondo vero anche se dura poco. L’illusione non deve venire dal sembrare reale, ma dalla forza di quello che succede sul palco. Ogni spettacolo dovrebbe essere una sfida seria, che mette in gioco qualcosa di importante per attori e spettatori, e il pubblico dovrebbe uscire cambiato, non come prima. La regia diventa fondamentale, creando una specie di partitura dove ogni movimento, ogni suono ha un significato preciso, superando l’importanza del testo scritto. Si cerca un linguaggio fatto di segni, ritmi, grida, che colpisca lo spirito attraverso il corpo. Questo tipo di teatro si chiama “Teatro della Crudeltà”, ma non significa violenza fisica, piuttosto intensità e rigore, verso se stessi e verso il pubblico. Vuole risvegliare le emozioni profonde, affrontare temi universali e primordiali, come i miti o le forze della natura, invece di concentrarsi sulla psicologia dei personaggi. Abbandona l’idea dell’uomo solo come mente e guarda all’uomo intero, compreso l’inconscio e i sogni. L’obiettivo è creare uno spettacolo che ti avvolga completamente, che usi tutti i mezzi possibili, anche quelli del cinema, per liberare un potenziale magico e attivo. Questa visione del teatro si lega a una critica più ampia della cultura europea, vista come superficiale e legata solo al denaro, che ha separato il corpo dallo spirito. La vera cultura, invece, dovrebbe trasformare la persona completamente, mente e corpo insieme. Le persone che pensano in modo critico dovrebbero usare la loro intelligenza per affrontare i problemi concreti della società. Una vera rivoluzione non è solo politica o economica, ma deve cambiare il modo in cui pensiamo e viviamo, superando questa separazione tra corpo e spirito. La cultura autentica è un modo di essere, che riguarda tutto, dal mangiare al pensare. Il teatro, con la sua capacità di toccare le energie profonde, può essere uno strumento importante per questa rivoluzione culturale e spirituale, per spingere l’uomo a superare i suoi limiti e cercare qualcosa di più alto. Oggi, di fronte a una specie di pigrizia culturale e alla mancanza di pensatori coraggiosi, riprendere queste idee radicali serve a stimolare il pensiero critico e l’azione contro chi cerca di controllare le idee.Riassunto Lungo
1. Antonin Artaud: Biografia di un Visionario
Antonin Artaud nasce a Marsiglia nel 1896. La sua infanzia è segnata da una grave malattia, la meningite, che gli causa problemi neurologici che lo accompagneranno per tutta la vita. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, Artaud dimostra fin da giovane un vivo interesse per la letteratura. Inizia a scrivere poesie e fonda anche una rivista letteraria, mostrando un precoce talento e una forte ambizione intellettuale.L’arrivo a Parigi e il Surrealismo
Successivamente, Artaud si trasferisce a Parigi, il cuore pulsante della cultura e dell’arte dell’epoca. Qui entra in contatto con l’ambiente teatrale e viene attratto dal movimento surrealista, un gruppo artistico che proponeva nuove forme di espressione e una rottura con le convenzioni tradizionali. Artaud aderisce al Surrealismo, ma ben presto se ne distacca, sentendo l’esigenza di trovare una sua strada originale e indipendente nel mondo dell’arte e del teatro.La rivoluzione teatrale di Artaud
Nel 1926, Artaud decide di mettere in pratica le sue idee innovative fondando il Théâtre Alfred Jarry. Questo progetto teatrale, purtroppo di breve durata a causa della mancanza di finanziamenti, rappresenta un momento cruciale nella sua carriera. Nonostante la sua vita breve, il Théâtre Alfred Jarry diventa il laboratorio in cui Artaud inizia a sviluppare le sue teorie rivoluzionarie sul teatro, che mirano a scuotere profondamente le convenzioni sceniche tradizionali. Un’esperienza particolarmente importante per Artaud è la scoperta del teatro balinese nel 1931. La visione di questo teatro esotico lo colpisce profondamente e influenza in modo decisivo la sua concezione del teatro. Questa esperienza lo porta a scrivere una serie di saggi fondamentali, poi raccolti nel libro Il teatro e il suo doppio. In queste opere, Artaud espone la sua visione di un teatro totale, capace di coinvolgere lo spettatore a livello sensoriale e emotivo, superando la centralità della parola e del testo. Nonostante le sue teorie innovative e il suo impegno, la sua opera teatrale I Cenci non ottiene il successo che sperava, segnando un periodo di frustrazione e difficoltà.Il periodo oscuro della malattia mentale
Nel 1936, un viaggio in Messico segna l’inizio di una fase molto difficile della vita di Artaud, caratterizzata da una grave instabilità mentale. I problemi psichici, già presenti da tempo, si acuiscono e lo portano a essere internato in manicomio. Artaud trascorre nove lunghi anni in diverse istituzioni psichiatriche, subendo trattamenti medici invasivi e dolorosi. Nonostante le condizioni di internamento estremamente difficili e le sofferenze fisiche e psichiche, Artaud non smette di dedicarsi alla scrittura. Proprio durante questo periodo buio, nel 1938, viene pubblicato Il teatro e il suo doppio, l’opera che raccoglie i suoi scritti teorici sul teatro e che avrà una grande influenza sulla storia del teatro contemporaneo.Il ritorno alla vita artistica e le ultime opere
Nel 1946, Artaud viene finalmente dimesso dal manicomio e può tornare a Parigi. Nonostante le sofferenze passate e la malattia che continua a condizionarlo, Artaud riprende con energia la sua attività artistica e intellettuale. Torna a frequentare gli ambienti culturali parigini, stringe nuove amicizie e pubblica opere importanti come Van Gogh il suicidato della società e Artaud le Mômo, in cui continua a esplorare i temi della follia, della società e del linguaggio. Negli ultimi anni della sua vita, Artaud si dedica anche alla radio e prepara il radiodramma Per farla finita col giudizio di Dio. Quest’opera, però, viene censurata poco prima della trasmissione a causa dei suoi contenuti considerati blasfemi e provocatori. Antonin Artaud muore nel 1948, lasciando un’eredità artistica di grande valore. La sua vita è stata un percorso tormentato, segnato dalla malattia mentale e dalla lotta per affermare la sua visione rivoluzionaria dell’arte e del teatro. Nonostante le difficoltà e le sofferenze, Artaud ha lasciato un segno profondo nella cultura del Novecento, influenzando generazioni di artisti e intellettuali con la sua opera visionaria e provocatoria.Il capitolo presenta la malattia mentale di Artaud come una fase “oscura” e di “difficoltà”: ma non rischia questa narrazione di ridurre la complessità del rapporto tra follia e creatività, suggerendo implicitamente una visione negativa e limitante della malattia mentale stessa?
Il capitolo, pur descrivendo le sofferenze di Artaud, potrebbe beneficiare di una maggiore riflessione critica sul modo in cui la malattia mentale viene presentata. Sarebbe utile esplorare come la società e la cultura hanno storicamente interpretato la follia, e come questa interpretazione possa influenzare la nostra comprensione di figure come Artaud. Approfondire autori come Michel Foucault potrebbe offrire strumenti concettuali utili per analizzare la costruzione sociale della malattia mentale e le sue implicazioni nel contesto artistico e biografico.2. Teatro Essenziale: Oltre la Parola, Verso l’Esperienza Totale
– il testo è ripetitivo nell’esprimere il concetto di crisi del teatro. – la struttura può essere migliorata suddividendo il testo in paragrafi più specifici. – alcuni concetti possono essere approfonditi per una maggiore chiarezza.3. Teatro Essenziale: Oltre la Parola, Verso l’Esperienza Totale
Crisi del teatro contemporaneo
Oggi il teatro vive una crisi profonda. Sembra incapace di coinvolgere il pubblico e di creare una vera illusione. C’è una generale sfiducia verso l’arte e il teatro in particolare appare svuotato di significato. Si critica il teatro occidentale perché ha messo al centro la parola e il dialogo, dimenticando il linguaggio specifico del teatro. Questo linguaggio è fatto di spazio, gesti e azioni concrete. Il teatro si è ridotto a illustrare testi letterari, perdendo la sua natura di evento vivo e reale.Verso un teatro dell’esperienza totale
Per superare questa crisi, si propone un teatro che sia un’esperienza completa. Questo teatro deve parlare ai sensi prima che alla mente. Deve creare un mondo che esiste solo per il tempo dello spettacolo, ma che sia vero e capace di scuotere profondamente lo spettatore. L’illusione teatrale non deve cercare di essere realistica, ma deve basarsi sulla forza della comunicazione e sulla realtà concreta di ciò che accade sulla scena. Ogni spettacolo deve essere un evento importante, che mette in gioco qualcosa di fondamentale per tutti, attori e spettatori. Il pubblico deve essere pronto a vivere un’esperienza intensa, che lo cambi profondamente.Centralità della messa in scena e del linguaggio fisico
In questo nuovo tipo di teatro, la messa in scena diventa più importante del testo. Si cerca un linguaggio che usa il corpo, fatto di gesti, suoni, luci e movimenti. Questo linguaggio crea una vera e propria poesia dello spazio. Deve essere un linguaggio concreto, capace di agire direttamente sulle emozioni del pubblico. Deve evocare immagini forti e profonde. Il teatro deve allontanarsi dalla psicologia e dalle storie tradizionali. Invece, deve affrontare temi universali e forze primordiali, cioè le energie fondamentali che muovono la vita.Il Teatro della Crudeltà come rigore ed intensità
Si parla di un “Teatro della Crudeltà”. Questa espressione non indica violenza fisica. Significa invece rigore e intensità. Questo teatro deve essere esigente, crudele verso se stesso. Deve essere capace di portare lo spettatore al limite delle sue emozioni. L’obiettivo è risvegliare il pubblico nel profondo, toccando i suoi nervi e il suo cuore. Lo spettacolo deve essere totale, deve avvolgere completamente lo spettatore e coinvolgerlo in ogni aspetto. Il teatro deve tornare ad essere un’esperienza magica e un rito. Deve toccare l’essenza profonda della vita e le energie che ci animano. Solo così può portare a una vera consapevolezza e a un cambiamento interiore.Limitarsi alle opere di Artaud e ai suoi critici è sufficiente per comprendere la sua complessa visione, o si rischia di perdere di vista il contesto culturale e storico in cui si è formato il suo pensiero?
Il capitolo presenta una lista di fonti utili per studiare Artaud, ma manca di sottolineare l’importanza di un approccio interdisciplinare. Per rispondere alla domanda posta, sarebbe utile integrare lo studio delle opere di Artaud con approfondimenti sul contesto storico-culturale del suo tempo, indagando le correnti artistiche e filosofiche che lo hanno influenzato, come il Surrealismo e l’esistenzialismo. Inoltre, per una comprensione più completa, si suggerisce di esplorare le opere di autori che hanno dialogato o criticato Artaud, per cogliere appieno la portata e i limiti del suo pensiero.7. Contro l’Abulia Culturale
Oggi si assiste a una riduzione dell’energia culturale, che si manifesta con un aumento dell’egocentrismo e una diminuzione del numero di intellettuali importanti. Si nota che le figure intellettuali che criticavano la società sono state sostituite da esperti della cultura che invece supportano il potere esistente. Inoltre, mancano scrittori e studiosi capaci di affrontare le sfide del nostro tempo. Questo periodo storico è molto delicato a causa di gravi problemi ambientali, economici e politici che mettono a rischio il futuro del pianeta. Per questo motivo, è fondamentale capire cosa non funziona nel presente e dare spazio a chi promuove il pensiero critico e azioni sia personali che di gruppo. La “Piccola Biblioteca Morale” nasce proprio come risposta a questa situazione di mancanza di vitalità culturale. Questa iniziativa si impegna a recuperare il pensiero radicale, sia attuale che passato, in diverse discipline come la sociologia, le scienze, la religione e l’arte. L’obiettivo è riscoprire gli insegnamenti del passato e stimolare una riflessione critica sulle false promesse del progresso e sui meccanismi del potere. Si vuole incoraggiare un pensiero indipendente, che ci protegga dalle idee manipolate, e un’azione concreta contro le imposizioni del potere, rifiutando l’atteggiamento di chi accetta tutto passivamente.Ma questa “abulia culturale” è una diagnosi oggettiva o una lamentela nostalgica per un passato intellettuale idealizzato?
Il capitolo descrive una crisi culturale caratterizzata da “egocentrismo” e mancanza di “intellettuali importanti” senza però definire chiaramente questi concetti né fornire prove concrete di questo declino. Per capire se si tratti di un’analisi fondata o di una critica soggettiva, sarebbe necessario esaminare studi sociologici che analizzino i cambiamenti nei consumi culturali, nella produzione intellettuale e nel ruolo pubblico degli esperti. Approfondire il pensiero di autori come Edgar Morin, che ha studiato la cultura di massa e la complessità sociale, potrebbe offrire una prospettiva più articolata.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]