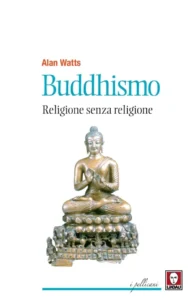Contenuti del libro
Informazioni
“Il tao della filosofia” di Alan Watts è quel tipo di libro che ti fa vedere le cose in modo completamente diverso. Watts parte subito forte, dicendo che l’idea che abbiamo di noi stessi, come un “io” isolato chiuso dentro la nostra pelle, è un po’ un’illusione, soprattutto qui in Occidente. Ci fa capire che non siamo separati dalla natura o dal resto dell’universo, ma siamo proprio una sua espressione, come una mela è parte del melo. Watts confronta la nostra visione occidentale, che vede il mondo come una macchina da controllare, con le filosofie orientali, tipo il Taoismo o il Buddismo, che invece parlano di spontaneità, di un flusso naturale delle cose. Non cerca una sostanza fissa dietro la realtà, ma la vede come un continuo divenire, un gioco di forme. E poi c’è tutta la parte sull’eterno presente: Watts dice che ci perdiamo a pensare al passato o al futuro, quando la vita vera succede solo ora. Invece di prendere la vita troppo sul serio, come una corsa verso un obiettivo, dovremmo vederla come un gioco, un “nonsenso” cosmico che ha valore in sé, proprio come la musica. È un invito a mollare un po’ il controllo e a fidarsi di questo ritmo naturale dell’esistenza, usando sia la testa che l’intuizione. È un viaggio che ti spinge a riconsiderare cosa significa essere vivi e connessi al tutto.Riassunto Breve
La percezione comune, specialmente in occidente, vede l’individuo come un sé isolato dentro il corpo, separato dalla natura e dal mondo. Questa idea deriva da miti culturali che presentano il mondo come un manufatto o una macchina, creando un senso di alienazione. Tuttavia, la scienza mostra l’essere umano come un’espressione dell’universo, non un’entità isolata. La coscienza non è solo localizzata nella testa, ma esiste anche una coscienza estesa che ci connette al tutto. Identificarsi solo con la coscienza focalizzata crea l’illusione di un sé separato, portando a paura e aggressività. Riconoscere la coscienza estesa rivela che il sé autentico è la totalità dell’essere, una manifestazione unica del cosmo. Confrontando culture diverse, si nota come la visione occidentale della natura come qualcosa da controllare si contrapponga alla visione indiana della natura come dramma cosmico o a quella cinese del Tao come flusso spontaneo e auto-organizzato. La filosofia cinese, in particolare, promuove la fiducia nell’ordine intrinseco della natura, sia interna che esterna. L’indagine sulla realtà rivela che la distinzione tra forma e sostanza è illusoria; la materia si manifesta come forma e schema, non come una sostanza ultima. Il linguaggio, separando nomi e azioni, contribuisce a questa illusione di agenti distinti. La realtà fondamentale è un processo continuo, un mondo di forme o “nāma-rūpa”, che nella sua essenza ultima è “tathatā”, puro divenire. L’attaccamento alla forma individuale e la proiezione della felicità nel futuro generano insoddisfazione. La vera esperienza della vita si manifesta nel presente, sfuggendo alla descrizione lineare del linguaggio. La saggezza orientale, attraverso pratiche come lo yoga e la meditazione, indica la via per radicarsi nel presente e dissolvere l’illusione del tempo come soluzione. La liberazione non viene dalla volontà di cambiare il sé, ma dalla comprensione che l'”io” separato è un’astrazione vuota; esiste solo l’accadere del mondo. La sensazione di mancanza di significato causa infelicità, ma la ricerca di un significato esterno può essere fuorviante. Il significato può risiedere nell’esperienza stessa, come nella musica o nell’arte, che hanno valore intrinseco. L’idea teologica di Dio che crea per “līlā”, gioco, suggerisce un nonsenso divino all’origine, e la meraviglia di fronte all’esistenza può essere una forma di gioia priva di significato esterno. L’attrazione per il nonsenso riflette una partecipazione a questo nonsenso essenziale del mondo, che possiede una sua qualità artistica. Ogni esperienza sensoriale è vibrazione, un’alternanza di opposti inseparabili in un campo unificato. La coscienza focalizzata frammenta questa unità. L’esistenza non è seria, ma un gioco spontaneo e vario, come la musica il cui valore è nell’atto di suonare. L’orientamento occidentale al raggiungimento di obiettivi trasforma la vita in un fardello. Abbandonarsi al ritmo naturale dell’esistenza, come nel gioco o nella danza, allinea l’individuo con l’universo. L’ossessione per il controllo tecnologico è controproducente e genera complessità. La visione occidentale che scompone l’universo in parti perde la sua natura organica. Esistono approcci “rigidi” (calcolo) ed “elastici” (intuizione), entrambi necessari, ma la coscienza analitica rischia di perdere la visione d’insieme. L’iperspecializzazione e l’eccesso di informazioni impediscono una visione completa. Esiste una coscienza “estesa” che permette di percepire e risolvere problemi complessi intuitivamente. È necessario un equilibrio tra analisi e intuizione per affrontare il futuro e integrare la tecnologia con l’intelligenza organica.Riassunto Lungo
1. L’Illusione del Sé Incapsulato
L’Identità Personale e la Sua Percezione Comune
La questione fondamentale per l’essere umano è capire la propria identità personale. Nella società occidentale, si pensa spesso all’individuo come a un ego isolato, chiuso dentro la propria pelle. Questa idea porta a considerare il corpo come qualcosa di esterno al sé, quasi un oggetto che ci appartiene, invece che una parte fondamentale di noi. In questa visione, l’io è localizzato nella testa, come se fosse un centro di controllo separato dal corpo e dal mondo che ci circonda.Miti Culturali e la Separazione dal Mondo Naturale
Questa concezione dell’identità è influenzata da antiche storie culturali tipiche del mondo occidentale. La prima storia racconta che il mondo è stato creato da una divinità, portando a vedere la natura come qualcosa di artificiale e separato dall’uomo. La seconda storia, più recente, descrive l’universo come un meccanismo senza intelligenza, relegando la coscienza e ciò che ha valore solo al mondo umano. Queste due narrazioni contribuiscono a farci sentire separati e distanti dal mondo naturale.La Prospettiva Scientifica: Siamo Parte dell’Universo
Osservando la realtà con occhi scientifici, emerge una visione diversa. L’essere umano non è un’entità isolata, ma piuttosto una manifestazione dell’universo stesso. Così come le mele sono il frutto del melo, allo stesso modo gli esseri viventi sono una espressione della Terra. La coscienza non è limitata al singolo individuo, ma è un fenomeno diffuso, presente in diverse forme anche nella materia che consideriamo inanimata.Coscienza Localizzata e Coscienza Estesa
La sensazione di essere un sé isolato nasce da una specializzazione della coscienza che definiamo “localizzata”. Questa è la coscienza che si concentra su un singolo punto, la nostra attenzione focalizzata. Però, esiste anche una “coscienza estesa”, che opera silenziosamente in sottofondo e ci collega al mondo intorno a noi in modo più ampio e profondo. Quando ci identifichiamo solo con la coscienza localizzata, dimentichiamo la vastità del nostro essere e ci sentiamo separati dal resto.Riconoscere l’Interconnessione per Superare l’Alienazione
Riconoscere la coscienza estesa significa capire che il nostro vero sé è la totalità del nostro essere. Ogni persona è una manifestazione unica del cosmo, una danza particolare nell’infinita varietà dell’esistenza. La paura della morte e l’aggressività verso l’ambiente nascono da un errore: percepirci come entità separate e isolate. In realtà, siamo parte integrante di un universo interconnesso e cosciente. Comprendere questa profonda unione è essenziale per superare la sensazione di alienazione e vivere in armonia con il mondo che ci ospita.Ma questa ‘coscienza estesa’, presentata come soluzione all’alienazione, non rischia di essere una bella favola senza solide basi scientifiche?
Il capitolo sembra dare per scontata l’esistenza e la rilevanza della ‘coscienza estesa’ come soluzione all’alienazione. Però, non è chiaro se questa idea abbia un solido supporto scientifico. Per approfondire, sarebbe utile studiare la neuroscienza e la filosofia della mente, magari leggendo autori come Patricia Churchland o Daniel Dennett, che hanno un approccio più critico e basato sulle evidenze empiriche allo studio della coscienza.2. Oltre la Pelle: Uomo e Natura come Unità
La visione comune e la prospettiva scientifica
Comunemente, si pensa all’essere umano come qualcosa di separato dal mondo che lo circonda, un individuo cosciente isolato in un ambiente esterno e diverso da sé. Questa idea si contrappone alla visione delle scienze naturali. Queste descrivono l’uomo e la natura come un unico sistema strettamente connesso. In questa prospettiva scientifica, le azioni umane non sono altro che manifestazioni dell’universo stesso. Questa visione mette in discussione l’idea di un “io” limitato alla coscienza individuale, suggerendo invece un concetto di sé molto più ampio, che include tutto l’ambiente che ci circonda.La filosofia occidentale e la natura come oggetto da controllare
La filosofia occidentale ha spesso interpretato la natura come se fosse un oggetto costruito, quasi un manufatto o una macchina. In questa visione, la natura è considerata una creazione divina oppure un sistema meccanico che può essere controllato e sfruttato a piacimento. Questo modo di vedere la natura genera una certa diffidenza. La natura viene percepita come qualcosa da dominare, da tenere sotto controllo e da cui difendersi.La filosofia indiana e la natura come illusione cosmica
La filosofia indiana offre una prospettiva diversa. In questa visione, la natura è vista come un grande spettacolo cosmico, una sorta di illusione, chiamata “māyā”. Questa illusione è il palcoscenico in cui si manifesta il sé universale, “brahman”, che assume innumerevoli forme diverse. La natura, quindi, non è altro che una manifestazione illusoria del principio universale che sottende ogni cosa.La filosofia cinese e la natura spontanea e auto-organizzata
La filosofia cinese propone un’ulteriore interpretazione. Essa considera la natura, chiamata “tzu-jan”, come qualcosa di spontaneo e capace di auto-organizzarsi. Il principio del Tao rappresenta il flusso naturale degli eventi, una forza che nutre e sostiene tutte le cose senza la necessità di dominarle o controllarle. Questa visione promuove un atteggiamento di fiducia nei confronti della natura, inclusa la natura umana. Si riconosce la complessità della natura, ma anche il suo ordine intrinseco e la sua capacità di autoregolarsi.L’ordine naturale e l’accettazione della spontaneità
La natura, sia quella che ci circonda sia quella che è dentro di noi, è vista come un organismo capace di autoregolarsi, senza bisogno di interventi esterni per essere guidata o controllata. Questo ordine naturale, chiamato “li”, è presente in ogni aspetto della realtà, dalle nuvole alle montagne, e si manifesta in modo spontaneo e armonioso. Comprendere veramente la natura significa accettare la sua assenza di uno scopo preciso. Significa trovare valore e bellezza nella sua esistenza stessa, senza volerle imporre un controllo rigido che finisce per soffocare la sua spontaneità e la nostra fiducia in essa.Se la natura è spontanea e auto-organizzata, come si concilia questa visione con la necessità di intervenire attivamente per affrontare le sfide ambientali e sanitarie che affliggono l’umanità?
Il capitolo presenta una visione suggestiva della natura come sistema spontaneo e auto-organizzato, ma lascia in sospeso interrogativi cruciali. Se abbracciamo l’idea di un ordine naturale intrinseco, come si concilia questa prospettiva con l’urgenza di azioni concrete di fronte a problemi ambientali e sanitari? Per approfondire queste tematiche, è fondamentale esplorare il campo dell’etica ambientale e le diverse teorie filosofiche sull’azione umana nella natura. Pensatori come Hans Jonas, con il suo principio di responsabilità, o autori come Donna Haraway, che esplorano le interconnessioni tra specie, possono offrire strumenti concettuali utili per affrontare queste complesse questioni.3. Forma e Apparenza
La distinzione tra forma e sostanza
L’indagine filosofica comincia analizzando idee comuni, come la differenza tra forma e sostanza. Questa idea, che arriva da Aristotele e dalla Bibbia, dice che ogni cosa materiale è fatta da una sostanza di base che viene plasmata in una forma. Però, se si analizza meglio il linguaggio, si scopre che questa distinzione può essere sbagliata. Il linguaggio crea delle “illusioni” quando nomina delle azioni come se fossero oggetti separati. Ad esempio, nomina “lampo” e “lampeggiare” come se fossero cose diverse, e questo fa credere che ci sia una sostanza nascosta sotto.La materia osservata dalla scienza
La scienza, cercando di capire la natura della materia, ha diviso la materia in parti sempre più piccole, dagli atomi alle onde-particelle. Questo processo mostra che la materia, quando la si guarda da vicino, appare sempre più come forma e schema, e meno come sostanza definita. Quindi, cercare una sostanza ultima non porta a risultati, perché l’universo, quando lo si osserva con la scienza, sembra sempre sfuggire a una comprensione definitiva.La filosofia e la manifestazione dell’esistenza
La filosofia cambia domanda: non chiede più “di cosa è fatta la materia?”, ma chiede “come si mostra l’esistenza?”. Si scopre che mettere le cose in categorie e definirle sono azioni formali che non riescono a capire l’essenza vera della realtà. La fisica di oggi, lasciando perdere la ricerca della sostanza, descrive l’universo usando modelli e forme. La parola “materia” stessa, nella sua origine, richiama idee di misura, forma e capacità di creare, suggerendo che la forma sia la cosa più importante.La percezione della solidità e il linguaggio
La sensazione che la materia sia solida è spiegata come un’illusione causata dalla velocità dei processi microscopici. La differenza tra nomi e verbi nel linguaggio, tipica delle lingue indoeuropee, crea una divisione tra chi fa l’azione e l’azione stessa, ma questa divisione non rispecchia la realtà di base. La realtà di base è invece un processo continuo senza persone o cose che agiscono in modo separato. Si abbandona quindi l’idea di sostanza e si preferisce pensare a un mondo di forme, o “nāma-rūpa”. Andando oltre le forme, si arriva al concetto buddhista di “tathatā”, la “cosa in sé”. Questa “cosa in sé” è qualcosa che non si può definire con le parole e si manifesta come puro cambiamento, simile alla musica che non rappresenta altro che sé stessa.Affermare che “ogni cosa è vibrazione” non è una semplificazione eccessiva che rischia di svuotare di significato concetti scientifici complessi come la fisica quantistica?
Il capitolo introduce l’idea che la realtà sia fondamentalmente vibrazione e dualità. Tuttavia, questa affermazione, presentata in modo così generico, solleva interrogativi sulla sua accuratezza e sul rischio di banalizzare concetti scientifici complessi. Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile approfondire le basi scientifiche di tali affermazioni, studiando la fisica quantistica e la teoria delle onde. Autori come Carlo Rovelli, che affrontano temi di fisica in modo divulgativo, potrebbero fornire una prospettiva più chiara. Inoltre, esplorare le radici filosofiche del concetto di dualità, presenti in diverse tradizioni di pensiero, potrebbe arricchire la comprensione di queste idee.7. Vedere Oltre la Rete del Controllo
L’illusione del controllo tecnologico
Viviamo in un’epoca che crede fermamente nella capacità della tecnologia di controllare ogni aspetto della natura. Questa ossessione per il controllo, però, sta diventando controproducente. La realtà di oggi appare complessa e difficile da capire, causando frustrazione e problemi in molti settori, dalle aziende agli ospedali, fino alle università.La necessità di cambiare prospettiva
Per capire meglio la nostra situazione, è utile confrontare la cultura occidentale con altre culture, come quella cinese o indiana. Questo confronto ci aiuta a mettere in discussione le nostre idee di base. Spesso, infatti, agiamo senza riflettere su cosa significano veramente concetti come coerenza, razionalità o una vita degna di essere vissuta, basandoci su supposizioni implicite.I limiti della visione occidentale meccanicistica
La cultura occidentale tende a vedere l’universo come una macchina da smontare in pezzi sempre più piccoli per poterla capire e dominare. Questo modo di pensare, anche se a volte funziona, ci porta a vedere il mondo in modo frammentato e separato, dimenticando che la natura è invece un sistema organico e interconnesso. Cerchiamo di misurare e catalogare la realtà attraverso schemi rigidi, come una rete, perdendo di vista la sua fluidità e la sua natura incerta.Due tipi di pensiero: rigido ed elastico
Esistono due tipi di persone: quelle “rigide”, che preferiscono il calcolo e la precisione, e quelle “elastiche”, che si affidano di più all’intuizione e alla vaghezza. Entrambi i modi di pensare sono importanti perché la realtà è sia rigida che elastica, fatta di struttura e cambiamento. Tuttavia, se ci concentriamo troppo sul pensiero analitico, che divide e classifica ogni cosa, rischiamo di perdere la visione d’insieme.Iperspecializzazione e perdita della visione d’insieme
L’iperspecializzazione è una conseguenza di questo approccio: gli esperti in un settore specifico non riescono più a vedere il contesto generale, causando difficoltà di gestione e coordinamento. La grande quantità di informazioni rende impossibile avere un quadro completo e analitico di ogni dettaglio.L’importanza della coscienza estesa e intuitiva
Esiste anche un altro tipo di coscienza, quella “estesa”, che ci permette di capire e risolvere problemi complessi in modo intuitivo, senza bisogno di un ragionamento lineare. Questa capacità, che fa parte del cervello umano, viene spesso trascurata a favore di un pensiero astratto e computazionale. La tecnologia è potente, ma non può sostituire completamente questa intelligenza intuitiva e naturale.Verso un equilibrio tra tecnologia e intuizione
Per affrontare le sfide del futuro, è fondamentale trovare un equilibrio tra il rigore dell’analisi e la flessibilità dell’intuizione. Dobbiamo evitare che la tecnologia, guidata solo da un pensiero lineare, diventi pericolosa per l’ambiente e per l’uomo. La vera sfida è unire la potenza della tecnologia con la saggezza della nostra intelligenza più profonda e ancora sconosciuta. Solo così potremo costruire un futuro sostenibile.È davvero utile e accurato ridurre la complessità del pensiero umano a una dicotomia tra “rigido” e “elastico”?
Questo capitolo presenta una distinzione tra pensiero “rigido” e “elastico” che, sebbene suggestiva, rischia di semplificare eccessivamente la varietà e la complessità dei processi cognitivi umani. Non si chiarisce se questa distinzione sia basata su evidenze scientifiche robuste o su generalizzazioni culturali. Per approfondire i limiti di tali categorizzazioni, sarebbe utile esplorare le opere di autori che si occupano di filosofia della scienza e di epistemologia, per comprendere meglio come le diverse culture e tradizioni di pensiero influenzano, ma non determinano rigidamente, i nostri approcci alla conoscenza e alla risoluzione dei problemi. Approfondimenti sul pensiero complesso e sui sistemi dinamici potrebbero offrire una prospettiva più sfumata e meno dicotomica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]