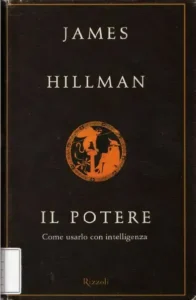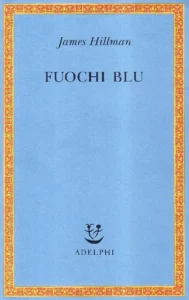1. Oltre la Classificazione Esterna del Suicidio
Il suicidio è stato considerato per molto tempo un reato gravissimo, punito sia dalle leggi dello stato che da quelle della chiesa. In Inghilterra, ad esempio, era visto come un doppio crimine contro Dio e contro il re, con conseguenze pesanti come il divieto di sepoltura in terra consacrata e la confisca di tutti i beni. Nel Settecento, per evitare queste severe punizioni, le giurie iniziarono a dichiarare le persone suicide “non compos mentis”, cioè incapaci di intendere e di volere. Questo trasformò l’atto da reato a segno di malattia mentale. Questa visione medica fu poi rafforzata dai primi psichiatri, che cercarono spiegazioni legate a problemi di salute per il suicidio.Le Visioni Esterne
Sociologia, diritto, teologia e medicina affrontano il suicidio guardandolo principalmente “da fuori”, concentrandosi su come prevenirlo. La sociologia lo considera un fenomeno che riguarda la collettività, legato a problemi di legame sociale. Il diritto lo vede come una rottura del patto che lega i membri della società. La teologia lo interpreta come un peccato contro la creazione divina e un atto di superbia. La medicina lo tratta come una condizione da combattere per proteggere la vita fisica. Questi ambiti partono da idee di base (come l’importanza della società, della giustizia, di Dio, della vita) che sentono minacciate dal suicidio, perché questo atto afferma la possibilità di una scelta personale e di una morte che nasce da dentro la persona.L’Approccio Psicologico
L’analisi psicologica si distingue da questi modi di vedere esterni. Non cerca di giudicare o impedire il suicidio, ma di capirlo come un evento che accade nella realtà interiore della persona. Chi fa analisi si concentra sul significato che l’atto ha per l’individuo, cercando di comprendere la ragione profonda che lo spinge, anche quando il comportamento esteriore sembra rientrare in categorie già note. L’approccio analitico parte dall’idea fondamentale che l’anima esista e che gli eventi umani abbiano un loro scopo interiore. Da questo punto di vista, il suicidio mette in luce quanto la psiche sia autonoma e indipendente dalle regole imposte dalla società, dal diritto, dalla teologia e persino dal corpo.Affermare che la psiche sia “autonoma e indipendente” dal corpo e dalle regole esterne non rischia forse di ignorare le complesse interazioni tra mente, cervello e contesto sociale?
Il capitolo presenta l’approccio psicologico come radicalmente distinto dalle visioni “esterne”, ponendo l’accento sull’autonomia della psiche. Tuttavia, questa distinzione netta solleva interrogativi sulla sua validità nel contesto scientifico e filosofico contemporaneo. La ricerca moderna in neuroscienze e psicologia clinica evidenzia costantemente il legame indissolubile tra stati mentali, processi cerebrali e influenze ambientali e sociali. Ignorare queste interconnessioni rischia di offrire una visione parziale e potenzialmente fuorviante della complessità umana e dei fattori che possono portare al suicidio. Per approfondire questa tematica e comprendere meglio i limiti di una visione puramente “interna” e autonoma della psiche, sarebbe utile esplorare discipline come le neuroscienze cognitive, la sociologia della salute mentale e la filosofia della mente. Autori come Antonio Damasio o Michel Foucault possono offrire prospettive cruciali che mettono in discussione l’idea di una psiche isolata, evidenziando invece il suo radicamento nel corpo, nel cervello e nelle strutture di potere e conoscenza della società.2. L’Anima e la Morte: Uno Sguardo dall’Interno
La psicologia che osserva i fenomeni umani, come il suicidio, solo dall’esterno, usando classificazioni e termini freddi, non riesce a cogliere l’esperienza interiore. Questo modo di procedere, tipico di certi studi, riduce problemi complessi a cose banali o a “logica confusa”. Sembra quasi un complesso di inferiorità verso le scienze naturali. Anche se guardare dall’esterno permette di fare generalizzazioni, chi analizza deve sempre rimanere legato all’interno, all’anima delle persone. I problemi psicologici sono fatti di esperienze e sofferenze profonde, hanno un “dentro”, non sono solo comportamenti da etichettare.L’Anima e l’Approccio dell’Analista
Il termine “anima” non è scientifico e non si lascia definire con precisione, ma è un simbolo fondamentale per la psicologia che scava in profondità. Rappresenta quella parte umana che rende possibile dare un senso alle cose e trasforma gli eventi esterni in vere e proprie esperienze vissute. Le diverse idee che la storia ha avuto sul rapporto tra anima e corpo sono viste, dal punto di vista psicologico, come modi in cui l’anima stessa si descrive. A differenza di chi guarda da fuori, come medici, sociologi o teologi che spesso puntano a prevenire, chi analizza cerca di capire le cose dall’interno. Questo significa dare spazio e riconoscimento agli stati d’animo, anche a quelli legati all’idea della morte, senza dare giudizi. La comprensione è un processo intimo e personale, basato sulla sintonia con l’altro, non una spiegazione valida per tutti.
Comprendere il Suicidio e la Morte: Un Percorso di Trasformazione
La psicologia accademica, concentrata solo su ciò che si vede fuori, rischia di perdere di vista l’anima. La psicologia del profondo, invece, la mette al centro del suo lavoro. Per capire davvero il suicidio, bisogna esplorare la vita della persona, compresa la sua “mitologia interiore”, fatta di sogni e fantasie. Il suicidio, da questa prospettiva, può essere visto come una strada per entrare nella morte, un passaggio che libera fantasie profonde e nascoste. La morte non è solo la fine del corpo, ma un’esperienza che l’anima attraversa in molte forme diverse. La filosofia, che vede la vita e la morte strettamente legate, offre una visione utile per chi analizza. Vivere implica un continuo morire, e ogni “morte” può essere vista come un atto che ci appartiene. L’esperienza della morte, intesa in senso ampio, è necessaria per i cambiamenti profondi della psiche.
L’Impulso Suicida: Un Desiderio di Cambiamento Profondo
L’impulso a togliersi la vita può essere letto come un tentativo urgente di trasformarsi, un passaggio violento da un modo di essere a un altro. Spesso nasce da una profonda confusione tra ciò che la persona sente dentro e le azioni che compie fuori. L’analisi aiuta proprio a distinguere la storia esteriore di una vita dai fatti simbolici che appartengono alla storia dell’anima, la quale emerge e si libera quando non si identifica più solo con il mondo esterno. Capire questa distinzione è fondamentale per affrontare il desiderio di cambiamento in modo diverso.
Ma un approccio che si basa su un concetto non scientifico come l’anima, non rischia di ignorare le cause concrete e urgenti del disagio che porta al suicidio?
Il capitolo critica giustamente una psicologia che riduce la complessità umana a mere etichette esterne, ma nel fare ciò, sembra abbracciare un concetto, quello di “anima”, che per sua stessa ammissione non è scientifico. Questo solleva interrogativi su come tale approccio possa interagire efficacemente con la realtà complessa del suicidio, che ha radici profonde anche in fattori biologici, sociali e clinici ben studiati da quelle stesse discipline “esterne” criticate. Per approfondire questo divario e capire come diverse prospettive affrontano il tema del suicidio, è utile esplorare la psicologia clinica basata sull’evidenza, la sociologia (in particolare gli studi sui fattori sociali del suicidio) e la psichiatria. Autori come Aaron Beck per l’approccio cognitivo al suicidio o Émile Durkheim per la prospettiva sociologica possono offrire punti di vista complementari o divergenti rispetto a quello presentato nel capitolo.3. La Necessità dell’Esperienza della Morte per l’Anima
L’anima ha un bisogno costante dell’esperienza della morte. Questa non è vista solo come un fatto fisico che accade all’esterno, ma come una parte sempre presente nella storia interiore dell’anima, come una forza chiamata Thanatos. Anche eventi che sembrano esterni o casuali possono in realtà inserirsi in questi schemi profondi e mitici dell’anima. L’analista guarda alla morte, anche al suicidio, non solo dal punto di vista medico o sociale, ma la collega sempre alla storia unica dell’anima di ogni persona.La prospettiva dell’analisiIl modo in cui l’analisi guarda alla morte è molto diverso da quello della medicina. La medicina si concentra sul combattere la morte fisica e mette al primo posto il corpo. L’analisi, invece, considera l’anima come prioritaria e riconosce che l’anima ha bisogno di fare l’esperienza della morte. Questa esperienza non si manifesta solo nel suicidio fisico, ma può prendere molte forme diverse a livello psicologico. Cercare di evitare l’esperienza necessaria della morte concentrandosi sulla morte concreta o usando cure mediche per impedirla va contro ciò di cui l’anima ha bisogno e tradisce il punto di vista dell’analisi.
L’esperienza necessaria e il ruolo dell’analistaL’esperienza della morte è fondamentale per l’anima e non si può scappare da essa con cure mediche o cercando di “simboleggiarla” in modo difensivo. La disperazione è una delle forme più importanti e centrali di questa esperienza. Il compito dell’analista è accompagnare la persona in questo percorso, stando al suo fianco nella disperazione senza dare false speranze o soluzioni facili. Questo stare insieme permette all’esperienza profonda della morte di accadere dentro la psiche, e questo processo può portare a una trasformazione importante e alla scoperta della forza indistruttibile dell’anima stessa. La responsabilità dell’analista si basa su un legame profondo e riservato con la persona che segue e sulla partecipazione alla sua storia interiore. Questa responsabilità non cambia a seconda di come si manifesta l’esperienza della morte. Un fallimento, anche nel caso di un suicidio, non è l’atto in sé, ma il non aver mantenuto questo legame di fiducia e vicinanza. Nessuno può essere responsabile della vita di un altro, ma si è responsabili del proprio coinvolgimento e del proprio impegno nella relazione d’aiuto.
L’identità dell’analisiL’analisi deve definire chiaramente chi è e che cosa fa, distinguendosi dalla medicina, dalla religione e dalla psicologia accademica. È una scienza che si occupa specificamente dell’anima. Parlare di “analisi laica” spesso riflette un punto di vista esterno, magari medico, che non capisce l’indipendenza e la specificità del lavoro analitico. Il requisito più importante per chi fa analisi è aver fatto un’analisi personale approfondita su se stesso. La medicina moderna, concentrandosi sul corpo e su una visione materiale della vita, ha perso il contatto con gli aspetti più profondi della cura che riguardano l’anima, che sono invece il campo d’azione e di esplorazione dell’analista.
Ma su quali evidenze concrete si fondano queste affermazioni sull’anima e sulla malattia come ‘necessaria’?
Il capitolo presenta una visione affascinante ma che si spinge in territori altamente speculativi, specialmente quando attribuisce alla malattia un ruolo quasi teleologico per la “crescita dell’anima” o postula l’esistenza di un’anima del mondo. Queste sono affermazioni che trascendono l’osservazione empirica e si collocano nel regno della metafisica o della fede. Per valutare criticamente tali concetti e comprendere il confine tra interpretazione psicologica profonda e postulato non verificabile, sarebbe utile esplorare la filosofia della scienza, in particolare i criteri di demarcazione tra scienza e non-scienza, e confrontarsi con autori che hanno analizzato criticamente le basi epistemologiche delle diverse scuole di pensiero psicologico.6. Oltre l’Io: Suicidio e Rito dell’Anima
Il suicidio non è solo un gesto intimo e privato, ma può essere compreso meglio se visto attraverso il rito e la partecipazione di più persone. Coinvolgere altri, come un gruppo di amici vicini, cambia l’atto da qualcosa di nascosto e vissuto con vergogna a una manifestazione più aperta. Questo aiuta a liberarlo dall’idea che sia solo una questione individuale e superba. Riconoscere che esiste un “corpo esterno” all’individuo fa capire che la morte, proprio come la vita, è un fatto che riguarda la comunità e coinvolge anche realtà che non vediamo. Il desiderio di togliere il suicidio dalla sfera della legge e della clandestinità, come alcuni gruppi hanno provato a fare, non è riuscito a liberarlo dalla sensazione di clandestinità psicologica legata all’individualismo. La resistenza che si trova in Occidente all’idea di rendere pubblico il suicidio nasce proprio dalla paura che questo metta in pericolo l’essenza stessa dell’individualità privata. Permettere ad altri di entrare nelle domande profonde legate al suicidio significa ricollegare questo gesto a contesti antichi e rituali, riconoscendo che in gioco c’è qualcosa di più grande della singola persona.La pulsione di morte nell’anima
La metapsicologia, come quella sviluppata da Freud con il concetto di Thanatos, la pulsione di morte, suggerisce che la morte non è semplicemente una fine. È invece una forza autonoma che è sempre presente nell’anima. L’anima, mentre vive, cerca la morte, e questo si manifesta non solo come distruzione, ma anche come trasformazione, crescita, e persino come esperienza di perdita e lutto. Questa presenza universale di Thanatos implica che chi si trova ad affrontare il tema del suicidio non può porsi come un giudice esterno. È piuttosto un partecipante che può mostrare empatia, riconoscendo questa forza che agisce dentro ognuno.L’individualità e il desiderio di liberazione
L’idea stessa di essere un “individuo” è un concetto che affonda le radici in archetipi, sostenuta da miti potenti come quello del monoteismo. Questa idea può diventare un’ossessione che ci imprigiona. La fantasia di “uccidere sé stessi” può essere vista come un modo letterale di esprimere il desiderio profondo di far morire l’idea archetipica di una soggettività chiusa e isolata. L’impulso che porta all’autodistruzione potrebbe nascere da quelle parti di noi o quelle influenze che sono state “escluse” (come altri Dei o altri tipi di esseri) e che cercano di liberare l’anima per permetterle una partecipazione più vasta al mondo. L’individuo è molto più grande della sua sola personalità singola; c’è qualcosa oltre l’io che abita l’anima e che ha voce e diritto di parola sulla sua morte.Il Daimon e la vocazione dell’anima
Ciò che definisce veramente l’essere “io” è il daimon. Questo daimon è un compagno interiore che ha scelto di abitare la vita di quella persona. Il percorso più importante nella vita non è tanto affermare l’io isolato, quanto piuttosto scoprire e far emergere questo daimon e realizzare la sua vocazione specifica. Per capire le domande profonde legate al suicidio, è utile rivolgerle al daimon stesso, cercando di comprendere il suo intento. Questo tipo di dialogo interiore ricorda le conversazioni che si trovano in antichi testi egizi, dove si parlava con le diverse parti dell’anima.Liberare l’anima e l’anima del mondo
Le idee archetipiche, compresa quella di essere un individuo separato, possono a volte prendere il sopravvento sulla nostra coscienza e possederla. Le fantasie sul suicidio possono essere interpretate come un tentativo di epistrophé, un ritorno a uno stato o a una comprensione più profonda. Per liberare l’anima da queste possessioni o ossessioni, non serve abbandonare il mondo fisico, ma piuttosto liberarsi dalla sua “mondanità”, un’altra ossessione archetipica che ci tiene legati solo all’aspetto superficiale delle cose. Si tratta di guardare il mondo in modo trasparente, cercando di vedere la sua anima più profonda. Ogni daimon è legato a questa anima del mondo e richiede una partecipazione attiva ad essa. Trascurare l’anima del mondo porta al suo impoverimento, al suo avvizzimento, e questo, a sua volta, può rafforzare l’impulso autodistruttivo dentro di noi.Ma un approccio così centrato su archetipi e “daimon” non rischia di trascurare le cause concrete e cliniche del suicidio, offrendo una lettura affascinante ma potenzialmente pericolosa?
Il capitolo propone una visione suggestiva del suicidio, sradicandolo dall’individualismo e riconnettendolo a forze archetipiche e a un’anima del mondo. Tuttavia, nel fare ciò, sembra eludere completamente la complessa realtà clinica e sociale che spesso accompagna questo gesto estremo. Non si accenna a patologie psichiatriche, a condizioni di disagio sociale, a fattori neurobiologici o all’impatto devastante sui sopravvissuti, elementi che la ricerca scientifica e l’esperienza clinica considerano centrali. Per bilanciare questa prospettiva, sarebbe fondamentale esplorare gli studi nell’ambito della suicidologia, della psicologia clinica e della sociologia, confrontandosi con autori che affrontano il tema da un punto di vista empirico e terapeutico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]