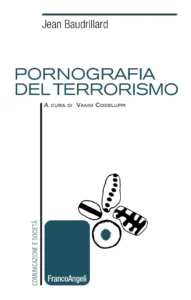Contenuti del libro
Informazioni
“Il sistema degli oggetti” di Jean Baudrillard ti fa pensare a come le cose che abbiamo intorno non sono solo oggetti utili, ma carichi di significati nascosti e complessi. Il libro parte dall’ambiente più intimo, la casa, analizzando come l’arredamento è passato da una struttura tradizionale, piena di simboli familiari e gerarchie, a un design moderno basato sulla funzionalità e la flessibilità, dove gli oggetti perdono la loro anima simbolica per diventare elementi di un sistema astratto, quasi solo forme perfette che nascondono la fatica. Ma non è finita qui, perché Baudrillard esplora il doppio valore degli oggetti: da un lato la funzionalità moderna, dall’altro l’anacronismo degli oggetti antichi, che non servono a niente di pratico ma ci affascinano perché ci parlano di storia, di autenticità, di un passato che cerchiamo per sentirci più sicuri. Questa ricerca di significato si manifesta in modo potente nel collezionismo, dove il possesso degli oggetti diventa un modo per creare un universo personale, un gioco seriale che dà l’illusione di controllare il tempo e le ansie, anche se a volte ti chiude un po’ in te stesso. Infine, il libro analizza il sistema consumistico più ampio, mostrando come la distinzione tra modello e serie, l’obsolescenza programmata e il credito ci intrappolano in un ciclo di acquisto infinito, amplificato dalla pubblicità, che non è solo informazione ma uno spettacolo rassicurante che ci spinge a volere gli stessi oggetti per definire il nostro status sociale, trasformando il consumo in una manipolazione di segni più che nella soddisfazione di bisogni reali.Riassunto Breve
Nella casa di una volta, i mobili erano grandi e fissi, messi lì per mostrare chi comandava in famiglia e per dare un posto preciso a ogni cosa, come la sala da pranzo o la camera da letto. Ogni oggetto aveva un significato forte, legato alle persone e alle regole della casa. Poi sono arrivati i mobili moderni, che si muovono e cambiano forma per risparmiare spazio, come i letti che spariscono. All’inizio sembravano solo una soluzione veloce, ma hanno iniziato a liberare le persone dai legami rigidi della famiglia, anche se solo per come si usava l’oggetto. Con l’arredamento più nuovo ancora, gli oggetti non sono più legati a una sola funzione o a significati profondi, ma servono a organizzare lo spazio in modo pratico. Diventano come pezzi di un gioco. I muri spariscono, la luce è dappertutto e gli oggetti perdono la loro “anima”. Anche i colori cambiano, non più legati a emozioni, ma usati in modo tecnico, come i materiali sintetici che prendono il posto del legno naturale. Il vetro diventa importante perché è trasparente e sembra puro. Le forme degli oggetti diventano semplici e facili da usare, quasi senza sforzo, e le cose tecniche diventano piccole. La forma perfetta nasconde che gli oggetti non hanno più quel legame con i gesti di una volta. Questa idea di funzionalità perfetta crea l’idea che gli oggetti, anche se complicati, controllano quello che facciamo, mostrando un mondo dove la tecnica è tutto.Il modo in cui usiamo gli oggetti oggi si basa sulla loro funzionalità, che non è solo usarli per uno scopo pratico, ma farli diventare parte di un sistema più grande, come segni che si possono spostare in un ordine astratto. Questo sistema nuovo è diverso da quello vecchio, dove contava l’uso principale dell’oggetto e il suo significato. Gli oggetti vecchi, anche se non sembrano funzionali oggi, rientrano in questo discorso perché la loro funzione diventa quella di mostrare il tempo che è passato. Non servono per un uso pratico immediato, ma la loro esistenza è importante perché rappresentano il passato e l’idea di dove veniamo. Rispondono al bisogno di sentirsi legati a qualcosa di vero e antico, come una foto di famiglia che ci rassicura sulle nostre origini. Volere oggetti vecchi mostra che cerchiamo l’autenticità e ci sentiamo nostalgici del passato. Restaurare edifici vecchi, per esempio, serve a mettere insieme il nuovo con il vecchio, per avere un senso di continuità. Nelle società ricche, si cercano gli oggetti vecchi per sentirsi autentici, mentre in quelle meno ricche si cercano gli oggetti nuovi come segno di progresso. Il mercato dell’antiquariato sfrutta questo desiderio di avere cose che sembrano importanti perché vengono dal passato. Alla fine, sia gli oggetti nuovi che quelli vecchi fanno parte di un sistema culturale complicato, che mostra la tensione tra il moderno e la tradizione.La voglia di avere oggetti nasce dal fatto che sono proprietà privata. Gli oggetti non sono solo cose da usare, ma diventano spazi nostri, che mostrano che li possediamo e ci teniamo. Non essendo più legati solo all’uso, diventano parte di un sistema che usiamo per costruirci un mondo personale. Collezionare è l’esempio più chiaro di questa voglia di possedere. La collezione trasforma oggetti normali in qualcosa di speciale che parla di noi. Spesso inizia da bambini e torna da adulti, legata a momenti importanti della vita, come se fosse un modo per sentirsi al sicuro. Non è l’oggetto in sé a rendere importante chi colleziona, ma la passione per l’atto di collezionare. La collezione è fatta di pezzi unici ma anche di una serie completa, creando un mondo piccolo e ripetitivo. Gli oggetti della collezione diventano un modo per sentirsi sicuri al posto delle relazioni con le persone, in un mondo che sembra difficile. Collezionare è come un gioco che ci fa sentire di controllare il tempo, mettendolo in un ciclo che si ripete, come le abitudini. L’orologio, per esempio, rende il tempo una cosa che si può possedere. La collezione, in pratica, prende il posto del tempo vero, annullando l’idea che non si torna indietro e dando l’illusione di controllare la vita e la morte. Se manca un pezzo nella collezione, la rende più viva, mentre finirla può sembrare una specie di fine. La gelosia per gli oggetti mostra quanto siamo legati a loro, come se fossero parte di noi. Anche l’idea di dividere l’oggetto del desiderio, che si vede in certe manie, si ritrova nel collezionismo, dove l’oggetto può essere smontato e diventare un feticcio. Anche se collezionare potrebbe aprirci al mondo, spesso ci chiude in un linguaggio che capiamo solo noi, perdendo la capacità di parlare con gli altri. La collezione rende l’oggetto un simbolo, ma mostra anche quanto sia fragile e possa finire.Il sistema degli oggetti moderni si basa sulla differenza tra il modello e la serie. Prima, le cose di valore erano uniche. Con le fabbriche, il modello è diventato la base per fare tanti oggetti uguali, rendendoli accessibili a tutti, ma creando anche il bisogno di differenziarsi. Ogni oggetto che compriamo sembra unico per piccoli dettagli, facendoci credere di scegliere in modo personale. Questa idea di personalizzazione serve a farci sentire parte del sistema dei consumi, spingendoci a cercare di essere diversi comprando oggetti che sono fatti in serie. Il modello perfetto, che spesso non esiste davvero, ci fa desiderare sempre di più, alimentando la produzione. Gli oggetti di serie, anche se sembrano i modelli, sono fatti peggio e durano poco. La loro qualità è inferiore e lo stile è solo un insieme di cose messe insieme, non armonioso come nel modello. Questa idea di far durare poco le cose serve al sistema, che vuole che compriamo sempre cose nuove. La differenza tra modello e serie mostra anche una differenza tra le classi sociali: il modello rappresenta l’alta società, mentre la serie è per tutti, mostrando una modernità solo apparente. Anche il tempo è diverso: il modello guarda avanti, la serie resta legata a un passato recente. Comprare a rate rende tutto questo ancora più forte. Sembra una cosa che aiuta, ma in realtà ci lega per sempre al sistema di produzione, facendoci usare l’oggetto prima ancora di averlo pagato. Comprare a rate è come una magia che ci fa sentire subito padroni dell’oggetto, nascondendo che siamo dipendenti e dobbiamo sempre inseguire il modello. Così, gli oggetti non sono più solo nostri, ma diventano strumenti per farci sentire parte della società, intrappolandoci in un ciclo infinito di produzione e acquisto.La pubblicità non serve solo a dire come è fatto un prodotto, ma è una parte fondamentale del sistema degli oggetti, diventando essa stessa qualcosa che consumiamo. Anche se pensiamo di non farci influenzare, siamo sensibili al fatto che la pubblicità esiste e ci mostra una società che sembra darci tutto. La pubblicità funziona come Babbo Natale: non crediamo del tutto al prodotto, ma crediamo alla storia che ci racconta. Sentiamo dentro di noi il bisogno infantile di essere premiati e protetti, dove la società, con la pubblicità, sembra un genitore che capisce e soddisfa i nostri desideri. La pubblicità usa spesso immagini di madri e promette un benessere totale per farci sentire parte di una società rassicurante. Aggiunge agli oggetti un “calore” umano che li rende desiderabili anche oltre il loro uso. Quindi, consumiamo la pubblicità stessa, più che essere influenzati da essa. La pubblicità, mostrando sempre immagini e promesse, crea l’illusione di essere liberi. In realtà, ci spinge a desiderare oggetti uguali per tutti, creando una competizione tra le persone che porta a essere tutti uguali. L’idea che possiamo realizzarci comprando cose è un modo per controllarci, spingendoci a scegliere in modo superficiale, che serve solo al sistema che produce. La pubblicità non è un linguaggio vero e proprio, ma un insieme di segni che ci classifica in base a quello che compriamo, cioè al nostro status sociale. Questo sistema, anche se sembra dare a tutti gli stessi criteri per farsi riconoscere, aumenta la voglia di essere diversi e mantiene una gerarchia basata su quello che si consuma. L’individuo è definito e limitato da quello che compra. Comprare, alla fine, non è solo soddisfare bisogni, ma è un gioco di segni che definisce la nostra cultura, dove il rapporto con gli oggetti diventa un sostituto e ci fa sentire estranei a noi stessi.Riassunto Lungo
1. La Casa Funzionale: Un Nuovo Ordine di Oggetti
L’Arredamento Tradizionale e la Società Patriarcale
L’arredamento tradizionale rispecchia un modello di famiglia e di società di tipo patriarcale. In questo modello, la sala da pranzo e la camera da letto rappresentano i punti focali della casa. I mobili che caratterizzano questo stile sono spesso grandi e pensati per una sola funzione specifica. Questi elementi contribuiscono a definire uno spazio domestico chiuso e organizzato in modo gerarchico. Questo tipo di arredamento non è solo una scelta per organizzare lo spazio, ma diventa il simbolo di un ordine morale ben preciso. Ogni oggetto presente nella casa sembra rappresentare le relazioni tra le persone e assume un significato simbolico profondo. In questo modo, la casa stessa diventa una rappresentazione concreta dell’idea di famiglia unita e integrata nella società.L’Arredamento Moderno e la Risposta alla Mancanza di Spazio
Con i cambiamenti della società, si diffonde un nuovo modo di arredare: l’arredamento moderno. In questo stile, compaiono soluzioni come i letti che si nascondono, i tavoli che cambiano forma e i mobili che si possono combinare in diversi modi. La caratteristica principale di questi nuovi arredi è la funzionalità, che nasce come risposta al problema della mancanza di spazio nelle case moderne. Inizialmente, però, l’arredamento moderno appare più come una soluzione di emergenza che come un vero cambiamento nel modo di pensare la casa. Si tratta di una semplificazione delle forme tradizionali, ma senza una vera e propria riorganizzazione dei significati simbolici degli oggetti. Gli oggetti moderni, essendo più facili da spostare e adattabili, offrono una maggiore libertà all’individuo rispetto ai legami familiari. Questa libertà, però, riguarda principalmente l’uso pratico degli oggetti, e non un cambiamento profondo nel loro significato simbolico.L’Arredamento Modello e l’Organizzazione Pratica
Successivamente, si afferma l’arredamento modello, che propone elementi singoli e diverse tipologie di sedute. Questo approccio supera l’idea dell’oggetto legato a una sola funzione, puntando invece su una organizzazione più pratica dello spazio. I valori simbolici e legati all’uso tradizionale degli oggetti lasciano il posto a valori più legati all’organizzazione. Gli oggetti diventano quasi dei pezzi di un gioco strategico, perdendo la loro funzione di simboli di relazioni personali profonde. Le pareti e le stanze della casa si aprono, e la luce naturale diventa un elemento fondamentale per definire lo spazio in modo uniforme. In questo contesto, gli oggetti perdono la loro importanza simbolica tradizionale.L’Evoluzione del Colore e dei Materiali
Anche il colore subisce una trasformazione. Inizialmente, il colore era associato a significati psicologici e morali. Poi, si passa a una fase in cui i colori vengono percepiti come “naturali” e delicati, fino ad arrivare al colore funzionale. Questo colore funzionale è astratto, fatto di toni caldi e freddi, e diventa uno strumento per organizzare l’ambiente. Anche i materiali cambiano: il legno naturale, carico di significati simbolici, viene sostituito da materiali sintetici, che possono assumere diverse forme e significati a seconda del contesto culturale in cui vengono utilizzati. Il vetro emerge come il materiale ideale di questo nuovo approccio, simbolo di trasparenza, di un rapporto ambiguo tra vicinanza e distanza, e di purezza funzionale.La Forma Funzionale e la Tecnica
Le forme degli oggetti funzionali diventano lineari, semplici da usare e progettate per evitare sforzi. L’azione umana viene ridotta al minimo, limitandosi al controllo degli oggetti. La riduzione delle dimensioni degli oggetti tecnologici è un esempio di come si cerca di organizzare lo spazio funzionale in modo efficiente. La forma diventa l’aspetto più importante, nascondendo la perdita di significato simbolico che era legata al gesto tradizionale. La funzionalità diventa essa stessa una forma di estetica, creando una sorta di mito in cui gli oggetti, sempre più complessi, finiscono per influenzare il comportamento delle persone. Questo crea l’immagine di un mondo dominato dalla tecnica e dall’efficienza assoluta.Ma è davvero superata la dimensione simbolica nell’arredamento funzionale, o si tratta piuttosto di una sua trasformazione e rielaborazione in chiave contemporanea?
Il capitolo descrive un’evoluzione dell’arredamento che culmina nella “forma funzionale” e nella “tecnica”, quasi a suggerire una completa scomparsa dei significati simbolici tradizionali. Tuttavia, questa visione potrebbe risultare eccessivamente dicotomica: la funzionalità stessa non potrebbe essere interpretata come un nuovo tipo di simbolismo, legato all’efficienza, alla razionalità e a una certa idea di progresso tecnologico? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare il campo della semiotica e della sociologia della cultura materiale, per comprendere come gli oggetti, anche quelli più moderni e apparentemente “funzionali”, continuino a veicolare significati culturali e sociali, seppur in forme nuove e complesse. Autori come Roland Barthes, con i suoi studi sui miti moderni, o studiosi del design come Victor Margolin, potrebbero offrire strumenti concettuali utili per analizzare più a fondo questa questione.2. Il Doppio Valore degli Oggetti: Funzionalità e Anacronismo
La Funzionalità nel Sistema degli Oggetti
Il sistema degli oggetti si basa sull’idea di funzionalità. Questa parola però ha un significato più ampio del semplice utilizzo pratico di un oggetto. La funzionalità indica la capacità di un oggetto di inserirsi in un sistema più grande, diventando un simbolo all’interno di un ordine astratto. Questo modo di intendere la funzionalità è diverso da quello tradizionale, che si concentrava sull’uso principale dell’oggetto, sui bisogni fondamentali e sul significato simbolico. Nel mondo moderno, la funzionalità viene spesso associata all’idea di “naturalezza”.La “Storialità” degli Oggetti Antichi
Anche gli oggetti antichi, che sembrano lontani da questa idea di funzionalità, in realtà vi rientrano. Negli oggetti moderni parliamo di funzionalità, mentre in quelli antichi parliamo di “storialità”. Un oggetto antico ci parla del tempo passato e dell’idea di origine. Non ha una funzione pratica immediata, ma la sua esistenza stessa è importante. Risponde al nostro bisogno di cose autentiche e di legami con un passato lontano, rappresentando un valore simbolico che va oltre l’utilità.Il Desiderio di Autenticità e il Valore degli Oggetti Antichi
Il desiderio di avere oggetti antichi dimostra che sentiamo la mancanza delle origini e che siamo alla continua ricerca di cose autentiche. Questo desiderio nasce da un bisogno psicologico di tornare all’infanzia e a un’idea di nascita. In questo senso, l’oggetto antico diventa come una “foto di famiglia”, un simbolo di un passato rassicurante. Il restauro degli edifici antichi, molto diffuso oggi, ci fa capire che sentiamo il bisogno di unire l’autenticità con la funzionalità, di collegare il presente con la storia.La Dualità Culturale e il Significato degli Oggetti
La presenza contemporanea di oggetti funzionali e oggetti antichi nella vita di tutti i giorni mette in luce una divisione culturale. Le società meno sviluppate vedono gli oggetti funzionali come simboli di progresso e potenza. Al contrario, le società industrializzate cercano negli oggetti antichi un legame con le origini e l’autenticità. Il mercato dell’antiquariato sfrutta questo desiderio di valore ereditario e importanza sociale. In conclusione, sia gli oggetti funzionali che quelli antichi fanno parte di un sistema culturale complesso, che riflette un contrasto tra modernità e tradizione, funzionalità e simbolo.È davvero così netta la distinzione tra funzionalità e “storialità” degli oggetti?
Il capitolo presenta una dicotomia forse troppo rigida tra oggetti funzionali moderni e oggetti antichi legati alla “storialità”. Questa divisione rischia di semplificare eccessivamente la complessità del valore che attribuiamo agli oggetti. Per comprendere meglio come funzionalità e valore simbolico si intrecciano, sarebbe utile approfondire studi di semiotica e antropologia culturale, esplorando autori come Roland Barthes e Clifford Geertz, che hanno analizzato in profondità i significati culturali degli oggetti e dei simboli nelle società umane.3. Il Fascino Discreto del Collezionismo
La passione per gli oggetti e il senso di proprietà
La passione per gli oggetti nasce dal senso di proprietà privata, un sentimento molto forte e presente nella vita di tutti i giorni. Gli oggetti non servono solo per la loro funzione pratica, ma diventano anche spazi mentali personali, che esprimono il possesso e la passione per essi. Quando si smette di considerare solo l’uso pratico degli oggetti, questi diventano un sistema attraverso cui una persona cerca di costruire un mondo suo, personale e chiuso.Il collezionismo come forma di possesso
La collezione è un esempio chiaro di questo meccanismo. Rappresenta il massimo desiderio di possesso, trasformando oggetti comuni in elementi di un discorso personale. Il collezionismo, che spesso inizia da bambini e poi ritorna da adulti, è collegato a momenti importanti della crescita personale e può essere un modo per compensare delle difficoltà. Non è importante il tipo di oggetti che si collezionano, ma la passione fanatica per il collezionismo in sé. La collezione si muove tra il valore unico di ogni singolo pezzo e l’insieme completo della serie, creando un piccolo mondo privato e ripetitivo.La collezione come rifugio sicuro
Gli oggetti da collezione diventano un sostituto rassicurante delle relazioni con le altre persone. Offrono sicurezza in un mondo che può sembrare pieno di problemi e conflitti. La collezione è come un gioco ripetitivo che permette di controllare il tempo, inserendolo in un ciclo continuo e regolare, simile alle abitudini. L’orologio, ad esempio, rende il tempo qualcosa di concreto e gestibile, trasformandolo in un oggetto che si può possedere.Il tempo e la collezione
In conclusione, la collezione prende il posto del tempo reale, eliminando l’idea che il tempo passa inesorabilmente e dando l’illusione di poter controllare il ciclo della vita e della morte. Se manca un oggetto nella collezione, questo oggetto rimane in qualche modo vivo e desiderabile. Invece, quando la collezione è completa, può sembrare che sia finita anche una parte importante della vita del collezionista. La gelosia, che è la forma più estrema del possesso, mostra quanto il rapporto con gli oggetti sia legato al proprio ego. Gli oggetti diventano come un’estensione di sé stessi. Anche nelle perversioni, dove l’oggetto del desiderio è frammentato, si può trovare un collegamento con il collezionismo, in cui l’oggetto può essere diviso e ridotto a feticcio.I limiti del collezionismo
Anche se una collezione può aprirsi alla cultura e alla società, spesso rischia di chiudersi in un linguaggiocomprensibile solo a chi colleziona, perdendo la capacità di comunicare con il mondo esterno. La collezione, pur dando importanza all’oggetto come simbolo, mostra anche quanto gli oggetti siano fragili e destinati a finire.Ma siamo sicuri che il desiderio di distinguersi sia sempre e solo una trappola del sistema consumistico, o non c’è anche una spinta umana più profonda verso l’individualità?
Il capitolo sembra presentare una visione un po’ semplicistica del desiderio di distinzione, quasi fosse unicamente indotto dal sistema consumistico per perpetuare se stesso. Sarebbe utile esplorare se questa spinta all’individualità non possa avere radici più profonde nella psicologia umana e nella società. Approfondimenti in antropologia culturale e psicologia sociale potrebbero offrire una prospettiva più complessa e articolata sul tema, considerando autori come René Girard e Erving Goffman, che hanno studiato i meccanismi del desiderio mimetico e la costruzione dell’identità sociale.5. L’abbraccio materno della pubblicità
La pubblicità come oggetto culturale
La pubblicità non si limita a dare informazioni sui prodotti. È molto di più: è una parte fondamentale del sistema in cui viviamo, fatto di oggetti e di cultura. La pubblicità stessa diventa un prodotto culturale che viene consumato. Anche se pensiamo di non farci influenzare dalla pubblicità, in realtà ne siamo attratti perché la vediamo come un fenomeno culturale. In questo modo, consumiamo l’immagine di una società che ci appare come generosa, sempre pronta a darci ciò di cui abbiamo bisogno.La dinamica infantile della pubblicità
La pubblicità funziona in modo simile a Babbo Natale. Non crediamo davvero a tutto quello che la pubblicità dice sui prodotti. Però, ci piace la storia che la pubblicità racconta intorno a questi prodotti. Così, senza accorgercene, accettiamo un meccanismo infantile di piacere e protezione. La società, attraverso la pubblicità, si presenta come una madre affettuosa che sa cosa desideriamo e ci accontenta.La retorica materna e il comfort
La pubblicità usa spesso immagini di madri e promette un benessere totale per convincerci. Il suo scopo è farci sentire parte di un sistema sociale che ci fa sentire sicuri e protetti. La pubblicità aggiunge agli oggetti una qualità umana, un “calore” che li rende più attraenti. Quindi, quando pensiamo di comprare un prodotto, in realtà stiamo consumando la pubblicità stessa, più che farci condizionare da essa.L’illusione di libertà e il conformismo
La pubblicità ci mostra continuamente immagini e promesse, facendoci credere di essere liberi. Ma in realtà, la pubblicità indirizza i nostri desideri verso prodotti sempre uguali. In questo modo, ci spinge a competere con gli altri per avere questi oggetti, ma finiamo per diventare tutti uguali nel nostro modo di consumare. L’idea che possiamo realizzarci comprando oggetti è solo un modo per controllarci. Ci fa credere di essere liberi di scegliere, ma questa libertà è solo superficiale e serve solo a far funzionare il sistema di produzione.La pubblicità come codice sociale
La pubblicità non è un vero linguaggio, ma un insieme di simboli. Questi simboli servono a mettere le persone in categorie e a creare una gerarchia in base a ciò che possiedono, cioè al loro “standing” sociale. Anche se questo sistema sembra uguale per tutti, in realtà aumenta il desiderio di essere diversi dagli altri e mantiene una gerarchia basata sul consumo. In questa gerarchia, le persone vengono definite e limitate dai prodotti che comprano. In conclusione, il consumo non è solo soddisfare i bisogni, ma è un modo per manipolare i simboli che definiscono la nostra cultura. In questa cultura, il rapporto con gli oggetti diventa qualcosa che sostituisce i veri rapporti umani e ci allontana da noi stessi.È davvero la pubblicità una “madre affettuosa” che ci manipola infantilmente, o questa è una visione eccessivamente semplicistica che ignora la complessità delle risposte individuali e culturali alla pubblicità?
Il capitolo presenta una visione della pubblicità come forza manipolatrice quasi onnipotente, riducendo gli individui a consumatori passivi. Ma è davvero così univoca la relazione tra pubblicità e pubblico? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile esplorare le teorie sociologiche del consumo e della cultura, ad esempio approfondendo il lavoro di autori come Bourdieu, per comprendere come le persone interpretano e usano la pubblicità in modi diversi, spesso attivi e selettivi.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]