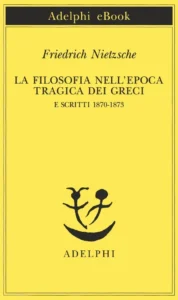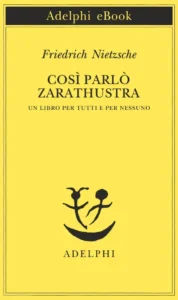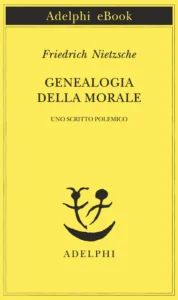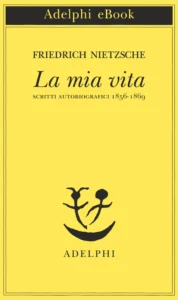1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il servizio divino dei greci” di Friedrich Nietzsche ti porta a scoprire come funzionava davvero la religione greca antica, andando oltre l’immagine classica. Non è solo una questione di dèi sull’Olimpo, ma di pratiche concrete nei santuari greci e templi greci. Vedrai come i sacrifici greci e i riti greci erano centrali, ma anche la differenza tra oggetti sacri e semplici tesori greci come quelli nel Partenone. Il libro esplora le immagini divine greche, dalle forme più antiche e misteriose alle statue più famose, e come non tutte fossero usate per il culto diretto. Si parla anche di luoghi meno noti ma fondamentali, come le tombe greche e le vie sacre che collegavano città e luoghi di culto. Scoprirai le figure chiave come sacerdoti greci e manteis, e l’importanza degli oracoli greci come Delfi. Un aspetto super interessante è l’analisi di Nietzsche su come la religione greca conservi tracce di credenze più primitive, quasi magiche, un’idea che viene dalle sue lezioni di filologia a Basilea. È un viaggio affascinante nelle radici profonde e a volte oscure del culto greco, che ti fa vedere l’antica Grecia con occhi diversi.Riassunto Breve
I templi greci hanno funzioni diverse, alcuni per preghiere individuali con cerimonie esterne, altri per grandi assemblee come i *megara* legati a culti ctoni. Esiste una distinzione tra templi di culto con altari e apparato sacrificale, templi per feste e depositi, e quelli solo per tesori (*thesauroi*) e doni (*anathema*). Gli *anathema* sono dediche, mobili e alienabili, gestite dallo Stato, mentre ciò che è consacrato (*hidrysis*) è inalienabile proprietà della divinità. Il Partenone è considerato più un tesoro di Stato (*thesauros*) e luogo per processioni (*pompeion*) che un tempio di culto primario per Atena Parthenos, la cui statua crisoelefantina è un *anathema* e riserva finanziaria. Le immagini divine evolvono da forme semplici come pali di legno (*xoana*) e pietre (*agalmata*) a rappresentazioni antropomorfe più tarde; la sacralità risiede spesso nell’aspetto non del tutto umano. Gli strumenti del culto includono il tavolo sacro (*hiera trapeza*) per offerte senza sangue all’interno della *cella* e l’altare (*bomos*) per sacrifici cruenti all’esterno. Le tombe (*taphoi, mnemata*) sono spostate fuori dalle città per purezza, con vari tipi di monumenti; le tombe degli eroi (*heroa*) hanno santità superiore e possono trovarsi in recinti sacri. I templi possono racchiudere tombe sacre, suggerendo un legame tra l’origine dei templi e i luoghi di sepoltura, con un passaggio dal culto dei “dèi mortali” al culto delle divinità viventi. Strade artificiali, le “vie sacre”, collegano città e santuari per processioni e trasporto di oggetti sacri, spesso seguendo percorsi mitici e includendo tombe lungo il tragitto, gestite dallo Stato. Il panorama religioso include sacerdoti (legati a templi specifici), esegeti (interpreti del diritto sacro), manteis (indovini che interpretano segni) e khrēsmologoi (profeti ispirati). Siti oracolari come Delfi e Dodona uniscono funzioni sacerdotali e divinatorie, usando vari metodi come vapori, sorgenti, fuoco, sogni o incubazione (dormire in un luogo sacro) e necromanteia (evocazione dei morti). Accanto alle strutture sociali, esistono associazioni religiose laiche (*orgeoni, tiasoti*) dedicate a culti specifici, e gruppi professionali come gli artisti dionisiaci (*technitai*) che ottengono privilegi statali. L’accostamento al sacro richiede purificazione con acqua, fuoco, suffumigi, per rimuovere l’impurità derivante da contatto con morte, malattia, o atti come l’omicidio; la purificazione è distinta dall’espiazione. I riti solenni includono l’incoronazione e l’uso di oggetti sacri. Il rapporto con gli dèi si basa su offerte e sacrifici, che possono essere pasti comuni o sacrifici di annientamento. La religione greca si fonda su credenze animistiche e un “pensiero impuro” primitivo, con pratiche magiche e superstizioni, dove le interazioni con le divinità sono viste come negoziati. Questo deriva da studi etnologici che mostrano “sopravvivenze” di strati culturali più antichi. Il culto conserva uno stadio pre-omerico, con il rito come elemento stabile e antico, mentre mito ed epica sono interpretazioni successive. Omero contribuisce a razionalizzare la religione, ma gli elementi antichi e oscuri sopravvivono. La religiosità greca è una tensione tra spirito e superstizione, una contraddizione che si manifesta anche nella filologia che idealizza la cultura greca pur scoprendo le sue origini materiali. Queste osservazioni si basano su studi e lezioni, come quelle di Nietzsche a Basilea, che combinano fonti esistenti con analisi originali, riflettendo un approccio che si avvicina all’etnologia e all’antropologia per comprendere il mondo antico.Riassunto Lungo
1. Santuari, Tesori e Immagini Divine nell’Antica Grecia
I templi nell’antica Grecia servono a diversi scopi. Molti permettono l’accesso solo a poche persone per preghiere e sacrifici individuali, mentre le cerimonie più importanti si svolgono all’esterno, davanti all’altare. Esistono anche templi pensati per ospitare grandi assemblee, specialmente quelli legati ai misteri, chiamati megara. Questo termine significa “dimora dei signori divini” e si riferisce spesso a culti legati alla terra, i culti ctoni. Un esempio famoso è il Telesterion di Eleusi, dedicato alla dea Demetra, costruito appositamente per accogliere molte persone durante le celebrazioni.Le diverse funzioni dei templi
È possibile distinguere i templi in base alla loro funzione principale. Ci sono quelli dedicati al culto vero e proprio, che includono altari per i sacrifici e tavoli per le offerte. Altri templi sono usati per feste che non sono strettamente religiose o servono come luoghi dove conservare tesori. Un terzo tipo sono i templi destinati unicamente a contenere tesori (thesauroi) e doni votivi (donaria). I templi di culto hanno una consacrazione specifica che li rende sacri e sono dotati di tutto il necessario per i sacrifici. Gli altri tipi di edifici, anche se all’interno di un’area sacra, sono considerati anathema, cioè oggetti o strutture donate alla divinità, e la loro funzione principale è quella di deposito o ornamento, non di culto attivo.Consacrato e dedicato: una distinzione fondamentale
Esiste una differenza importante tra ciò che è consacrato (hidrysis) e ciò che è dedicato (anathema). Ciò che è consacrato è una proprietà stabile della divinità, inalienabile, che non può essere spostata o usata per altri scopi. Ciò che è dedicato, invece, è una proprietà mobile e alienabile, anche se è posta sotto la protezione divina all’interno del recinto sacro (temenos). Lo Stato greco spesso gestisce i tesori conservati nei santuari, considerandoli a volte come veri e propri tesori statali. I funzionari incaricati di gestire questi beni sono spesso figure politiche, non sacerdoti. Gli anathema possono essere oggetti di vario tipo, dai doni preziosi alle opere d’arte, e la loro importanza può dipendere dalla loro posizione all’interno del santuario. La dedicazione di un oggetto o di una struttura spetta allo Stato o a privati, mentre la consacrazione per il culto è compito dell’autorità sacerdotale.Il Partenone: un esempio di tesoro di Stato
Il Partenone ad Atene è un esempio che ha generato molte discussioni tra gli studiosi. Non è considerato un tempio di culto per la dea Atena Nike, il cui culto si svolge in un altro luogo sull’Acropoli. La sua architettura in stile dorico, che non era tipica dei santuari nazionali attico-ionici, sembra confermare questa interpretazione. Il Partenone funzionava piuttosto come tesoro di Stato (thesauros), un luogo di partenza per le processioni (pompeion) e un tempio usato durante le feste agonistiche, come le Grandi Panatenee. Anche la grande statua di Atena Parthenos, fatta d’oro e avorio (crisoelefantina), non era un’immagine di culto inalienabile. Era invece un tesoro dello Stato, un anathema realizzato con l’oro ricavato dal bottino della battaglia di Salamina. La piccola statua della Vittoria (Nike) che Atena tiene in mano simboleggia Atena come colei che dona la vittoria, non come la dea Atena Nike stessa. L’oro della statua rappresentava una riserva finanziaria per lo Stato, che poteva essere utilizzata in caso di estrema necessità.Le immagini divine e la loro evoluzione
Le immagini delle divinità hanno origini molto antiche, legate inizialmente al culto di elementi naturali come alberi, pietre e animali. Queste forme primitive precedono le rappresentazioni umane. Le prime immagini fisse erano spesso semplici pali di legno (xoana) o pietre di varie forme (agalmata, obelischi, colonne), mentre le immagini che potevano essere spostate erano a volte scettri o lance. Le rappresentazioni con forme umane sono comparse più tardi e inizialmente erano viste con una certa cautela. La sacralità di un’immagine risiedeva spesso nel suo aspetto non del tutto umano o avvolto nel mistero. Le immagini di culto più antiche mantenevano forme tradizionali e venivano riprodotte in modo fedele. L’arte della scultura più avanzata, influenzata da culture come Fenici, Egizi e Assiri, si sviluppò principalmente per creare anathema e decorazioni nei santuari, non per le immagini di culto principali.Strumenti e pratiche del culto
Gli strumenti essenziali per il culto includono il tavolo sacro (hiera trapeza), usato per le offerte senza spargimento di sangue all’interno della cella del tempio, e l’altare (bomos), dove si svolgevano i sacrifici cruenti all’esterno. In molti templi si trovavano anche fuochi che ardevano continuamente o lampade sempre accese, che venivano spente solo in occasioni rituali di purificazione.Le tombe: luoghi sacri e monumenti
Le tombe (taphoi, mnemata) erano in origine situate all’interno delle case, ma in seguito furono spostate fuori dalle città per ragioni di purezza rituale. Esistono vari tipi di monumenti funerari, che vanno da semplici cumuli di terra a stele decorate, colonne, edifici che imitano la forma di un tempio (naidia, heroa) e tavole di pietra. Le tombe private sono considerate religiosum, ovvero luoghi legati al rispetto dei defunti e alle pratiche familiari. Le tombe degli eroi (heroa), invece, il cui culto è organizzato e promosso dallo Stato, possiedono un grado di santità superiore (sacer) e potevano anche essere collocate all’interno dei recinti sacri delle città. Diverse tecniche costruttive e decorative si manifestano nelle tombe rupestri e in costruzioni come i tholoi, che mostrano la varietà delle pratiche funerarie nel mondo greco.Se l’Athena Parthenos era un “tesoro di Stato” alienabile, come si spiega il suo ruolo centrale e la sua innegabile sacralità nel cuore del santuario più importante di Atene?
Il capitolo presenta una distinzione netta tra ciò che è consacrato per il culto e ciò che è dedicato come tesoro o ornamento, usando il Partenone e la statua crisoelefantina di Atena Parthenos come esempio di quest’ultima categoria. Tuttavia, questa categorizzazione, pur corretta dal punto di vista della proprietà e della gestione, rischia di semplificare eccessivamente la complessa realtà del sacro nel mondo greco. La statua, sebbene proprietà dello Stato e riserva finanziaria, era pur sempre l’immagine della divinità posta nell’edificio più imponente dell’Acropoli, oggetto di venerazione e fulcro simbolico della città. La sua funzione non era meramente quella di un lingotto d’oro monumentale. Per comprendere appieno queste sfumature e la tensione tra funzione pratica e significato religioso, è essenziale approfondire gli studi sull’architettura sacra greca, la storia religiosa ateniese e l’interazione tra sfera politica e religiosa. Autori come Walter Burkert o Robin Osborne offrono prospettive fondamentali su questi temi, evidenziando come le categorie moderne possano non aderire perfettamente alla percezione antica del sacro.2. Sentieri del Sacro e Dimore dei Morti
I templi antichi spesso custodiscono tombe sacre di eroi, demoni o divinità, come nel caso della tomba di Zeus a Creta. Esiste l’idea che i templi stessi abbiano avuto origine dalle tombe, con il termine greco “casa” (νεώς) usato forse in modo delicato per indicare una sepoltura. In origine, i riti religiosi si svolgevano in queste strutture legate alla sepoltura, dedicate a “dèi mortali”. Col tempo, i simboli delle divinità celesti vennero associati a questi luoghi sacri delle tombe, e il loro culto si spostò gradualmente in queste antiche dimore, diventando via via più importante del culto dei morti. Questo processo portò al passaggio dal semplice simbolo alla statua (simulacro), e il tempio si trasformò nella stabile dimora della divinità considerata vivente.Le Vie Sacre
La costruzione di strade non naturali serve principalmente a guidare i cortei festivi verso i santuari e a rendere più facile il trasporto di oggetti importanti per i riti. Queste “vie sacre” collegano le città ai luoghi di culto più significativi. Per realizzarle, si spianava il terreno e si rendevano lisce le carreggiate per permettere il passaggio agevole dei carri usati nelle processioni. Le vie sacre seguono spesso percorsi legati a storie di divinità o segnano i confini di aree considerate sacre. Lungo questi cammini si trovano punti di sosta che ricordano eventi importanti della mitologia o monumenti come tombe, a volte considerate luoghi capaci di guarire.Le Tombe Lungo le Strade
Le tombe sono un elemento caratteristico del paesaggio fuori dalle città, lungo le strade di campagna. Lo spazio a lato del sentiero è di solito di proprietà dello Stato, che gestisce i luoghi destinati alla sepoltura. Questi siti, scelti in posizioni appartate e considerate pure, sono delimitati con cura, spesso con muri e piccoli giardini. La struttura di una tomba include una base, un altare (βωμóς) che sostiene il sarcofago (μνημεῖον), e una facciata decorata con sculture (εἰδοφóρος). Le tombe situate appena fuori dalle mura cittadine godono di particolare rispetto. Era usanza seppellire insieme i soldati caduti in battaglia in luoghi specifici, come il monumento collettivo sulla strada del Cerameico ad Atene, gestito dalle autorità pubbliche. Le tombe di eroi o figure considerate protettrici venivano poste davanti alle porte della città per offrire protezione. Anticamente, le tombe dei fondatori di una città si trovavano nella piazza principale (agorà), mentre nelle città costruite in epoche più recenti, segnano il limite esterno dell’area urbana.Ma siamo sicuri che i templi siano solo dimore nate dalle tombe?
Il capitolo suggerisce una derivazione quasi esclusiva dei templi dalle strutture funerarie, legandola all’idea di “dèi mortali”. Questa prospettiva, sebbene affascinante, potrebbe non cogliere la complessità delle origini dei luoghi di culto nel mondo antico, che spesso includono altari all’aperto, aree sacre naturali o strutture con funzioni diverse. Per una visione più completa, sarebbe utile esplorare le diverse teorie sull’origine dell’architettura sacra e confrontare le evidenze archeologiche relative a differenti tipi di luoghi di culto. Approfondire la storia delle religioni antiche e l’archeologia dei luoghi di culto, magari leggendo studiosi come Walter Burkert, può offrire prospettive alternative o complementari.3. Sacerdoti, Indovini e Oracoli Greci
Il mondo religioso greco è popolato da diverse figure fondamentali, come i sacerdoti, gli esegeti, i manteis e i khrēsmologoi. I sacerdoti sono strettamente legati a un tempio specifico e alla divinità che vi è onorata, mantenendo vivo il legame profondo tra il dio e quel luogo preciso. Essi si occupano di perpetuare questo rapporto attraverso sacrifici e rituali, a volte arrivando a rappresentare temporaneamente la divinità stessa. La posizione di sacerdote poteva essere trasmessa di padre in figlio, scelta tramite elezione o, in rari casi, persino comprata. I sacerdoti traevano il loro sostentamento dalle offerte e dai sacrifici ricevuti. Altro personale era presente per assistere nelle cerimonie e prendersi cura del tempio.Altre Figure Religiose e Divinatori
Gli esegeti hanno il compito di interpretare le leggi sacre e le tradizioni religiose antiche, fornendo consigli su come svolgere riti, purificazioni e su cosa significano i presagi. La loro posizione è considerata meno importante rispetto a quella dei sacerdoti e dei manteis. I manteis, invece, sono indovini capaci di leggere i segni inviati dagli dèi, interpretando sogni, osservando il volo degli uccelli o esaminando le interiora degli animali sacrificati. Quest’arte divinatoria è solitamente una tecnica che si impara, differente dalla profezia che arriva per ispirazione divina. Non mancava un certo scetticismo nei confronti dei manteis, specialmente quando si immischiavano nelle questioni politiche. I khrēsmologoi sono profeti che si sentono ispirati direttamente dalla divinità e comunicano i messaggi divini, spesso usando la poesia; le loro predizioni potevano poi essere messe per iscritto o modificate nel tempo.I Grandi Oracoli
Luoghi come Delfi e Dodona erano noti come siti oracolari, dove si univano le funzioni dei sacerdoti e quelle degli indovini. Questi centri rappresentavano un’autorità importante per quanto riguarda le leggi sacre e la guida che si riteneva provenisse dagli dèi. Delfi, considerato il centro del mondo, ebbe un’enorme influenza sia in ambito politico che religioso, arrivando a condizionare decisioni importanti come la fondazione di nuove città o l’elaborazione di leggi, anche se la sua importanza diminuì con il passare del tempo. Dodona, un sito ancora più antico, si affidava all’interpretazione di segni naturali per le sue predizioni. Negli oracoli si faceva uso di diversi sistemi per ottenere risposte divine, tra cui l’inalazione di vapori, l’uso di sorgenti sacre, l’osservazione del fuoco o l’interpretazione dei sogni.Ma in cosa consisteva, concretamente, questa “nuova visione dei Greci” e del loro “servizio divino” che il capitolo promette?
Il capitolo descrive l’importanza delle lezioni per lo sviluppo intellettuale di Nietzsche e la storia editoriale del volume, ma lascia il lettore all’oscuro sul contenuto effettivo di questa “nuova visione”. Per colmare questa lacuna e comprendere cosa Nietzsche scoprì o teorizzò sul “servizio divino” greco, sarebbe fondamentale approfondire non solo le lezioni stesse, ma anche gli studi di filologi e storici delle religioni antiche che hanno analizzato il pensiero nietzschiano su questi temi. Discipline come la storia delle religioni e l’antropologia del mondo antico, a cui Nietzsche stesso si avvicinò, offrono strumenti essenziali per capire il contesto e l’originalità delle sue idee. Autori che si sono occupati di religione greca o del pensiero di Nietzsche in questo periodo possono fornire il necessario approfondimento.7. Le radici oscure del culto greco
La religione greca affonda le sue radici in credenze molto antiche, legate a un pensiero primitivo basato sull’animismo. Questo modo di pensare, definito “pensiero impuro”, nasce da errori di valutazione e cerca di influenzare la natura e le persone attraverso pratiche magiche e superstizioni. Le interazioni con le divinità in questo contesto sono viste quasi come trattative tra esseri umani, dove si usano sottomissione, offerte o persino l’inganno per ottenere ciò che si desidera.Le scoperte dell’etnologia
Questa visione delle origini primitive della religione greca si basa sugli studi di etnologi come Tylor e Lubbock. Questi studiosi hanno dimostrato che le culture si sviluppano per fasi successive, e le epoche più recenti mantengono spesso tracce, chiamate “sopravvivenze”, delle fasi più antiche. Queste sopravvivenze si possono trovare in aspetti della vita di tutti i giorni, nei giochi, nei proverbi o negli oggetti d’uso comune.Rito e mito: l’eredità del passato
Applicando questa idea alla religione greca, si scopre che essa conserva elementi di una civiltà precedente all’epoca omerica. In questa fase antica, il rito, cioè la pratica religiosa concreta, era l’elemento centrale e più stabile, mentre il mito e le storie sugli dèi erano interpretazioni create in seguito per dare un senso a questi riti. Questa prospettiva si contrappone all’idea che la religione greca sia nata come una pura espressione artistica, libera da ogni legame con la magia o le pratiche primitive.Il ruolo di Omero e la razionalizzazione
Omero ha avuto un ruolo importante nel trasformare la religione greca, rendendo le divinità più simili agli esseri umani e contribuendo a “liberarla” in parte dal terrore primitivo. Tuttavia, gli elementi antichi e oscuri non sono scomparsi del tutto, ma sono rimasti nascosti o integrati nel mito degli dèi dell’Olimpo. Il culto religioso si è poi organizzato in due modi principali: le pratiche magiche sono state ordinate in sequenze precise per cercare di ottenere effetti specifici, e i riti antichi sono stati giustificati con le nuove credenze quando culture diverse sono entrate in contatto. Questi processi hanno portato a compromessi che hanno spesso nascosto il significato originale dei riti.La tensione nella religiosità greca
La religiosità greca è caratterizzata da una costante tensione tra un aspetto più spirituale e le antiche superstizioni. Questi due elementi sono strettamente legati ma allo stesso tempo in contraddizione tra loro. Questa dualità emerge anche negli studi filologici, che da un lato svelano le origini concrete e materiali della cultura greca, ma dall’altro tendono poi a idealizzarla. Comprendere questi aspetti antichi e le “sopravvivenze” nel culto greco permette di vedere la distanza da un passato che a volte è stato idealizzato, ma suggerisce anche che elementi di valore provenienti da epoche lontane possono continuare a esistere e influenzare il presente.Ma l’etnologia e la storia delle religioni non hanno forse superato le visioni evoluzionistiche ottocentesche?
Il capitolo fonda gran parte della sua argomentazione sull’idea di “sopravvivenze” e su un modello di sviluppo culturale per fasi, attingendo a studi pionieristici ma datati di etnologi come Tylor e Lubbock. Questo approccio, pur fondamentale per l’epoca, è stato oggetto di ampie revisioni e critiche nel corso del XX secolo. Definire il pensiero animista come “impuro” o basato su “errori di valutazione” riflette una prospettiva che rischia di apparire giudicante e anacronistica rispetto alle metodologie antropologiche più recenti, che tendono a comprendere le diverse forme di pensiero nei loro contesti culturali specifici senza gerarchie evolutive. Per un quadro più aggiornato e critico, sarebbe utile esplorare la storia del pensiero antropologico e le diverse scuole di interpretazione del fenomeno religioso, che offrono alternative ai modelli evoluzionistici lineari e alla rigida separazione/priorità tra rito e mito.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]