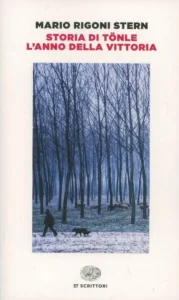1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il sergente nella neve” di Mario Stern è un libro che ti porta dritto nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, sul fronte russo, raccontando la terribile ritirata di Russia vista con gli occhi di un alpino. Immagina il freddo, quello vero, che ti entra nelle ossa mentre sei bloccato sul fiume Don, in trincea, con la neve alta e i russi a due passi. Il libro descrive la vita quotidiana lì, fatta di stenti, cameratismo tra i soldati, e la domanda che torna sempre: “Ghe rivarem a baita?”, ce la faremo a tornare a casa? Poi arriva l’ordine di ripiegare, e inizia la marcia nella steppa russa, una fuga disperata nella tormenta, tra villaggi in fiamme e scontri a fuoco. Il racconto ti fa sentire la fatica, la fame, il gelo che non ti lascia mai. Un momento chiave è la battaglia di Nikolajewka, uno scontro durissimo per aprirsi un varco. Ma in mezzo a tutto questo orrore, ci sono anche piccoli momenti di umanità, incontri inaspettati che ti fanno capire che anche in guerra le persone restano persone. È un libro che parla di sopravvivenza, del legame tra commilitoni e del lungo, estenuante cammino del ritorno, una testimonianza cruda e vera dell’esperienza di guerra degli alpini.Riassunto Breve
La vita di un caposaldo italiano sul fiume Don è segnata dal freddo intenso, dalla neve e dalla precarietà, con cibo scarso e la costante presenza di topi e pidocchi. Tra i soldati, per lo più alpini, si vive un forte senso di cameratismo nonostante la fatica e l’incertezza espressa dalla domanda “Ghe rivarem a baita?”. Con l’arrivo di gennaio, la situazione peggiora con notizie di accerchiamento e l’intensificarsi degli attacchi russi, che causano perdite. Arriva infine l’ordine di ripiegare e il caposaldo viene abbandonato in silenzio durante la notte. La ritirata inizia nella tormenta e nel freddo estremo, un cammino faticoso con zaini pesanti e la colonna che spesso perde l’orientamento, costringendo i soldati a nascondere le munizioni in eccesso nella neve. Si incontrano villaggi in fiamme e si cerca riparo, trovando a volte un inaspettato momento di conforto, come una tazza di latte caldo offerta da una famiglia russa. La marcia prosegue in un ambiente caotico, con soldati di diverse nazionalità e civili, nella steppa innevata, segnata dalla stanchezza e dal gelo che intorpidisce le membra, mentre molti uomini si disperdono. La colonna si muove all’interno di una sacca gelata, affrontando scontri continui con le forze russe che difendono i villaggi e le vie di fuga, e la costante ricerca di cibo in mezzo a razionamenti scarsi. La disciplina militare è messa a dura prova, ma la coesione tra i soldati semplici diventa fondamentale per la sopravvivenza. Un momento cruciale è l’assalto al villaggio di Nikolajewka il 26 gennaio 1943 per cercare di rompere l’accerchiamento e raggiungere la ferrovia, un attacco difficile sotto il fuoco nemico che causa perdite, ma che vede anche un episodio di umanità reciproca in un’isba dove soldati russi e italiani condividono cibo. Superata la linea ferroviaria, inizia una lunga marcia di ritorno in condizioni estreme, con il corpo che cede, le scarpe che si deteriorano causando ferite ai piedi, dolori alle ginocchia e dissenteria, e la colonna che si disperde in gruppi più piccoli. Pochi superstiti del battaglione e della compagnia si ritrovano in un punto di raccolta, provati fisicamente. Il cammino prosegue per molti giorni attraverso l’Ucraina e la Russia Bianca, affrontando ancora freddo e tormente, fino all’arrivo della primavera che segna un cambiamento. In attesa del treno per l’Italia, si trova riparo in villaggi, sperimentando un periodo di quiete inaspettata e momenti di normalità con le famiglie russe che accolgono i soldati, condividendo pasti e la routine quotidiana, offrendo un senso di pace dopo le esperienze vissute.Riassunto Lungo
1. L’attesa e l’abbandono sul Don
Un avamposto italiano si trova in un villaggio distrutto sulla riva ghiacciata del fiume Don, nella terra dei cosacchi. Le postazioni e le trincee sono scavate nella scarpata che dà sul fiume. A poca distanza, di fronte, ci sono le postazioni russe. La vita qui è segnata dal freddo intenso, dalla neve costante, dalla presenza di topi e pidocchi che rendono tutto più difficile. Il cibo è scarso e ripetitivo, spesso solo polenta fatta con segala macinata a mano o razioni congelate. Per rendere la vita un po’ meno dura, si cerca di recuperare qualcosa dalle case distrutte del villaggio: una sedia, uno specchio, qualche provvista dimenticata.La vita quotidiana e il cameratismo
La routine quotidiana è fatta di turni di vedetta durante la notte, lavori continui di scavo per migliorare le trincee e il posizionamento di reticolati per la difesa. I soldati, che sono per lo più alpini, affrontano la situazione in modi diversi: alcuni mantengono un atteggiamento allegro, come Tourn, altri sono più chiusi e sembrano prevedere il peggio, come Lombardi, altri ancora mostrano tutta la loro stanchezza e insofferenza, come il soldato soprannominato “il Baffo”. Nonostante le difficoltà e le tensioni inevitabili, c’è un forte legame tra i soldati, un senso di cameratismo e solidarietà che li aiuta ad andare avanti. La domanda che si sente ripetere spesso è “Ghe rivarem a baita?”, un modo per esprimere l’incertezza e la speranza di poter tornare a casa un giorno.Il peggioramento della situazione
Con l’arrivo del mese di gennaio, le condizioni diventano ancora più difficili e la situazione si fa critica. Cominciano a circolare voci insistenti su un possibile accerchiamento delle forze italiane. I soldati russi aumentano la loro attività lungo il fronte e gli attacchi contro il caposaldo diventano più frequenti e violenti. Viene usata anche artiglieria pesante, come i razzi lanciati dalle Katiuscia, che causano distruzione e paura. Purtroppo, si registrano anche le prime perdite significative tra i compagni, come il tenente Sarpi, Lombardi e Marangoni, che cadono durante gli scontri. Le armi vengono tenute pronte, preparate per resistere ai continui assalti nemici.L’ordine di ripiegare
Alla fine, l’attesa finisce con l’arrivo dell’ordine di ripiegare. Il caposaldo è ormai completamente circondato dalle forze nemiche. Il tenente Moscioni, stremato dal freddo e dalla fatica, non è più in grado di comandare e deve essere aiutato a lasciare la posizione, passando il comando ad altri. Si prepara l’abbandono del caposaldo in silenzio, cercando di non farsi scoprire dal nemico. I soldati si muovono a squadre durante la notte. Le munizioni che non possono essere portate via vengono nascoste, mentre gli effetti personali non indispensabili vengono distrutti per non lasciare nulla al nemico. L’ultima squadra lascia la posizione nel buio della notte, proprio mentre inizia a cadere la neve, dirigendosi verso il punto di ritrovo stabilito per iniziare la ritirata.Perché l’ordine di ripiegare è arrivato solo quando il caposaldo era già completamente circondato?
Il capitolo descrive l’ordine di ripiegare arrivato solo quando il caposaldo era ormai completamente circondato. Questo dettaglio solleva interrogativi cruciali sulla pianificazione strategica e sulla gestione delle informazioni da parte dei comandi superiori. Attendere l’accerchiamento prima di ordinare la ritirata suggerisce una grave lacuna nella valutazione della situazione o una mancanza di tempestività decisionale che ha messo a rischio la vita dei soldati. Per comprendere meglio le dinamiche che portarono a situazioni simili sul fronte orientale, sarebbe utile approfondire la storia militare del periodo, la strategia e la logistica dell’esercito italiano durante la campagna di Russia, e le decisioni prese ai più alti livelli di comando. Autori come Giorgio Rochat o Lucio Ceva hanno analizzato a fondo questi aspetti.2. La marcia nella tormenta
La ritirata inizia lasciando il villaggio sul Don, un addio definitivo alla terra russa. La marcia si svolge in condizioni estreme, tra freddo intenso e una tormenta che cresce di intensità. Il peso degli zaini, carichi di munizioni, rende ogni passo faticoso. I soldati cadono nella neve alta e si rialzano con grande difficoltà, mentre il vento gelido e i fiocchi di neve pungono viso e mani come aghi. Si cammina con la testa bassa, uno dietro l’altro, nel silenzio imposto dalla fatica e dalla disperazione.Le difficoltà del cammino
Nella tormenta, la colonna perde l’orientamento, aumentando lo smarrimento e la difficoltà del percorso. Alcuni soldati, stremati dal peso, si staccano dal gruppo per alleggerire il proprio carico, nascondendo le munizioni nella neve. Nonostante la tentazione di abbandonare tutto, si cerca di non lasciare le armi pesanti e le relative munizioni, consapevoli della loro importanza cruciale in caso di un attacco improvviso. Il freddo è così intenso che le mani diventano insensibili, rendendo ogni semplice gesto una sfida.Incontri e brevi soste
Lungo la marcia, si incontrano villaggi in fiamme, la cui luce rossa e inquietante illumina il cielo notturno, testimonianza del conflitto e della distruzione. Nonostante la stanchezza che piega i corpi, la marcia non si ferma, spinta dalla necessità di allontanarsi. In un paese, si cerca disperatamente riparo dal gelo. Molte delle isbe, le tipiche case rurali, sono già occupate dal personale delle retrovie. Tuttavia, un soldato riesce a trovare rifugio in un sotterraneo, condividendo lo spazio con una famiglia russa e altri commilitoni italiani. Qui, riceve una tazza di latte caldo, un piccolo e prezioso momento di umanità e conforto in mezzo alle privazioni assolute della ritirata.Caos e ripresa della marcia
La marcia riprende da un paese in preda al caos. La località è affollata di soldati di diverse nazionalità e civili che saccheggiano i magazzini in fiamme, creando una scena di disordine e disperazione. Si osserva il netto contrasto tra i soldati provati dalla prima linea e il personale dei servizi arretrati, meno segnato dalla battaglia e dalla ritirata. La colonna si snoda nuovamente nella vastità innevata della steppa. Nonostante la lentezza generale imposta dalle condizioni estreme, piccoli gruppi di soldati cercano di avanzare più velocemente, spinti dal desiderio di restare uniti e raggiungere un punto di relativa sicurezza. La fatica e il freddo rimangono compagni costanti e insopportabili del viaggio. Lungo la strada, si incontrano soldati completamente stremati, alcuni dei quali sono costretti ad abbandonare il proprio equipaggiamento, incapaci di portare avanti anche il minimo peso.Il ricongiungimento e il riposo notturno
Gradualmente, il plotone riesce a ricomporsi, ritrovando i compagni che si erano persi nella tormenta. Si raggiunge un altro paese, dove si ritrovano altre unità disperse, un segno che la coesione, per quanto difficile e precaria, non è del tutto perduta. Un maggiore cerca di infondere coraggio nei soldati, ma la vastità della distanza ancora da percorrere è una realtà ineludibile e pesante che grava su tutti. La notte cala, portando con sé un gelo ancora più intenso e penetrante. Si cerca disperatamente riparo in un edificio abbandonato, trovando finalmente un po’ di calore e della paglia su cui potersi stendere per la notte. La stanchezza accumulata è totale, un peso che schiaccia ogni pensiero tranne il desiderio di un breve e agognato riposo.Il capitolo descrive la marcia infernale, ma non ci si chiede chi abbia mandato quei soldati in un simile mattatoio?
Il capitolo si concentra giustamente sull’esperienza vissuta dai soldati, offrendo un quadro potente della sofferenza e della disperazione sul campo. Tuttavia, per comprendere appieno la portata della tragedia descritta, è indispensabile considerare il contesto strategico e politico che portò l’esercito italiano a trovarsi in quella situazione disperata e impreparata. La ritirata non fu un evento isolato, ma la drammatica conseguenza di decisioni militari e politiche prese ai livelli più alti, la cui analisi è fondamentale per individuare le responsabilità. Approfondire la storia militare del Fronte Orientale e la partecipazione italiana, studiando autori come Giorgio Rochat, può fornire le coordinate necessarie per rispondere a questa domanda cruciale.3. Il Cammino nella Sacca Gelata
Una colonna militare si muove nella steppa coperta di neve, cercando di rompere un accerchiamento. Le condizioni sono estremamente difficili, con un freddo intenso, neve alta, stanchezza e fame che mettono a dura prova i soldati. La marcia dura per ore, spesso anche di notte, nella speranza di trovare riparo in isbe abbandonate o già piene di gente. La ricerca di cibo diventa una necessità fondamentale per la sopravvivenza, portando a razionamenti molto scarsi o alla requisizione di animali nei villaggi incontrati lungo il percorso.Gli scontri lungo la via
Durante il cammino, si verificano scontri con le forze russe, che cercano di difendere i villaggi e bloccare le possibili vie di fuga. Vengono usate armi pesanti come mitragliatrici e mortai. Per superare i paesi, la colonna deve a volte aggirarli o attaccare frontalmente, subendo perdite da entrambe le parti. Lungo il tragitto, si vedono i segni dei combattimenti, inclusi i corpi senza vita di soldati e civili.La tenuta dei soldati
In questo caos e nella disperazione, la disciplina militare fatica a mantenersi. Anche alcuni ufficiali mostrano segni di cedimento. In questa situazione difficile, la capacità dei soldati semplici di restare uniti diventa essenziale per riuscire a sopravvivere. Molti uomini, stremati, si allontanano dalla colonna principale, diventando sbandati. Nonostante tutto, la marcia continua, segnata dalla fatica costante, dal gelo che rende insensibili le membra e dalla continua incertezza sul raggiungimento di un luogo sicuro. La speranza di salvezza si alterna a momenti di profonda tristezza e disperazione.[/membership]La descrizione della marcia è vivida, ma chi sono questi soldati e in quale contesto strategico si trovano?
Il capitolo dipinge con efficacia il dramma umano e la fatica fisica della ritirata, ma la mancanza di un contesto più ampio – l’identità delle truppe, l’esercito di appartenenza, la specifica campagna militare e le ragioni strategiche dell’accerchiamento – lascia una lacuna significativa. Comprendere il quadro generale non sminuirebbe la sofferenza individuale, ma la collocherebbe in una dimensione storica e militare precisa, permettendo di valutare meglio le cause e le conseguenze di tale situazione disperata. Per approfondire questo aspetto, è utile studiare la storia militare, in particolare le grandi campagne caratterizzate da ritirate in condizioni estreme. Autori come John Keegan offrono analisi fondamentali sulla natura della guerra e l’esperienza del soldato nel contesto strategico.4. La sacca e il cammino del ritorno
La colonna militare si ferma e subisce attacchi continui, preparandosi per l’assalto decisivo al villaggio di Nikolajewka fissato per il 26 gennaio 1943, con l’obiettivo vitale di raggiungere la ferrovia. L’artiglieria dispone di pochissime munizioni, rendendo l’attacco ancora più rischioso. L’avanzata procede sotto il fuoco incessante del nemico, colpiti da anticarro, mortai e mitragliatrici che causano perdite significative tra le fila. La progressione è estremamente difficile, con molti soldati che esitano di fronte alla violenza dello scontro o cadono feriti sul terreno gelato. Durante questi combattimenti, in un’isba dove si trovano soldati russi armati, si verifica un episodio inaspettato: condividono del cibo con un soldato italiano, un raro momento di umanità reciproca che contrasta con la brutalità circostante.La lunga marcia della ritirata
Dopo aver superato con fatica la linea ferroviaria a Nikolajewka, inizia una lunghissima marcia in condizioni fisiche e ambientali estreme che mettono a dura prova i soldati. Le scarpe si deteriorano rapidamente sul terreno ghiacciato e accidentato, causando ferite dolorose ai piedi che rendono ogni passo una sofferenza. Le ginocchia diventano gonfie e dolenti, mentre la dissenteria si diffonde, debilitando ulteriormente gli uomini già stremati. La colonna, ormai disorganizzata e ridotta, si disperde in gruppi sempre più piccoli nel tentativo di sopravvivere. Lungo il percorso, la desolazione è evidente: si incontrano cannoni abbandonati e muli contesi tra i soldati italiani e quelli tedeschi in ritirata. La marcia è un susseguirsi di stanchezza insopportabile, fame costante e un opprimente senso di isolamento dal resto del mondo.Il ricongiungimento e la speranza del ritorno
Finalmente, si raggiunge un punto di raccolta dove i pochi superstiti del battaglione e della compagnia riescono a ritrovarsi, constatando con dolore quanto il numero di uomini sia drasticamente ridotto rispetto alla partenza. Le condizioni fisiche dei soldati che sono riusciti a raggiungere questo luogo sono profondamente provate dalle privazioni subite. Il cammino prosegue ancora per molti giorni attraverso le vaste distese dell’Ucraina e della Russia Bianca, affrontando ancora il freddo pungente e tormente di neve che sembrano non finire mai. L’arrivo della primavera segna un lento ma atteso cambiamento, con lo sciogliersi della neve che porta un barlume di speranza.Un inatteso periodo di quiete
In attesa del treno che dovrebbe riportarli in Italia, i soldati vengono alloggiati in diversi villaggi lungo il percorso. In un’isba, si sperimenta un periodo di relativa quiete, un’occasione per osservare da vicino la vita quotidiana della popolazione locale. Una famiglia russa accoglie i soldati con semplicità, condividendo con loro i pasti frugali e permettendo di assistere alla loro routine, come il filare la canapa o il cullare teneramente un neonato. Questo ambiente inaspettato offre ai soldati un prezioso senso di pace e normalità dopo le esperienze traumatiche e disumane vissute durante la ritirata.Dato il contesto di una ritirata militare brutale e sanguinosa, come è possibile che il capitolo descriva un “inatteso periodo di quiete” e “normalità” in villaggi russi, con famiglie locali che accolgono i soldati e condividono i pasti?
Il capitolo offre un quadro crudo della sofferenza e della disorganizzazione durante la ritirata, ma il passaggio a un periodo di relativa pace e interazione amichevole con la popolazione russa, sebbene umanamente toccante, appare privo di un adeguato contesto esplicativo. Non viene chiarito come si inserisca questa dinamica nel più ampio scenario di un paese invaso e di un esercito in rotta. Per approfondire le complesse relazioni tra soldati occupanti/in ritirata e popolazioni civili durante la Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale, è consigliabile studiare la storia militare e sociale di quel periodo, e leggere le memorie di chi ha vissuto direttamente quegli eventi. Autori come Eugenio Corti offrono testimonianze fondamentali sull’esperienza italiana in Russia.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]