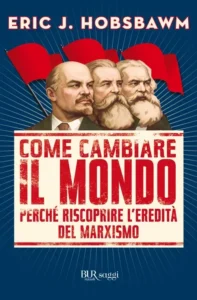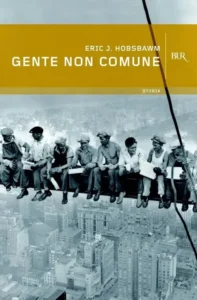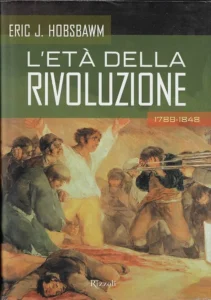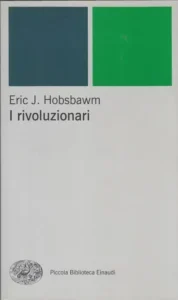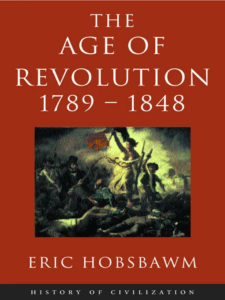Contenuti del libro
Informazioni
“Il secolo breve” di Eric Hobsbawm ti catapulta in un periodo pazzesco, dal 1914 al 1991. Non è solo storia, è come un’unica, enorme onda che ha travolto tutto. Si parte con la catastrofe della Prima Guerra Mondiale che distrugge il vecchio mondo, poi arrivano la Seconda Guerra Mondiale, le crisi economiche senza precedenti e l’ascesa dei regimi totalitari come il fascismo. Sembra finita, ma c’è un’Età dell’Oro incredibile, un trentennio di prosperità e trasformazioni sociali profonde che cambiano la vita di milioni di persone, con l’urbanizzazione di massa, il declino rurale, l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e una vera rivoluzione culturale. Ma dura poco, e arriva la frana, un’epoca di crisi, incertezza e decomposizione, culminata con il crollo dell’Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda. Hobsbawm ti fa vedere come il mondo è diventato globale e interconnesso, non più centrato sull’Europa, con le lotte per la decolonizzazione, l’ascesa e la caduta di ideologie come il comunismo, le rivoluzioni che cambiano volto, la guerriglia che diventa protagonista. È un viaggio attraverso le vite di milioni di persone, le loro migrazioni forzate, i genocidi, ma anche il progresso scientifico e i cambiamenti nell’arte. Alla fine, ti lascia con un sacco di domande su dove stiamo andando, in un mondo pieno di sfide, dalla disuguaglianza alla crisi ambientale, dove le vecchie risposte sembrano inadeguate. È una lettura che ti apre gli occhi su quanto siamo cambiati in così poco tempo.Riassunto Breve
Il ventesimo secolo, chiamato “secolo breve” e durato dal 1914 al 1991, è un periodo storico a sé stante. Inizia con la Prima Guerra Mondiale, che segna la fine del vecchio mondo ottocentesco e l’inizio di un’epoca di grandi problemi, guerre mondiali, crisi economiche e regimi autoritari. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, c’è un periodo di circa trent’anni, l'”Età dell’oro”, dove l’economia cresce molto e la vita delle persone cambia tantissimo, forse più che in altri momenti. Ma questa crescita non dura per sempre. L’ultima parte del secolo è un periodo di crisi e incertezza, che finisce con la caduta dell’Unione Sovietica. Alla fine di questo secolo, il mondo è molto diverso: non è più l’Europa al centro, ma è tutto collegato a livello globale. Le vecchie idee su come vivevano le persone e come stavano insieme si sono un po’ perse, e c’è più spazio per l’individuo singolo. La scienza e la tecnologia sono andate avanti un sacco, ma c’è anche un senso di preoccupazione e meno fiducia nel futuro.Nel terzo quarto del secolo, le società cambiano profondamente. Nei paesi ricchi, sempre meno persone lavorano la terra, e anche nei paesi poveri la gente si sposta dalle campagne alle città, che crescono tantissimo, a volte in modo disordinato. Aumenta molto anche l’istruzione, soprattutto all’università. Le università diventano posti dove nascono nuove idee e dove gli studenti protestano, diventando un gruppo importante e che si fa sentire in diversi paesi. Anche la classe operaia cambia: le vecchie fabbriche diminuiscono, e i lavoratori sono più diversi tra loro, anche per provenienza. La vecchia idea di “coscienza di classe” si indebolisce perché la vita migliora per molti e le persone pensano più alla loro vita privata. Un altro cambiamento enorme è che molte più donne iniziano a lavorare e a studiare all’università. Questo fa nascere una nuova consapevolezza tra le donne e i movimenti femministi, che mettono in discussione i ruoli tradizionali. Tutti questi cambiamenti portano a una specie di “rivoluzione culturale” nei paesi occidentali. La famiglia come la si conosceva prima entra in crisi, aumentano i divorzi, le persone convivono senza sposarsi, e i giovani creano una loro cultura che va oltre i confini dei paesi e che mette in discussione le regole e i valori di prima. Questa rivoluzione, che mette l’individuo al centro, rende meno forti le vecchie regole morali e sociali, creando un senso di incertezza e dividendo un po’ la società.Questi cambiamenti mostrano un mondo in difficoltà. Nei paesi che prima erano colonie, le persone comuni iniziano a farsi sentire, mettendo in crisi le idee delle élite che avevano preso il potere. Questo succede non solo nei paesi poveri, ma anche in quelli ricchi, dove tornano fuori idee nazionaliste e legate all’identità. Il sistema dell’Unione Sovietica, che per molti sembrava un’alternativa al mondo occidentale, promettendo sviluppo veloce e giustizia, si dimostra rigido e poco efficiente, soprattutto nell’agricoltura e per via della troppa burocrazia. La sua economia, gestita dallo stato, non riesce a stare dietro ai cambiamenti e a quello che vuole la gente. La crisi economica degli anni ’70 colpisce tutti, sia i paesi capitalisti che quelli socialisti, e fa capire che gli stati da soli non riescono più a controllare l’economia globale. Nel mondo capitalista tornano problemi come la disoccupazione e la povertà, mentre nel blocco sovietico c’è una situazione di stallo che fa perdere fiducia nel sistema. Le soluzioni economiche usate prima non funzionano più, e la globalizzazione rende gli stati ancora meno potenti. Nei paesi del Terzo Mondo, la situazione politica e sociale rimane difficile, con tante guerre e colpi di stato. La guerriglia, cioè la lotta armata fatta spesso in campagna, diventa un modo comune per cercare di fare la rivoluzione, ma non sempre funziona. Le persone cercano nuove identità e si attaccano ai nazionalismi perché si sentono un po’ persi in un mondo che cambia troppo in fretta. Per cercare di gestire tutto questo, aumentano le organizzazioni internazionali.Negli anni Settanta, molti paesi in Africa e Indocina adottano forme di socialismo, a volte molto diverse tra loro, come i Khmer rossi in Cambogia che fanno cose terribili. In America Latina ci sono movimenti rivoluzionari, a volte guidati anche da religiosi con idee di sinistra. La Rivoluzione in Iran nel 1979 è importante perché è la prima guidata da idee religiose fondamentaliste, non laiche come le altre. Le rivoluzioni di fine secolo mostrano che le vecchie idee politiche non funzionano più tanto, e che la gente comune torna a essere protagonista con proteste che fanno vedere che molti governi non hanno più l’appoggio del popolo, specialmente nelle città che crescono. Il sistema sovietico, anche se sembrava forte, va in crisi negli anni ’70, con un’economia ferma e gente al potere corrotta. I tentativi di riforma di Gorbachev, chiamati “perestroika” e “glasnost”, non riescono a salvare il sistema, anzi, la trasparenza senza un vero cambiamento economico porta al crollo dell’URSS nel 1991. Il comunismo, che non aveva messo radici profonde nella gente, scompare velocemente quando cadono i governi che lo imponevano. Anche l’arte cambia molto: il centro del mondo dell’arte si sposta dall’Europa agli Stati Uniti, e i nuovi mezzi come radio e televisione portano l’arte ovunque. L’arte più “difficile” si allontana dalla cultura popolare, dominata dallo spettacolo e dal consumo. Il modernismo nell’arte finisce, e arriva il postmodernismo, che mette in dubbio tutto, i valori, i giudizi, riflettendo una crisi generale delle certezze. Infine, anche se il Novecento dipende tantissimo dalla scienza, c’è un rapporto strano con essa. La scienza va avanti velocemente, creando tecnologie che la maggior parte delle persone non capisce. Questa mancanza di comprensione fa nascere sospetto e paura verso la scienza, anche se è ovunque e indispensabile.La storia del Novecento è piena di eventi terribili, come l’espulsione di intere popolazioni e lo sterminio di massa, cose per cui si sono dovute inventare parole nuove come “apolide” (chi non ha una patria) e “genocidio”. La Prima Guerra Mondiale apre la strada a queste tragedie, con il massacro degli armeni, e poi l’Olocausto. Queste guerre e rivoluzioni, come quella russa, creano un numero enorme di profughi, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale e la fine delle colonie. La Rivoluzione Russa del 1917 è un evento chiave, nata dalla guerra e diventata un esempio per i movimenti rivoluzionari in tutto il mondo. Non è solo un fatto russo, ma un tentativo di far scoppiare una rivoluzione dei lavoratori in tutto il mondo. Anche se la rivoluzione mondiale non succede subito, l’eco del 1917 si sente in Europa e in Asia, ispirando partiti e movimenti comunisti. Però, il comunismo sovietico, anche se si presenta come migliore del capitalismo, non riesce a dimostrarlo e non risolve i problemi della società. Allo stesso modo, l’idea di un mercato completamente libero e senza regole si dimostra non adatta ad affrontare i problemi di oggi. Il mondo ora è incerto, non c’è un ordine chiaro tra i paesi, e ci sono nuove minacce globali, come la differenza sempre più grande tra ricchi e poveri e il fatto che i mezzi per distruggere sono sempre più accessibili. Le vecchie idee politiche non sembrano funzionare, e le religioni tradizionali non danno risposte convincenti. Di fronte a problemi come l’aumento della popolazione e i danni all’ambiente, si capisce che serve un’autorità pubblica forte e nuova per gestire le sfide del futuro. Il futuro dipende dalla capacità di trovare un equilibrio tra economia, società e ambiente, in un mondo politico complicato e che deve cambiare per non finire male.Le rivoluzioni del Novecento, dopo quella russa, prendono strade diverse: a volte sono colpi di stato fatti dai militari nelle città, a volte lunghe lotte armate nelle campagne. Nei paesi poveri, l’esercito è un’opportunità per i giovani istruiti senza agganci, spesso con idee di sinistra, e guidano rivoluzioni in Egitto, Medio Oriente e America Latina. Anche in paesi sviluppati, come il Portogallo nel 1974, i militari possono rovesciare un governo. Nei paesi industrializzati, però, i militari sono più spesso di destra. Nei movimenti che lottano per l’indipendenza dalle colonie, ex soldati locali che avevano combattuto per i colonizzatori hanno un ruolo importante. La guerriglia, cioè la lotta armata fatta da piccoli gruppi, diventa una strategia rivoluzionaria più tardi, dopo la rivoluzione cubana e l’esempio di Mao in Cina. Mao adatta la guerriglia al contesto cinese, prendendo spunto anche dai banditi sociali. Questa strategia funziona nelle zone dove lo stato non ha controllo, ma meno dove la società è più moderna. La guerriglia cinese non vince subito, costringendo i comunisti a una lunga ritirata. La Seconda Guerra Mondiale dà un grande impulso alla guerriglia come resistenza contro i nazisti. La resistenza armata, spesso guidata dai comunisti, si sviluppa in Europa e Unione Sovietica. La sconfitta dei nazisti porta alla nascita di governi comunisti in Jugoslavia, Albania e Asia orientale, che nascono dalla resistenza, non dal rifiuto della guerra come nella prima ondata rivoluzionaria. Queste rivoluzioni di metà secolo, nate da guerre vinte, sono diverse da quelle classiche. Non c’è un vuoto di potere, ma un controllo chiaro da parte di gruppi legati all’Unione Sovietica. La guerriglia sposta la lotta dalle città alle campagne, e i partiti comunisti diventano eserciti di contadini. Il rapporto tra guerriglieri e popolazione locale è complicato. Nonostante le difficoltà, i comunisti diventano una forza importante in molte parti del mondo. Sembra che la rivoluzione mondiale stia avanzando con la fine delle colonie. Ma il mondo cambia in modi inaspettati. L’epoca delle rivoluzioni trasforma il pianeta, anche se non come previsto da Lenin, aprendo la strada all’indipendenza delle colonie, alla lotta contro il fascismo e alla socialdemocrazia in Europa, che sono risposte e adattamenti al bolscevismo e al nuovo mondo.Il fascismo diventa un fenomeno mondiale negli anni ’30, influenzato da Germania e Italia. In Europa attira soprattutto gruppi di destra, fuori dall’Europa, anche se ci sono idee simili, non diventa un movimento di massa come il comunismo. In America Latina, alcuni leader populisti prendono spunto dal fascismo per mobilitare i poveri contro i ricchi, al contrario del fascismo europeo che reprimeva i lavoratori. Il liberalismo perde forza tra le due guerre non solo per colpa del fascismo, ma anche perché i governi democratici non riescono a gestire bene le crisi economiche e sociali, perdendo l’appoggio della gente. La Grande Depressione mostra i punti deboli della democrazia e favorisce i governi autoritari. L’antifascismo unisce diverse forze politiche contro il nemico comune. La guerra civile spagnola diventa il simbolo di questa lotta globale. Durante la Seconda Guerra Mondiale, l’antifascismo crea un’alleanza tra comunisti e capitalisti, e i movimenti di resistenza in Europa, spesso guidati dalla sinistra, sono molto importanti. Nei paesi non occidentali, la modernizzazione e la lotta contro gli imperi si mescolano con l’antifascismo. Le élite che vogliono modernizzare, ispirate dall’Occidente, devono fare i conti con le tradizioni locali e le resistenze. La modernizzazione è necessaria ma difficile e piena di conflitti.La Prima Guerra Mondiale indebolisce molto il colonialismo, distruggendo alcuni imperi e creando problemi nelle colonie. La Rivoluzione Russa e l’indipendenza dell’Irlanda fanno pensare che l’era degli imperi stia finendo. Ma è la Seconda Guerra Mondiale a cambiare tutto definitivamente, mostrando che le potenze coloniali sono deboli e non possono tornare come prima. La guerra porta alla nascita di due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, e all’inizio della Guerra Fredda. Questo periodo, durato quarantacinque anni, è fatto di tensione continua e paura della bomba atomica, ma stranamente non diventa mai una guerra mondiale vera e propria. Le due superpotenze si dividono il mondo in zone di influenza e mantengono un equilibrio basato sulla paura reciproca. Nonostante le minacce, la Guerra Fredda si stabilizza presto, e le superpotenze evitano lo scontro diretto. Questo periodo di calma relativa a livello internazionale coincide con un’epoca di crescita economica enorme, chiamata “Età dell’Oro”. Tra gli anni ’50 e ’70, l’economia capitalista cresce tantissimo, con un aumento enorme della produzione e del commercio. Ma questa ricchezza non è per tutti, e la differenza tra paesi ricchi e poveri aumenta. La crescita economica danneggia anche l’ambiente, con più inquinamento e sfruttamento delle risorse. La fine della Guerra Fredda, arrivata all’improvviso con la caduta dell’URSS, chiude un’epoca e porta nuove sfide e incertezze in un mondo completamente cambiato.Riassunto Lungo
1. L’Eco Distorto del Secolo Breve
Il Secolo Breve: Un’Epoca Unitari
Il ventesimo secolo viene definito “secolo breve” perché, dal 1914 al 1991, costituisce un periodo storico con caratteristiche proprie, diverse da quelle che lo hanno preceduto e seguito. La Prima Guerra Mondiale segna uno spartiacque netto: la civiltà borghese e liberale dell’Ottocento tramonta, lasciando spazio a un’epoca di grandi difficoltà. Questa fase iniziale, che si protrae fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è segnata da guerre mondiali, gravi crisi economiche e dall’affermarsi di regimi totalitari in diverse parti del mondo. Questi eventi hanno cambiato profondamente la società e la politica.L’Età dell’Oro e le Trasformazioni Profonde
Successivamente, si apre una fase di circa trent’anni chiamata “Età dell’oro”. Durante questo periodo, si verifica una crescita economica notevole e siRealizzano importanti cambiamenti sociali. Queste trasformazioni hanno modificato radicalmente la vita delle persone, forse più di quanto sia accaduto in altri periodi di simile durata. Tuttavia, questa fase positiva si dimostra di breve durata e destinata a esaurirsi rapidamente.La Frana e la Crisi di Fine Secolo
L’ultima parte del secolo breve è caratterizzata da una fase di declino, definita “frana”. Questo periodo è segnato da incertezze, crisi e da una generale sensazione di instabilità, culminata con la fine del sistema sovietico. Questa crisi non riguarda solo l’economia e la politica, ma investe anche la società e la sfera morale, mettendo in discussione i principi fondamentali della civiltà moderna. Si tratta di un periodo di grandi cambiamenti e sfide.Un Mondo Trasformato e Incertezze sul Futuro
Alla fine del Secolo Breve, il mondo appare molto diverso rispetto al 1914. L’Europa non è più al centro del mondo, ma si è affermata una realtà globale e interconnessa. Le tradizionali strutture sociali e i rapporti tra le persone si sono indeboliti, favorendo un individualismo mai visto prima. Il progresso scientifico e tecnologico ha raggiunto livelli straordinari, ma allo stesso tempo si diffondono preoccupazioni e una minore fiducia nel futuro. Il Secolo Breve, iniziato con la tragedia della Prima Guerra Mondiale, si conclude in un clima di incertezza, con interrogativi sul futuro dell’umanità e sul percorso intrapreso.Ma è davvero così univoca e universalmente accettata questa suddivisione del XX secolo in ‘secolo breve’, o rischia di essere una narrazione eccessivamente semplificata e eurocentrica?
Il capitolo presenta una periodizzazione del XX secolo basata sul concetto di ‘secolo breve’. Tuttavia, tale periodizzazione, pur essendo influente, non è esente da critiche. Per approfondire la questione, è utile esplorare la storiografia del XX secolo, confrontando diverse interpretazioni e periodizzazioni proposte da storici come Hobsbawm, ma anche autori che offrono prospettive globali e decoloniali sulla storia del Novecento. Approfondire la storia globale e la critica postcoloniale può offrire una visione più complessa e sfumata del periodo.2. Il Mondo Trasformato: Declino Rurale, Ascesa Urbana e Rivoluzione Culturale
Trasformazioni globali nel terzo quarto del XX secolo
Nel periodo tra il 1950 e il 1975, le società di tutto il mondo hanno subito cambiamenti molto profondi. L’agricoltura, che per secoli aveva rappresentato la base dell’economia e della società, ha iniziato a perdere importanza nei paesi industrializzati. Il numero di persone che lavoravano in agricoltura è diminuito drasticamente. Questo fenomeno non ha riguardato solo i paesi ricchi; anche nelle nazioni più povere, molte persone hanno lasciato le campagne per trasferirsi nelle città. Questo spostamento dalle campagne alle città ha messo in discussione le idee rivoluzionarie che pensavano che il cambiamento dovesse partire dalle campagne.L’urbanizzazione e l’istruzione di massa
Contemporaneamente allo spopolamento delle campagne, le città sono cresciute enormemente. Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, le città si sono ingrandite molto rapidamente, diventando delle metropoli spesso disorganizzate, ma piene di vita. Questo cambiamento demografico è andato di pari passo con un grande aumento dell’istruzione, in particolare dell’università. L’istruzione universitaria è diventata un elemento molto importante nella società e nella politica. Le università sono diventate luoghi di protesta e di nuove idee, e gli studenti sono diventati un gruppo sociale indipendente e internazionale, portando avanti idee politiche nuove e radicali.Cambiamenti nella classe operaia
Anche la classe operaia ha subito trasformazioni importanti. Anche se il numero di operai è rimasto più o meno lo stesso fino agli anni ’80, il tipo di lavoro operaio è cambiato. Le vecchie fabbriche sono diminuite, mentre sono nate nuove forme di produzione industriale. La tradizionale idea di “classe operaia” ha perso forza perché le persone stavano diventando più ricche, la vita privata diventava sempre più importante e la classe operaia stessa diventava sempre più varia al suo interno, anche con persone provenienti da diverse etnie e paesi.Il ruolo delle donne e i movimenti femministi
Un altro cambiamento fondamentale è stato l’aumento delle donne che hanno iniziato a lavorare e a studiare all’università. Questo fenomeno, soprattutto tra le donne sposate, ha portato a una nuova consapevolezza tra le donne e alla rinascita dei movimenti femministi. Questi movimenti hanno messo in discussione i ruoli tradizionali degli uomini e delle donne e le regole della società.La “rivoluzione culturale” e le sue conseguenze
Tutti questi cambiamenti insieme hanno portato a una “rivoluzione culturale” nei paesi occidentali più avanzati. La famiglia tradizionale è entrata in crisi, i divorzi sono aumentati, sempre più coppie hanno iniziato a convivere senza sposarsi e la cultura dei giovani è diventata un elemento autonomo e dominante. Questa cultura giovanile era caratterizzata da un forte spirito internazionale e da una critica radicale delle regole sociali e morali esistenti. Questa rivoluzione culturale, che metteva al centro l’individuo e la sua libertà, ha indebolito i vecchi valori etici e sociali, portando a una sensazione di incertezza e a una divisione della società, con conseguenze complesse e contrastanti per il futuro delle società moderne.Ma è corretto interpretare questi cambiamenti come una “crisi” dei valori tradizionali, o piuttosto come una loro inevitabile evoluzione di fronte a mutate condizioni socio-economiche?
Il capitolo descrive una serie di trasformazioni avvenute nel terzo quarto del XX secolo, culminando in quella che viene definita una “rivoluzione culturale”. Tuttavia, l’uso del termine “crisi” per descrivere i cambiamenti nella famiglia e nei valori potrebbe riflettere un giudizio di valore piuttosto che un’analisi neutrale. Sarebbe utile esplorare se questi cambiamenti rappresentino realmente un declino negativo, oppure una riorganizzazione delle strutture sociali e dei sistemi di valori in risposta a fattori come l’urbanizzazione, l’industrializzazione e l’aumento dell’istruzione. Per approfondire questa prospettiva, si suggerisce di studiare autori come Zygmunt Bauman e Ulrich Beck, che hanno analizzato le trasformazioni della società moderna e la fluidità delle identità e dei valori nell’epoca contemporanea.3. Il Mondo alla Deriva
Le trasformazioni sociali e politiche della fine del Novecento mostrano un mondo in crisi. I modelli di potere e di progresso conosciuti fino ad allora vengono messi in discussione. L’arrivo delle masse nella modernità ha cambiato gli equilibri nei paesi post-coloniali. Le élite occidentali non hanno più il controllo esclusivo, e questo mette in difficoltà le idee e i progetti su cui si basavano i nuovi stati. Questo cambiamento non riguarda solo il mondo islamico o i paesi poveri. Anche i ceti medi e le nazioni industrializzate vivono tensioni legate all’identità e al nazionalismo.Il modello sovietico e la sua crisi
Il modello sovietico di “socialismo reale” nasce dalla Rivoluzione d’Ottobre. Molti lo vedono come un’alternativa al modello occidentale, perché promette industrializzazione rapida e giustizia sociale. Questo sistema si diffonde in diverse aree geografiche. Tuttavia, il sistema sovietico si isola economicamente e politicamente, e presto mostra i suoi limiti. Diventa rigido e inefficiente, soprattutto in agricoltura e nella gestione burocratica. La pianificazione centralizzata, utile all’inizio per forzare l’industrializzazione, non riesce più a gestire economie complesse e a soddisfare i bisogni delle persone.La crisi economica degli anni ’70
Negli anni ’70 scoppia una crisi economica che colpisce sia i paesi capitalisti sia quelli socialisti. Finisce un periodo di crescita economica chiamato “Età dell’oro”. Questa crisi dimostra che gli stati nazionali non sono in grado di controllare le forze economiche globali. Nel mondo capitalista aumentano le differenze sociali, la disoccupazione e la povertà. Nei paesi sovietici l’economia e la politica si bloccano, e questo indebolisce il sistema. Le soluzioni economiche tradizionali, sia quelle di tipo keynesiano sia quelle liberiste, non bastano per risolvere la crisi. La globalizzazione riduce ulteriormente il potere degli stati nazionali.Instabilità nel Terzo Mondo e nuove forme di conflitto
Nel Terzo Mondo, l’instabilità politica e sociale è sempre presente. Ci sono rivoluzioni, guerre civili e colpi di stato. La guerriglia, ispirata a Cuba, diventa la principale forma di lotta rivoluzionaria, ma spesso non porta ai risultati sperati. Le politiche identitarie e i nazionalismi che vogliono l’indipendenza prendono importanza. Questi fenomeni dimostrano un senso di smarrimento e la ricerca di nuove identità in un mondo che cambia velocemente. Per affrontare questi problemi globali, nascono più organizzazioni internazionali e autorità finanziarie che operano al di sopra dei singoli stati. L’obiettivo è gestire un mondo sempre più collegato tra paesi e allo stesso tempo sempre più instabile.Ma è davvero corretto definire “fascismo” quei movimenti latinoamericani che, a differenza del fascismo europeo, si presentavano come difensori dei lavoratori?
Questo capitolo sembra suggerire una certa flessibilità del termine “fascismo”, applicandolo a contesti e movimenti anche molto diversi tra loro. Tuttavia, questa generalizzazione potrebbe oscurare le specificità storiche e ideologiche dei vari movimenti politici. Per comprendere meglio le sfumature e le controversie legate al concetto di fascismo, è consigliabile approfondire gli studi sul fascismo comparato e le opere di autori come Emilio Gentile e Zeev Sternhell, che hanno offerto interpretazioni diverse e spesso contrastanti del fenomeno fascista.8. L’Era delle Trasformazioni: Imperi, Guerra Fredda e Prosperità
La fine del colonialismo dopo le guerre mondiali
La struttura del colonialismo in tutto il mondo ha subito un forte cambiamento con la Prima Guerra Mondiale. Questo evento ha portato alla distruzione di imperi coloniali e ha creato instabilità nei territori dipendenti. La Rivoluzione d’Ottobre e l’indipendenza irlandese hanno rafforzato l’idea che il periodo degli imperi stranieri stesse finendo. Tuttavia, è stata la Seconda Guerra Mondiale a rappresentare una svolta decisiva. Questa guerra ha mostrato quanto fossero deboli le potenze coloniali e quanto fosse impossibile per loro ripristinare il vecchio ordine.La Guerra Fredda e la divisione del mondo
La guerra mondiale ha portato all’affermazione di due superpotenze, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, e all’inizio della Guerra Fredda. Questo periodo è durato quarantacinque anni ed è stato caratterizzato da una tensione continua e dalla minaccia nucleare. Nonostante ciò, non si è mai arrivati a una guerra mondiale diretta. Entrambe le superpotenze hanno accettato di dividere il mondo in zone di influenza, mantenendo un equilibrio di potere basato sulla reciproca capacità di deterrenza.La coesistenza pacifica e l’Età dell’Oro
Nonostante le parole aggressive, la Guerra Fredda si è stabilizzata abbastanza presto. Le superpotenze hanno evitato lo scontro diretto e hanno cercato una convivenza pacifica. Questo periodo di relativa stabilità internazionale è coinciso con un periodo di crescita economica senza precedenti, chiamato “Età dell’Oro”. Tra gli anni ’50 e ’70, l’economia capitalistica mondiale ha avuto un grande sviluppo, con un aumento molto rapido della produzione industriale, del commercio e della produzione agricola.Le disuguaglianze e l’impatto ambientale della crescita
Questa ricchezza, però, non è stata distribuita in modo uguale. Il divario tra i paesi sviluppati e il Terzo Mondo è aumentato. Inoltre, la crescita economica ha avuto conseguenze importanti sull’ambiente, con un aumento dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse naturali. La fine della Guerra Fredda, arrivata inaspettatamente con la caduta dell’URSS, ha segnato la fine di un’epoca. Questo evento ha portato con sé nuove difficoltà e incertezze in un mondo che era cambiato profondamente.L’espressione ‘Età dell’Oro’ non rischia di oscurare le profonde disuguaglianze globali che hanno caratterizzato il periodo post-bellico, suggerendo una prosperità universale che appare contraddetta dalle stesse righe successive del capitolo?
Il capitolo descrive l’Età dell’Oro come un periodo di prosperità diffusa, ma poi riconosce l’aumento del divario tra paesi sviluppati e Terzo Mondo. Questa apparente contraddizione solleva interrogativi sulla reale portata di questa ‘età dell’oro’. Per approfondire, è fondamentale esaminare criticamente la storiografia di questo periodo, considerando le prospettive di autori come Immanuel Wallerstein, che ha analizzato le dinamiche del sistema-mondo e le disuguaglianze strutturali tra centro e periferia.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]