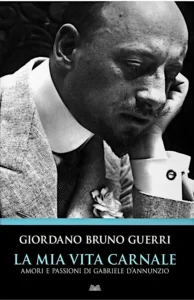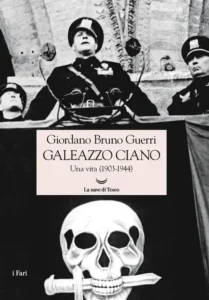Contenuti del libro
Informazioni
“Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio” di Giordano Guerri ti porta nel cuore oscuro dell’Unità d’Italia. Dimentica la retorica ufficiale: questo libro racconta come il Risorgimento, nel 1861, sia stato vissuto nel Sud Italia non come liberazione, ma come un’annessione violenta da parte del Piemonte. Esplora le profonde fratture tra l’élite piemontese e la popolazione meridionale, schiacciata dalla povertà e indifferente agli ideali nazionali. Il cuore del racconto è il brigantaggio post-unitario, un fenomeno complesso che non fu solo criminalità, ma una disperata reazione alla miseria, alla leva obbligatoria e alla mancata riforma agraria, alimentato anche da ex soldati borbonici e dal clero. Vedrai la brutalità della repressione del brigantaggio da parte del nuovo Stato, con fucilazioni, paesi bruciati (come Pontelandolfo e Casalduni) e l’applicazione di leggi eccezionali come la Legge Pica, che sospese i diritti fondamentali solo al Sud. Il libro non nasconde la violenza, le sofferenze dei soldati settentrionali impreparati alla guerriglia, il ruolo delle brigantesse e la complessità di figure come Carmine Crocco. È un viaggio nella Questione Meridionale, mostrando come la gestione di questa “guerra civile” abbia lasciato ferite aperte, rafforzato il latifondo e spinto milioni di persone all’emigrazione, creando un duraturo senso di estraneità verso lo Stato unitario. Questa è l’antistoria di un’Italia che, unendosi, ha versato il sangue del Sud.Riassunto Breve
L’unificazione italiana del 1861 si configura come una espansione territoriale guidata dalla classe dirigente piemontese, che non integra pienamente le diverse realtà della penisola. Esiste un forte divario tra questa élite e la maggioranza della popolazione, specialmente nel Sud, dove i contadini sono più preoccupati dalla povertà e legati alla tradizione religiosa che dagli ideali nazionali. Il Regno delle Due Sicilie, prima dell’annessione, possiede risorse ma anche carenze infrastrutturali, inefficienze amministrative e forti disuguaglianze sociali. L’annessione da parte del Piemonte è vissuta da molti meridionali come una occupazione, e i plebisciti che sanciscono l’unità sono considerati da alcuni storici non pienamente liberi. La reazione a questa nuova realtà nel Sud si manifesta nel brigantaggio, un fenomeno complesso che non è solo criminalità. Coinvolge contadini esasperati dalla miseria, dalla leva obbligatoria e dalla mancata riforma agraria, ex soldati borbonici e sostenitori del vecchio regime. La vita dei briganti è dura, fatta di stenti, ma si basa su una rete di informatori locali. Il movimento riceve appoggio dai Borbone in esilio e da gran parte del clero. Figure come Chiavone, Crocco e Monaco mostrano la complessità del fenomeno, che unisce ribellione sociale, aspirazioni politiche e a volte pura criminalità. Tentativi di coordinamento con esponenti borbonici, come il generale Borges, falliscono per divergenze di obiettivi. La repressione da parte del governo unitario è estremamente dura. I comandanti locali fucilano i ribelli per imporre il controllo. Il generale Cialdini intensifica l’azione, con migliaia di fucilati e centinaia di paesi bruciati, come Pontelandolfo e Casalduni, dove interi paesi vengono distrutti e gli abitanti uccisi per rappresaglia. Questa realtà è minimizzata al Nord. L’esercito italiano, composto in gran parte da soldati settentrionali, si trova impreparato ad affrontare la guerriglia e soffre per le condizioni difficili e le malattie. La Legge Pica del 1863 accentua la militarizzazione del Sud, instaura tribunali militari, permette fucilazioni sommarie e incentiva la delazione, sospendendo garanzie costituzionali solo al Sud. Questa legge spinge i soldati ad adottare tattiche spietate. Le donne, le “brigantesse”, partecipano attivamente o supportano i briganti, spesso spinte da tragedie personali o per sfuggire alla miseria, e vengono ritratte negativamente dalla stampa. La gestione repressiva è alimentata anche da pregiudizi diffusi nel Nord verso i meridionali, visti come arretrati. Una commissione d’inchiesta parlamentare analizza il fenomeno ma ignora le cause sociali ed economiche e descrive i meridionali con stereotipi negativi. Dopo la repressione militare, il brigantaggio organizzato diminuisce, ma i problemi del Sud persistono. La politica unitaria non realizza una riforma agraria efficace; i beni ecclesiastici e demaniali venduti finiscono alla borghesia, rafforzando il latifondo e peggiorando le condizioni di vita dei contadini. La mancanza di investimenti in infrastrutture e lo sviluppo economico sbilanciato a favore del Nord aumentano il divario tra le due aree del paese. La povertà e la mancanza di opportunità spingono milioni di meridionali all’emigrazione, dove spesso affrontano sfruttamento e pregiudizi. La gestione dell’Unità, percepita al Sud come una conquista e non come integrazione, lascia ferite aperte e contribuisce a creare un sentimento di estraneità verso lo Stato, consolidando la “questione meridionale” e la contrapposizione tra Nord e Sud.Riassunto Lungo
1. L’Unità e le Sue Ombre Nascoste
L’Italia raggiunge l’unificazione nel 1861, un traguardo politico importante. Tuttavia, il modo in cui questo avviene crea divisioni profonde nel paese. La classe dirigente, guidata dal Piemonte di Cavour, vede l’unità più come un’espansione del proprio territorio che come un vero processo di integrazione tra le diverse aree della penisola. Questa élite è lontana dalla maggior parte della popolazione, soprattutto nel Sud. Qui, la gente comune, in particolare i contadini, pensa di più alla propria povertà e alle tradizioni religiose che agli ideali di nazione o libertà proposti dal nuovo stato.La Situazione nel Sud Prima e Dopo l’Unità
Prima di essere annesso, il Regno delle Due Sicilie possiede risorse economiche significative. Nonostante ciò, affronta anche problemi come infrastrutture insufficienti, un’amministrazione poco efficiente e grandi differenze sociali tra ricchi e poveri. Quando il Piemonte annette il Sud, molti abitanti lo vivono come un’occupazione militare, non come un’unione voluta. Anche i voti (plebisciti) che confermano l’annessione sono visti da alcuni studiosi come non del tutto liberi o rappresentativi della volontà popolare.La Nascita del Brigantaggio
La risposta a questa nuova realtà nel Sud si manifesta nel fenomeno del brigantaggio. Questo non è un semplice atto criminale, ma un movimento complesso con diverse cause. Vi partecipano contadini stanchi della miseria, della leva militare obbligatoria e del fatto che non vengono distribuite le terre promesse. Si uniscono a loro anche soldati che facevano parte dell’esercito del vecchio Regno borbonico e persone che sostenevano il regime precedente e speravano in un suo ritorno.La Dura Repressione e le Sue Conseguenze
Il governo del nuovo Regno d’Italia reagisce al brigantaggio con estrema durezza. Vengono applicate leggi speciali molto severe e si verificano numerose fucilazioni e repressioni violente. Questa risposta brutale è anche alimentata da forti pregiudizi che esistono nel Nord nei confronti degli abitanti del Sud, spesso visti come arretrati o selvaggi. La gestione violenta e repressiva del brigantaggio contribuisce in modo determinante a creare e consolidare quella che viene definita la “questione meridionale”, segnando profondamente la contrapposizione e la distanza tra il Nord e il Sud del paese.Il brigantaggio post-unitario fu solo un “movimento complesso” di resistenza popolare, o il capitolo trascura le sue anime più reazionarie e criminali?
Il capitolo descrive il brigantaggio come un fenomeno complesso, ma le cause elencate sembrano privilegiare l’aspetto della resistenza popolare e della reazione legittimista. Tuttavia, la storiografia sul brigantaggio è ricca di dibattiti e interpretazioni diverse. Per comprendere appieno la sua natura, è fondamentale esplorare anche le componenti più strettamente criminali e quelle legate a progetti politici reazionari, che non si limitavano alla semplice speranza di un ritorno borbonico ma miravano a destabilizzare il nuovo stato. Approfondire gli studi che analizzano le diverse anime del brigantaggio, magari leggendo autori che ne hanno messo in luce gli aspetti meno ‘romantici’ e più legati alla criminalità comune o alla pura reazione politica, può offrire una visione più completa. È utile confrontarsi con le diverse scuole di pensiero storiografico che hanno affrontato il tema.2. Guerra civile e repressione nel Meridione postunitario
Dopo l’unificazione d’Italia, la repressione dei ribelli nel Sud è estremamente violenta. I comandanti militari sul posto procedono con fucilazioni sommarie per imporre l’ordine, nonostante da Torino arrivino indicazioni per un approccio più misurato. Il generale Cialdini, investito di ampi poteri militari e civili, intensifica le operazioni repressive. I suoi stessi rapporti documentano migliaia di persone fucilate, ferite o arrestate, oltre a centinaia di case e interi paesi dati alle fiamme. Questa dura realtà viene spesso minimizzata nel Nord, per nascondere i costi umani e sociali dell’annessione.
Le cause della rivolta e i suoi sostenitoriLa ribellione è alimentata dalla profonda miseria che affligge i contadini meridionali. Essi vivono in condizioni igienico-sanitarie disperate, con malattie diffuse e una quasi totale mancanza di servizi essenziali. Per molti di loro, unirsi ai gruppi armati rappresenta l’unica via di fuga da una vita di stenti insopportabili. Il movimento riceve un sostegno significativo sia dalla famiglia Borbone in esilio, che spera in una restaurazione, sia da gran parte del clero locale. Quest’ultimo fornisce rifugi sicuri, risorse economiche e una sorta di legittimazione morale e religiosa alla lotta, percependo il nuovo Stato unitario come ostile.
La vita dei ribelli e la risposta brutale dello StatoLa vita dei ribelli è segnata da grandi difficoltà, privazioni costanti e continui spostamenti per sfuggire alle truppe. Tuttavia, essi possono contare su una fitta rete di informatori e complici tra la popolazione locale che li aiuta a sopravvivere e a muoversi sul territorio. Figure come Chiavone emergono nel tentativo di organizzare e guidare la resistenza, sebbene a volte con iniziative personali. La risposta militare dello Stato è spesso spietata, con episodi di estrema violenza contro le comunità civili. Il massacro di Pontelandolfo e Casalduni, dove interi villaggi vengono rasi al suolo e gli abitanti trucidati per rappresaglia, sono esempi tragici di questa brutalità. Anche nel Nord, alcune voci autorevoli, come quella di Massimo d’Azeglio, esprimono seri dubbi sulla legittimità e sulla modalità dell’annessione forzata del Sud.
La “ribellione” postunitaria fu davvero solo la disperata reazione alla miseria contadina, o il capitolo omette di indagarne altre, scomode, nature?
Il capitolo pone giustamente l’accento sulla brutalità della repressione statale e sulla miseria dei contadini come causa scatenante della rivolta. Tuttavia, la complessa natura del fenomeno, spesso definito “brigantaggio”, andrebbe esplorata più a fondo. Non fu un movimento monolitico, e accanto alla disperazione sociale coesistettero spinte legittimiste, criminali e politiche, sostenute da forze esterne. Per comprendere appieno questo periodo, è fondamentale confrontarsi con la ricca e dibattuta storiografia sul brigantaggio postunitario, approfondendo le diverse interpretazioni e le motivazioni dei vari attori in campo. Autori come Franco Molfese, Gigi Di Fiore o Carmine Pinto offrono prospettive essenziali per inquadrare la complessità del fenomeno.3. Sangue e miseria nel Sud unificato
La repressione del brigantaggio nel Sud dopo l’Unità d’Italia si manifesta con estrema violenza, colpendo paesi e popolazioni civili. Città come Pontelandolfo e Casalduni subiscono incendi e distruzioni devastanti, causando perdite umane e materiali immense. La risposta militare è brutale e spietata, giustificata dalle autorità dell’epoca come necessaria per ristabilire l’ordine, ma ampiamente criticata per la sua ferocia indiscriminata.Le difficoltà dell’esercito e la legge Pica
L’esercito italiano, composto in gran parte da soldati provenienti dal Nord, si trova impreparato ad affrontare la guerriglia tipica del brigantaggio. Le truppe soffrono enormemente a causa delle condizioni difficili del territorio, affrontando malattie come tifo e malaria, utilizzando equipaggiamenti inadeguati e mancando di mappe precise delle zone montuose. La strategia militare tradizionale, basata su scontri in campo aperto, si dimostra inefficace contro bande mobili e sfuggenti. Questa situazione porta a un alto numero di perdite tra i soldati e a un progressivo calo del morale. L’introduzione della legge Pica nel 1863 accentua ulteriormente la militarizzazione del Sud e spinge i soldati ad adottare tattiche ancora più spietate, trasformandoli in esecutori brutali.Il ruolo delle donne nel brigantaggio
Le donne, spesso definite “brigantesse”, partecipano attivamente o supportano i briganti in vari modi. Le loro motivazioni sono diverse: a volte sono spinte da tragedie personali o dal desiderio di vendicarsi per soprusi subiti, altre volte cercano di sfuggire alla miseria estrema e alla subalternità sociale che caratterizzano la loro vita. La stampa dell’epoca le descrive in modo sensazionalistico e disumanizzante, contribuendo a creare un’immagine distorta della loro figura. Molte di queste donne muoiono durante gli scontri o finiscono in carcere, dove in alcuni casi si trovano a partorire. La loro scelta di entrare nell’illegalità viene spesso vista dalla società e dalle autorità come pura depravazione, piuttosto che come una reazione comprensibile a condizioni sociali ed economiche estreme e disperate.La natura complessa del brigantaggio e le figure chiave
Il brigantaggio presenta un confine incerto e sfumato tra motivazioni di natura politica, come il sostegno alla dinastia borbonica o la rivendicazione di diritti per le popolazioni meridionali, e pura attività criminale, che include rapine, furti e sequestri di persona a scopo di riscatto. Figure come Pietro Monaco e Carmine Crocco incarnano perfettamente questa complessità. Pietro Monaco, un ex soldato garibaldino deluso dalle promesse non mantenute dal nuovo stato, si dedica a sequestri e atti di violenza, spesso agendo insieme alla sua compagna Ciccilla. Carmine Crocco, proveniente da una famiglia contadina segnata da ingiustizie, diventa un capo carismatico capace di unire la ribellione sociale contro le ingiustizie a più ampie aspirazioni politiche. Tuttavia, anche Crocco non rinuncia a saccheggi e ricatti per finanziare la sua banda e la sua attività. Nonostante alcuni tentativi di coordinamento con esponenti borbonici esiliati, come il generale spagnolo José Borges, il movimento brigantesco manca di una strategia unitaria e di un sostegno esterno sufficiente. Questa mancanza limita fortemente l’efficacia complessiva della rivolta. La repressione del brigantaggio si protrae per diversi anni, lasciando un segno profondo e duraturo sul territorio del Sud e sulla vita delle popolazioni che lo abitano.[/membership]Il capitolo descrive la complessità del brigantaggio, ma quanto a fondo esplora le sue radici politiche e ideologiche, al di là della reazione alla miseria e all’oppressione?
Il capitolo evidenzia giustamente la natura sfaccettata del fenomeno brigantesco, riconoscendo la compresenza di spinte politiche e criminali. Tuttavia, la trattazione delle motivazioni politiche sembra meno sviluppata rispetto alla descrizione della repressione e delle difficoltà dell’esercito. Per comprendere appieno la portata e la persistenza del brigantaggio, sarebbe cruciale approfondire il contesto storico e politico del Regno delle Due Sicilie pre-unitario, le dinamiche sociali ed economiche che alimentavano il malcontento e le specifiche rivendicazioni (o la mancanza di esse) dei gruppi briganteschi legati alla causa borbonica o a istanze autonomiste. Approfondire la storia del Risorgimento dal punto di vista meridionale e studiare autori come Antonio Gramsci o Denis Mack Smith può fornire prospettive utili per colmare questa lacuna.4. L’Italia non fatta e le sue ombre
L’unificazione italiana incontra una forte resistenza nel Sud del paese, dove il fenomeno del brigantaggio assume forme complesse. Alcune figure, come il generale borbonico Borges, cercano di dare un’organizzazione militare alle bande. Tuttavia, si scontrano con la brutalità e gli obiettivi diversi dei capi briganti locali. Tra questi, Crocco, che preferisce saccheggi e vendette personali piuttosto che seguire un piano strategico unitario. Borges vorrebbe creare un vero esercito e riportare l’ordine, mentre Crocco punta soprattutto a estorcere denaro ai ricchi e a combattere in modo autonomo con la sua banda. Questa profonda differenza di vedute porta alla fine dell’alleanza tra loro e al fallimento di azioni importanti, come l’attacco alla città di Potenza.La reazione dello Stato e la repressione
Lo Stato unitario risponde al brigantaggio con grande durezza. Viene creata una commissione parlamentare per indagare sul fenomeno. Purtroppo, l’analisi di questa commissione è parziale: ignora le vere cause sociali ed economiche del brigantaggio e descrive la popolazione meridionale con pregiudizi negativi. La repressione si fa ancora più intensa con l’introduzione della Legge Pica nel 1863. Questa legge stabilisce l’uso di tribunali militari, permette le fucilazioni immediate senza processo e incoraggia le persone a denunciare i briganti in cambio di ricompense. La Legge Pica sospende di fatto le garanzie costituzionali e i diritti fondamentali dei cittadini, ma viene applicata solo nelle regioni del Sud. La strategia militare, guidata da generali come Pallavicini, sfrutta molto la delazione per individuare e distruggere le bande. Questo porta a migliaia di condanne a morte e arresti. Alcune figure, come Giuseppe Caruso, decidono di tradire i propri compagni briganti per ottenere sconti di pena.Le conseguenze a lungo termine e l’emigrazione
Dopo la forte repressione militare, il brigantaggio organizzato diminuisce notevolmente. Tuttavia, i problemi profondi del Sud non vengono risolti. La politica del nuovo Stato unitario non riesce a realizzare una riforma agraria efficace. I beni che appartenevano alla Chiesa e quelli pubblici vengono venduti, ma finiscono nelle mani della borghesia più ricca, non dei contadini poveri. Questa situazione rafforza il sistema del latifondo, dove pochi grandi proprietari possiedono vaste terre, e peggiora ulteriormente le condizioni di vita dei lavoratori agricoli. La mancanza di investimenti nelle infrastrutture e uno sviluppo economico che privilegia il Nord aumentano il divario tra le diverse aree del paese. La povertà e la mancanza di opportunità spingono milioni di persone dal Sud a emigrare. Molti si spostano verso altre regioni d’Italia, altri vanno all’estero. Spesso, chi emigra si trova a dover affrontare sfruttamento e pregiudizi. La gestione dell’Unità, percepita al Sud più come una conquista militare che come una vera integrazione, lascia ferite aperte e contribuisce a creare un forte sentimento di distanza e sfiducia verso lo Stato.Se il capitolo sottolinea che la commissione parlamentare ignorò le “vere cause sociali ed economiche” del brigantaggio, perché il capitolo stesso non le esplora in modo più approfondito, limitandosi a descrivere la repressione e le conseguenze a lungo termine?
Il capitolo offre un quadro efficace della repressione statale e dei suoi esiti, ma, pur riconoscendo il limite dell’analisi della commissione parlamentare nel trascurare le “vere cause” del fenomeno, non si sofferma su quali fossero effettivamente queste cause profonde. Per comprendere appieno il brigantaggio non solo come reazione alla conquista o come mero banditismo, ma come espressione di tensioni sociali, economiche e politiche preesistenti e acuite dall’Unità, è fondamentale approfondire la complessa “Questione Meridionale”. Discipline come la storia sociale, l’economia e la sociologia sono indispensabili, e l’opera di autori come Gramsci offre spunti cruciali per inquadrare il contesto storico-politico.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]