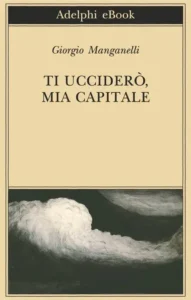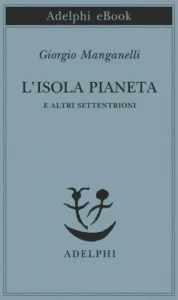1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
Il rumore sottile della prosa di Giorgio Manganelli non è il solito saggio sulla scrittura. È un viaggio pazzesco dentro l’idea stessa di fare libri, di essere uno scrittore. Manganelli smonta tutto: dice che scrivere è un mestiere strano, quasi inutile, più simile all’alchimia che a un lavoro vero, e che lo scrittore è una figura inesistente, un inetto, forse un matto che inganna prima di tutto sé stesso. Il libro esplora la natura complessa e oscura della letteratura, vista non come espressione di sentimenti o messaggi, ma come puro artificio, tecnica, un gioco di parole “morte” prese dai dizionari e rianimate in strutture precise e disubbidienti. Si parla del romanzo contemporaneo, diventato troppo serio e noioso, e della critica letteraria, vista come un genere letterario a sé, impuro ma creativo, fatto di recensioni che sono quasi risse tra letterati. Manganelli ci porta nel mondo strano dei premi, delle fiere del libro, e ci fa capire che il vero piacere sta nella rilettura dei classici, nel trovare il “rumore sottile della prosa” che sfugge alla prima lettura. È un libro che ti fa guardare la letteratura da un’angolazione completamente diversa, piena di ironia e disincanto, ma anche di una profonda passione per le parole e la loro magia artificiale.Riassunto Breve
Scrivere è un lavoro manuale, come fare il pane, un’esecuzione di gesti in uno spazio, ma i gesti sono poveri e ripetitivi. La spinta a scrivere può venire dall’incapacità di fare cose pratiche semplici, un modo per compensare e schivare lavori normali. È un mestiere ingiudicabile, come l’astrologia, importante per chi si sente inadeguato e vuole sfuggire ai giudizi. Lo scrittore, come l’alchimista, inganna prima sé stesso, imitando il matto, un capolavoro inutile. Scrivere è solitario, richiede poca abilità manuale, è astuzia o follia. Pubblicare è diverso dallo scrivere; la regola è pubblicare, non scrivere. Una riga bianca pubblicata dimostra questo. Dire cosa non è un racconto è difficile; solo il romanzo si distingue, perché tende a una struttura fissa e sopprime la molteplicità del racconto, che è polimorfo e provvisorio. La chiarezza nella scrittura è complessa e non sempre buona, specialmente in letteratura e filosofia. Il linguaggio è sfuggente e resiste alla semplificazione. La letteratura e la filosofia lavorano con il caos, l’irrazionale; la chiarezza può non contare per il valore. L’oscurità può portare a una complessità profonda. La figura dello “scrittore” non esiste davvero; è una favola. Esistono solo parole che si uniscono. Il giovane scrittore non sa che andrà incontro a un fallimento. Nemmeno la morte garantisce il titolo. Il romanzo oggi è in rovina perché i romanzieri sono troppo seri, cercano messaggi e verità, hanno perso la gioia della menzogna e l’irresponsabilità. Hanno dimenticato di essere artificio. La letteratura è disubbidiente, asociale, una satira anarchica. Richiede la retorica, intesa come pura tecnica, conoscenza delle regole, indifferente ai sentimenti. La retorica è uno strumento contro l’idea romantica di genio e ispirazione. La letteratura è artificio e struttura, non espressione di sentimenti o morale. Non parla esplicitamente al lettore, è asociale, rivolta ai lettori futuri. Ridurla a qualcosa “per bene” la snatura; è ambigua, disubbidiente, accoglie ideologie senza interessarsene. È libertà non convenzionale. Anche i classici possono essere letti come scoperte, nella loro natura inattesa. Scrivere lettere d’amore letterarie non dipende dall’essere innamorati; spesso sono scritte da chi sa mentire o da professionisti. Le parole nuove e antiche che tornano funzionano in modo simile; non solo nominano, ma definiscono la realtà, sono un incantamento. La lingua letteraria è una “lingua morta”, statica, dove le parole diventano fantasmi. Stabilire chi è scrittore, specialmente tra i vivi, è difficile; non ci sono criteri chiari. Forse solo molto dopo la morte si capisce. Narrare può essere un dono, ma scrivere romanzi è un’abilità che si impara, una tecnica. L’esistenza del romanzo dimostra che si può studiare. L’università non è la strada migliore per chi vuole scrivere; meglio studiare altre discipline per avere esperienze nuove. Volgarizzare concetti complessi è impossibile ma necessario. La letteratura è complessa, non complicata; non si può semplificare senza perdere l’essenza. È oscura, elusiva. Insegnare letteratura è difficile; forse si può educare a sentire l’enigma. Le polemiche tra autori e recensori nascono quando gli autori reagiscono alle critiche. Rispondere a una recensione negativa è scorretto. Pubblicare un libro è un atto non necessario, poi è esposto al giudizio. Ringraziare per recensioni positive può sembrare ricerca di favori. Gli autori mostrano un narcisismo fragile. La critica si basa su formule linguistiche, accostamenti di parole che creano giudizi rapidi. La critica letteraria è letteratura sulla letteratura, non spiega o giudica, ma usa le parole altrui come personaggi. È impura, creativa, non esaustiva. Non è uno strumento utile, ma qualcosa di ambiguo, come una farfalla. Le recensioni hanno impatto limitato sulle vendite, influenzano di più i libri meno noti. Non sono oggettive, legate alla passione del lettore. La recensione non si basa sul riassunto della trama; i libri importanti hanno uno strato profondo, un tema, la qualità della prosa. Molti libri ottimi sono difficili da riassumere. La citazione è utile per mostrare la prosa, specialmente nelle opere prime. Scoprire classici poco noti o opere prime promettenti è un piacere del recensore. La recensione è un genere ambiguo, non pura critica o informazione. Grandi recensori la usano in modo arbitrario. Le stroncature sono divertenti, animano il dibattito, non migliorano l’autore ma intrattengono il lettore. La letteratura non è intrinsecamente seria. Un Censore in un paese senza libri ha un compito astratto: mantenere concetti simbolici. Il significato di parole come “cerebrale”, “retorico”, “artificioso” cambia, diventano positivi, indicano tecnica e artificio. Una retorica moderna promuove la scrittura basata sull’intelletto, non sul sentimento. L’opera è un oggetto costruito. Si usa il linguaggio in modo non naturale, difficile, per liberarlo dalle emozioni. Il linguaggio scritto è fatto di parole “morte”, fisse, che creano immagini. Trovare parole antiche o inventarne di nuove serve a costruire strutture eccitanti. La scrittura è “fiction”, un modo diverso di presentare le cose. Autori come Alfieri e D’Annunzio costruiscono riti verbali con una lingua morta. Le parole letterarie “allucinano” l’esistenza. Lo scrittore è un “negromante” che evoca queste “larve”. Le enciclopedie sono oggetti magici che ordinano il mondo alfabeticamente, un genere letterario. Sentimenti intensi hanno aspetti nobili e turpi, includono patimento. Organizzare la storia con annali elenca eventi slegati, un labirinto senza senso. La creazione letteraria si basa sul tormento. I premi letterari richiedono ansia e sofferenza estrema. Il successo letterario può essere difficile per uno scrittore schivo, richiede una socialità innaturale. Trasforma il libro in un evento pubblico. I personaggi suscitano reazioni emotive. L’insuccesso è un enigma complesso, non garantisce successo futuro. Il successo può portare a letture sbagliate. Alcuni autori sono indifferenti alla fama. L’insuccesso, gestito bene, può essere gratificante; un libro di insuccesso parla a pochi o nessuno. Cercare l’insuccesso è difficile quanto il successo. Le celebrazioni dei centenari sono un modo artificiale per recuperare figure del passato, un trionfo temporaneo dell’anti-storia. Leggere certi libri, fuori dalle mode, è un gesto di libertà. Offrono letizia e ordine contro il caos della storia. Il linguaggio può “sbriciolarsi”, rivelando significati nascosti, come nell’enigmistica o nei sogni. La rima ricorda l’insensatezza del linguaggio. Cercare libri “strani” è difficile; opere potenti rimangono marginali. Una civiltà letteraria si basa sulla rilettura. La prima lettura è per la trama; la rilettura scopre aspetti inattesi, implicazioni. Molti libri moderni non sono fatti per essere riletti, a differenza dei classici. I grandi libri sono inesauribili, le parole mostrano nuovi significati. La poesia è fatta per essere riletta. Rileggere è accedere alla profondità. L’estate non è per forza per letture impegnative; può essere una performance sociale. Essere chiamato “scrittore” crea disagio, implica aspettative. Meglio dire “Io scrivo”. Rispondere a domande semplici è sconsigliato; quelle complesse sono difficili per mancanza di “forza morale”. La fantasia è elusiva, non moralistica, legata ai sogni ma diversa, dissolve la realtà. C’è resistenza sociale verso l’inconscio e la fantasia, visti come destabilizzanti. Seguire la fantasia porta a deviare. Lo scrittore è un “inetto” che cede a questa forza arbitraria. Il mondo dei libri, come una fiera, è artificiale, un “harem” di idee intoccabili. Gli editori trattano con prodotti fantastici, cercando di interpretare gusti imprevedibili.Riassunto Lungo
1. Il Mestiere Ingiudicabile
L’atto dello scrivere è una performance, un’esecuzione di gesti che si compie in uno spazio preciso. È un lavoro, simile ad altre attività manuali come fare il pane o costruire muri, dove l’attenzione è rivolta all’azione in sé, non tanto a ciò che ne risulta. A differenza di molti lavori pratici, i gesti dello scrivere possono sembrare poveri e ripetitivi. Spesso, la spinta a scrivere nasce proprio dall’incapacità di affrontare compiti pratici più semplici, perfino allacciarsi le scarpe può sembrare difficile. Scrivere diventa così un modo per trovare un proprio spazio, compensare questa apparente mancanza di abilità e, in fondo, evitare lavori più convenzionali e definiti.Un mestiere senza giudizio
La scrittura, in questo senso, si avvicina a mestieri antichi come l’astrologia o l’alchimia. Sono attività difficili, se non impossibili, da valutare in modo oggettivo. Non c’è un metro di misura chiaro per dire se un oroscopo è “giusto” o se una trasmutazione alchemica è “riuscita” nel senso comune. Questa caratteristica è fondamentale per chi scrive, perché spesso percepisce una propria mancanza di abilità concreta e desidera ardentemente sfuggire a qualsiasi forma di giudizio esterno. È un rifugio dove la valutazione tradizionale non ha presa.L’ombra del matto
Chi scrive, così come l’alchimista o l’astrologo, mette in atto una forma di autoinganno. Queste figure sembrano imitare l’archetipo del matto, una figura anch’essa impossibile da giudicare secondo i criteri comuni e spesso considerata un’opera d’arte inutile in sé. Scrivere è un lavoro che si fa in solitudine, richiede pochissima abilità manuale nel senso tradizionale del termine. È un’attività che può apparire come una forma di astuzia per navigare nel mondo, o forse, semplicemente, come una manifestazione di follia.Scrivere o pubblicare?
È cruciale distinguere tra l’atto di scrivere e quello di pubblicare. Le regole che governano il mondo editoriale impongono la pubblicazione, non necessariamente la scrittura. L’esempio più chiaro di questa differenza è una riga bianca: non è stata scritta, eppure può essere pubblicata. Questa riga non scritta ma che appare sulla pagina è considerata, in un certo senso, l’unica riga “vera”. Rispetta la regola fondamentale di esistere nello spazio della pubblicazione senza essere nata dall’atto fisico dello scrivere. Rappresenta un vuoto che ha piena dignità di apparire, dimostrando che l’esistenza editoriale non dipende sempre dalla creazione materiale del testo.Ma se scrivere è un “mestiere ingiudicabile” per chi non sa allacciarsi le scarpe, come si spiega l’enorme sforzo tecnico e intellettuale che richiede, e il giudizio spietato del mercato e della critica?
Il capitolo, nel descrivere la scrittura come un rifugio ingiudicabile per chi manca di abilità pratiche, ignora la complessità del mestiere. La scrittura richiede padronanza della lingua, struttura narrativa, ricerca, revisione – tutte abilità che si affinano con pratica e studio. Inoltre, il mondo editoriale e la critica letteraria impongono giudizi molto concreti, che determinano il successo o l’oblio di un testo. Per approfondire il divario tra la visione del capitolo e la realtà della professione, si potrebbe esplorare la sociologia della letteratura, la teoria della critica letteraria, e gli studi sul processo cognitivo della scrittura. Autori come Pierre Bourdieu o Roland Barthes offrono strumenti per analizzare il campo letterario e le dinamiche di valore e giudizio.2. La Natura Sfuggente del Racconto e la Complessità Oscura
È difficile definire esattamente cosa sia un racconto, perché molti tipi di testi, anche quelli che non sembrano narrativi come una ricetta o un lungo poema epico, possono avere al loro interno elementi che raccontano qualcosa. L’unica forma che si distingue nettamente da un racconto è il romanzo. Questo perché il romanzo di solito segue una struttura unica e ben definita, che spesso mette da parte la possibilità di avere tante storie diverse al suo interno. Invece, un racconto è per sua natura fatto di tante forme diverse, è provvisorio e può lasciare un po’ disorientati chi lo legge. Proprio per questa sua natura sfuggente e non rigida, il racconto ci porta a confrontarci con la complessità del linguaggio stesso.Scrittura e complessità
La chiarezza assoluta nella scrittura è un’idea difficile da raggiungere e non sempre utile, soprattutto quando parliamo di letteratura o filosofia. Questo perché il linguaggio ha una sua natura complessa e non si lascia facilmente semplificare in modo totale. Cercare di rendere un testo troppo semplice e chiaro rischia di togliere forza, vita e tutte quelle piccole sfumature che rendono le parole interessanti. Mentre testi pensati per insegnare cercano di limitare i significati per farsi capire meglio, la letteratura e la filosofia accolgono proprio questa complessità come una parte fondamentale della loro essenza. Chi scrive o pensa in modo profondo, come un vero scrittore o un filosofo, spesso lavora con idee che sembrano caotiche o non del tutto razionali, e a volte non capisce fino in fondo tutto quello che sta creando.L’oscurità e la complessità profonda
Per il valore di un testo letterario, la sua estrema chiarezza può non essere importante. Anzi, in questo tipo di scrittura, l’oscurità non è per forza un punto debole. Può essere la strada per arrivare a una complessità molto profonda, che non si potrebbe raggiungere con una scrittura troppo semplice. La complessità è proprio una caratteristica centrale del linguaggio e della letteratura. Questa ricchezza e complessità non possono essere riassunte o rese semplici senza perdere ciò che le rende uniche e preziose.Ma se la chiarezza assoluta è “difficile da raggiungere e non sempre utile”, e l’oscurità è la “strada per arrivare a una complessità molto profonda”, non si rischia di confondere l’incapacità di definire con la “natura sfuggente” e la semplice confusione con la “complessità profonda”?
Il capitolo pone una distinzione netta tra romanzo e racconto e valorizza l’oscurità come via alla complessità, ma questa posizione solleva interrogativi. Affermare che il romanzo è l’unica forma nettamente distinta dal racconto, o che l’oscurità sia intrinsecamente legata alla profondità, potrebbe trascurare altre prospettive sulla definizione dei generi narrativi e sul ruolo della chiarezza (o della sua assenza) nella comunicazione letteraria e filosofica. Per esplorare queste tematiche in modo più approfondito, è utile confrontarsi con la teoria della letteratura, in particolare la narratologia e la teoria dei generi, e con la filosofia del linguaggio e l’ermeneutica. Autori come Gérard Genette o Paul Ricoeur possono offrire strumenti per analizzare la struttura narrativa e i processi di interpretazione, mentre pensatori che hanno dibattuto il rapporto tra linguaggio, significato e comprensione possono aiutare a contestualizzare il valore attribuito alla chiarezza o all’oscurità.3. L’illusione dello scrittore e il romanzo in rovina
Non esiste una figura definita come “scrittore”. Il termine è meno onesto di “romanziere” o “poeta”, parole che indicano un mestiere preciso e riconoscibile. Non si sa bene cosa sia uno scrittore; forse è semplicemente qualcuno con problemi personali e molta vanità, o magari un imbroglione che approfitta di un titolo vago.Il destino e l’illusione del titolo
Lo scrittore anziano, ad esempio, si sente spesso un fallito proprio perché ha perso la certezza del proprio titolo, non confermato da premi o successi concreti. Il giovane che inizia a scrivere non sa ancora che è destinato a seguire un percorso simile, perdendo col tempo la convinzione di essere un vero scrittore. Lavora inconsapevolmente verso un fallimento di cui non si rende conto. Nemmeno la morte garantisce il titolo di scrittore per sempre, perché la fama postuma può essere facilmente distrutta o creata da altri. I giovani scrittori sembrano necessari solo per diventare anziani, che a loro volta sono la materia prima per gli unici “scrittori” che sembrano legittimi: i morti. Ma anche questa è un’illusione. Lo scrittore, in realtà, non esiste. È solo una favola. Esistono soltanto parole che si uniscono sotto una mano.La rovina del romanzo
Il romanzo oggi è in rovina. Questo accade perché i romanzieri sono diventati troppo seri nel loro lavoro. Cercano a tutti i costi di inserire idee profonde e messaggi importanti nelle loro storie, convinti che il romanzo debba spiegare e interpretare il mondo. Questa eccessiva serietà ha fatto perdere la gioia di inventare storie, quella sana irresponsabilità e l’arroganza necessarie per creare letteratura vera. Invece di raccontare bugie affascinanti e fluide, balbettano verità complicate e cercano di trovare un posto nella storia, un luogo che è estraneo alla vera natura della letteratura. Hanno semplicemente rinunciato alla disubbidienza creativa. Il romanzo ha iniziato a decadere quando ha dimenticato di essere un artificio, proprio come è successo con la crisi della retorica classica in passato.Lo scrittore del futuro e una nuova strada
In questo quadro, emerge una figura che si definisce “scrittore del futuro”. Questa persona opera al di fuori delle regole del tempo presente e crea quelli che vengono chiamati “nonlibri”, opere che non possono essere giudicate o imitate secondo i canoni attuali. Questo scrittore si attribuisce il titolo semplicemente decidendolo per sé, poiché non c’è altro modo per sapere chi è un vero scrittore. Vede il processo di fare libri come un gioco, una specie di scherzo, una “costruzione del futuro” che va contro la realtà di oggi. Crea opere molto complesse e riesce persino a influenzare il mondo letterario, arrivando a suggerire trame ad altri autori. Arriva anche a scrivere un “libro sbagliato” che, pur essendo imbarazzante, riesce per un momento a liberare la letteratura dalle sue catene. Forse un possibile futuro per la letteratura si trova proprio in questo tipo di creazione astratta e apparentemente inutile.Ma la fatica di rispondere a domande complesse è davvero una questione di ‘forza morale’ o ‘pochezza morale’?
Il capitolo stabilisce un legame diretto tra la difficoltà nel fornire risposte definitive e una presunta qualità morale, senza però esplorare a fondo le molteplici ragioni di tale difficoltà. Forse la reticenza o l’incertezza nascono piuttosto dalla consapevolezza della complessità dei temi, dall’ambiguità intrinseca di certi termini (“cultura”, “pace”) o da una forma di onestà intellettuale che rifugge le semplificazioni. Per approfondire questo nodo, che mescola conoscenza, linguaggio e giudizio, sarebbe utile esplorare discipline come la filosofia, in particolare l’epistemologia e l’etica, o la psicologia del pensiero critico e della comunicazione.20. La Tirannia Fantastica dei Libri
La natura della fantasia e la resistenza sociale
La fantasia è una forza difficile da afferrare con precisione. Non è l’opposto della realtà; al contrario, la parola “realtà” porta con sé un peso emotivo e morale, cosa che non accade con la fantasia. La fantasia è legata al mondo dei sogni, ma se ne distingue nettamente. I sogni hanno una loro concretezza e una loro necessità interna, mentre la fantasia è più incerta, aperta a diverse possibilità e combinazioni, e possiede un elemento che scioglie la solidità della vita di tutti i giorni. Esiste una diffidenza nella società verso l’inconscio e la fantasia, perché sono visti come elementi che possono creare instabilità e che non portano a risultati concreti in termini economici. Seguire la fantasia significa percorrere strade non dritte, che portano a deviare dal percorso comune e ad arrivare “dopo” gli altri, una condizione che può sembrare una “dannazione meravigliosa”. Questa forza si impone sulla persona, che la riceve quasi senza poter scegliere.Lo scrittore: un “inetto” al servizio della fantasia
La figura dello scrittore viene spesso associata a quella di una persona “inadatta”, uno sconfitto, qualcuno che non si adatta al modo in cui gli oggetti o la vita pratica dovrebbero funzionare normalmente. Essere uno scrittore significa cedere a questa forza che è esigente, strana e imprevedibile, quella stessa forza fantastica che porta a percorsi non convenzionali e a essere “diversi” dagli altri. L’identità di scrittore non è qualcosa di definito una volta per tutte, ma si costruisce e si conferma nel tempo, cedendo continuamente a questa spinta interiore che dissolve la realtà quotidiana e impone la sua logica bizzarra. Questa dedizione alla fantasia, vista dalla società come improduttiva, definisce profondamente chi scrive e il suo percorso.Il mondo dei libri: una fiera fantastica e divoratrice
Il mondo dei libri prende forma in luoghi specifici, come la Fiera di Francoforte. Questo ambiente è descritto come un “harem” dove i libri sono visti come idee intoccabili o “sultane”, un luogo dove il prodotto della fantasia viene esposto e trattato. È uno spazio costruito artificialmente, dove le normali relazioni quotidiane e la presenza fisica sembrano quasi assenti, focalizzato interamente sulla merce letteraria. Le persone che lavorano in questo ambiente, come gli editori, dimostrano di avere un senso pratico per gli affari, ma allo stesso tempo trattano con prodotti fatti di fantasia, come sogni e deliri, cercando di monetizzare l’impalpabile. Sono figure che sembrano distaccate, quasi capaci di prevedere il futuro, mentre cercano di capire i gusti imprevedibili e dominanti del pubblico, la cui volontà è una vera e propria tirannia. Immergersi in questo mondo può portare a sentirsi mentalmente saturi, quasi divorati dalla quantità e dalla natura irreale di ciò che si incontra.Ma la diffidenza sociale verso la fantasia e l’inconscio è davvero solo una questione economica?
Il capitolo lega la resistenza sociale alla fantasia e all’inconscio principalmente alla loro presunta improduttività economica e alla deviazione dai percorsi convenzionali. Questa visione, pur plausibile, potrebbe essere limitata. La diffidenza verso ciò che è irrazionale o difficile da controllare ha radici profonde che vanno oltre il mero calcolo economico, toccando aspetti psicologici, culturali e storici legati al bisogno di ordine, prevedibilità e controllo sociale. Per esplorare la complessità di questa resistenza, sarebbe utile considerare prospettive dalla psicologia del profondo, come quelle proposte da Freud o Jung, o analisi sociologiche e storiche sui meccanismi di controllo sociale e la gestione della devianza, come quelle sviluppate da Foucault.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]