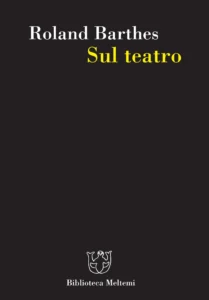1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il punto sulla semiotica letteraria” di Roland Barthes ti porta dentro una lezione speciale tenuta al Collège de France nel 1977. Non è la solita presentazione accademica, ma una riflessione super interessante sul linguaggio e sul sapere. Barthes parte subito forte dicendo che la lingua, per come funziona, è un po’ “fascista” perché ti obbliga a dire le cose in un certo modo, esercitando un potere che non notiamo. Contrappone questa visione del linguaggio alla letteratura, vista come una specie di fuga, un modo per “barare” con quel potere, giocando con le parole. Parla di come la letteratura possa contenere il sapere (Mathesis), rappresentare il reale (Mimesis) e far giocare i segni (Semiosis), proponendo una semiologia non come scienza rigida, ma come un modo per divertirsi con i segni, quasi una “semiotica apofatica”. L’idea di sapere che emerge non è quella delle grandi teorie, ma un sapere che ha “sapore”, che ti fa sentire la vita nei dettagli. È un invito a “disimparare”, a lasciare che le cose si mescolino. Se ti interessa la teoria letteraria, la critica letteraria o semplicemente capire meglio il rapporto tra linguaggio e potere, questo libro, basato su quella lezione, ti offre spunti pazzeschi, mostrandoti il testo letterario da una prospettiva nuova e super stimolante sulla semiotica letteraria.Riassunto Breve
La lingua funziona come una legge, un codice che ha potere. Questo potere non si vede sempre ma obbliga a parlare in certi modi, a classificare le cose e a pensare in modi già decisi, ed è oppressivo. Parlare non è solo dire qualcosa, ma anche sottomettersi. La lingua, di per sé, non è buona o cattiva, ma è vista come “fascista” perché costringe a dire. Il potere della lingua si vede nell’autorità di quello che si afferma e nel ripetersi di segni già usati. Chi parla ripete quello che è già stato detto ma lo presenta come suo. Sembra che la libertà, intesa come non sottomettere nessuno, non possa esistere nel linguaggio umano, che è come una porta chiusa. Una via per sfuggire a questo potere della lingua è la letteratura. La letteratura, cioè lo scrivere e i testi scritti, permette di “imbrogliare” la lingua, di deviarla non con quello che si dice, ma con il gioco delle parole. La forza che libera della letteratura sta nel suo far scivolare la lingua. La letteratura ha diverse forze. La prima è la *Mathesis*, la capacità di contenere e far girare il sapere, lavorando negli spazi lasciati liberi dalla scienza e pensando al sapere in modo vivo. La seconda è la *Mimesis*, la forza di mostrare la realtà, anche se la realtà non si può mostrare del tutto. La letteratura insiste nel voler mostrare l’impossibile, mostrando un lato utopico, specialmente oggi con le utopie del linguaggio. Questo significa accettare che ci siano più modi di parlare dentro la stessa lingua, così una persona può scegliere in base a quello che desidera, non in base a una regola. La terza forza è la *Semiosis*, la capacità di far giocare i segni, di metterli in una “macchina” linguistica che spegne i sistemi di controllo. Questo porta alla semiologia, vista non come una scienza certa e fissa dei segni, ma come un lavoro che raccoglie le parti “sporche” della lingua, quelle che lo studio tradizionale della lingua lascia fuori. Questa semiologia attiva è negativa perché dice che i segni non hanno caratteristiche fisse e che non cambiano mai. Non è un linguaggio che sta fuori dal suo oggetto, ma si muove nel gioco dei segni stessi. Aiuta altre scienze senza prendere il loro posto. È una “semiotropia”, che si rivolge al segno per giocarci come con un’illusione che si conosce. I suoi oggetti preferiti sono i testi che vengono dall’immaginazione. Questa semiologia legata alla letteratura nasce quando l’idea del grande scrittore si indebolisce e la letteratura non è più tenuta stretta dalle istituzioni. Diventa un viaggio in un posto libero, dove lo sguardo può posarsi sulle cose vecchie e belle con piacere. Il modo di fare di questo approccio non cerca di spiegare i significati, ma di togliere potere a quello che viene detto. Si basa sul dividere le cose nello scrivere e sull’andare fuori tema nel parlare, come un gioco di bambino che si allontana e poi torna. All’inizio di questo insegnamento c’è un desiderio che si allontana dal posto che ci si aspetta. L’esperienza di questo percorso è quella di “disimparare”, di lasciare che l’oblio cambi le cose che si sono imparate. È l’età della *Sapientia*: nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di saggezza e il più sapore possibile.Riassunto Lungo
1. Il sapore del sapere
Durante una lezione tenuta al Collège de France nel 1977, il discorso si concentra sulla natura del linguaggio e del sapere. Invece di seguire il solito schema che presenta la propria materia e i progetti futuri, l’attenzione si sposta sull’atto stesso del parlare e sul suo significato profondo. Ci si interroga su cosa significhi usare la lingua e quali implicazioni questo comporti per la nostra comprensione del mondo e della conoscenza. Questa scelta di approccio sottolinea l’importanza di riflettere sulle basi stesse della comunicazione e del pensiero.Il Linguaggio e il suo Potere Nascosto
Il linguaggio è percepito come qualcosa di intrinsecamente oppressivo. Non impedisce alle persone di esprimersi o di dire ciò che pensano, ma le costringe a farlo seguendo determinate regole e strutture. Questa imposizione di un modo specifico di parlare rende la lingua, in un certo senso, “fascista” perché limita la libertà espressiva imponendo una forma predefinita. La struttura stessa del linguaggio esercita un potere che condiziona il pensiero e la comunicazione.Semiologia e la Rivoluzione della Letteratura
La semiologia, un campo di studi in cui si è riconosciuti come figura centrale, non è più considerata una scienza nel senso tradizionale. È vista piuttosto come un’immagine sfuggente, un “simulacro”, consapevole della natura mutevole e temporanea del valore attribuito alle diverse discipline scientifiche nel corso del tempo. A questa visione della semiologia si contrappone la letteratura. La letteratura è considerata un’illusione positiva, uno spazio dove è possibile immaginare un linguaggio libero dalle costrizioni del potere. Permette una continua rivoluzione del linguaggio, esplorando nuove forme e significati al di fuori delle norme stabilite.Il Sapere che ha Sapore
Un’idea di sapere autentico emerge, basato non su grandi teorie generali o astrazioni, ma sul dettaglio specifico e particolare. Questo sapere si trova nel “sapore” delle cose, in quella qualità unica che riesce a trasmettere il senso profondo della vita e dell’esperienza. Il sapere più vero e genuino è l’atto di “assaggiare” questo sapore, di cogliere la ricchezza che si nasconde nei particolari. È un invito a cercare la conoscenza nella concretezza e nella specificità, piuttosto che nelle generalizzazioni astratte.Definire il linguaggio “fascista” non rischia di banalizzare sia la complessità della lingua che la gravità storica del fascismo?
Il capitolo presenta una tesi forte sull’oppressività intrinseca del linguaggio, arrivando a definirlo “fascista” per la sua imposizione di regole e strutture. Questa metafora, pur potente, potrebbe risultare eccessivamente semplificatoria e polemica, trascurando il fatto che la struttura linguistica è anche ciò che rende possibile la comunicazione e la condivisione del sapere. La gravità storica e le implicazioni politiche e sociali del fascismo come regime sono immense e specifiche; accostare questa realtà alla natura strutturale della lingua richiede un’argomentazione molto solida e contestualizzata che nel riassunto non emerge appieno. Per approfondire la relazione tra linguaggio, potere e struttura, senza necessariamente ricorrere a metafore così cariche, potrebbe essere utile esplorare la filosofia del linguaggio e la teoria critica, leggendo autori come Roland Barthes o Michel Foucault, che hanno analizzato i meccanismi del discorso e del potere in modo articolato.2. La Lingua come Potere e la Fuga della Scrittura
La lingua funziona come una legge e un codice, esercitando un potere che spesso non si percepisce. Ogni lingua classifica la realtà e questa classificazione può risultare oppressiva, perché obbliga chi parla a dire certe cose e a organizzare il proprio pensiero in modi già stabiliti. Parlare, quindi, non è solo un atto di comunicazione, ma implica anche una forma di sottomissione a queste regole implicite. La lingua, nella sua essenza più profonda, non è schierata politicamente, non è né progressista né reazionaria; piuttosto, si potrebbe dire che è “fascista” nel senso che impone e obbliga a dire.Il Potere Nascosto della Lingua
Questo potere della lingua si manifesta nell’autorità con cui vengono fatte le affermazioni e nella ripetizione continua di modi di dire e stereotipi. Chi parla si trova in una posizione ambigua: è contemporaneamente padrone, perché usa la lingua per affermare qualcosa, e schiavo, perché ripete ciò che è già stato detto, pur presentandolo come proprio. La vera libertà, intesa come la capacità di non imporre nulla a nessuno, sembra esistere solo al di fuori del linguaggio umano, che appare come una porta chiusa, un sistema rigido da cui è difficile uscire completamente.La Letteratura come Via di Fuga
Una possibile via per sfuggire a questo potere coercitivo della lingua è offerta dalla letteratura. La letteratura, intesa sia come l’atto di scrivere sia come il testo che ne deriva, permette in un certo senso di “barare” con la lingua. Non si tratta di cambiare il messaggio che si vuole comunicare, ma di giocare con le parole stesse, di usarle in modo inaspettato. Le forze che rendono la letteratura uno strumento di liberazione risiedono proprio nella sua capacità di far “slittare” la lingua, di spostarla dai suoi binari abituali.Le Forze Liberatrici della Letteratura
La letteratura possiede diverse forze potenti. La prima è la Mathesis, che è la sua capacità di accogliere e far circolare il sapere. Agisce negli spazi lasciati liberi dalla scienza e permette di riflettere sul sapere in modo vivo e concreto, quasi teatrale. La seconda forza è la Mimesis, la capacità di rappresentare la realtà, anche quando questa realtà sembra non poter essere rappresentata. La letteratura insiste nel voler mostrare ciò che appare impossibile da descrivere, manifestando così una funzione che tende all’utopia. Questo è particolarmente vero nella modernità, dove si sono sviluppate utopie legate proprio al linguaggio. Questa visione implica un’etica: accettare che all’interno di una stessa lingua esistano in realtà molte “lingue” diverse. Questo permette a chi usa la lingua di scegliere le parole e le strutture in base al proprio desiderio, e non solo in base a regole imposte. La terza forza è la Semiosis, ovvero la capacità di far interagire i segni tra loro. È come mettere i segni in una “macchina” linguistica che disattiva i soliti meccanismi di controllo e di significato fisso.Un Approccio Diverso ai Segni: La Semiologia
Questa capacità di far giocare i segni porta alla semiologia, intesa però in un modo particolare. Non è una scienza rigida e definitiva dei segni, ma un lavoro che raccoglie ciò che la lingua tradizionale considera “impuro”, lo scarto che la linguistica classica non prende in considerazione. La semiologia proposta in questo contesto è “negativa” o “apofatica”. È negativa perché nega la possibilità di attribuire ai segni caratteristiche fisse e immutabili nel tempo. Non si pone al di fuori del linguaggio per studiarlo in modo distaccato, ma si sviluppa all’interno del gioco stesso dei segni. Ha un rapporto di “aiuto” con altre discipline, supportandole senza sostituirsi a esse. È una “semiotropia”, cioè un orientamento verso il segno, con cui si gioca come con un’illusione di cui si è consapevoli. I suoi oggetti di studio preferiti sono i testi che appartengono all’Immaginario, alla sfera del fantastico e del non reale.Un Contesto Culturale e un Metodo
Questo tipo di semiologia, legata alla letteratura e al gioco dei segni, nasce in un periodo culturale in cui l’idea del grande scrittore come figura intoccabile si affievolisce. La letteratura non è più vista come qualcosa da custodire gelosamente nelle istituzioni. Diventa piuttosto come un viaggio in un paesaggio libero, dove lo sguardo può posarsi su cose antiche e belle, provando un senso di piacere e godimento. Il metodo che deriva da questo approccio non cerca di trovare significati nascosti o di “decifrare” i testi in modo definitivo. Al contrario, mira a indebolire il potere del discorso, a renderlo meno impositivo. Si basa sulla frammentazione, sul dividere il testo in parti, e sulla digressione, sull’allontanarsi momentaneamente dall’argomento principale durante l’esposizione. È un po’ come il gioco di un bambino che si allontana per esplorare e poi torna. All’origine di questo modo di insegnare e pensare c’è un’idea, un desiderio che si allontana dal percorso atteso, quello che tradizionalmente sarebbe legato all’autorità o alla figura paterna.L’Esperienza del Disimparare
L’esperienza che si vive seguendo questo percorso è quella di “disimparare”, di lasciare che il tempo e l’oblio modifichino e riorganizzino le conoscenze accumulate. È come raggiungere un’età della Sapientia, della saggezza. In questa condizione non c’è potere da esercitare, ma si possiede un po’ di sapere, un po’ di saggezza e, soprattutto, si cerca di trovare quanto più sapore possibile nelle cose, un godimento autentico e libero.Se la lingua è una prigione “fascista”, come può una semiologia che si limita a “giocare” con i segni rappresentare una vera liberazione?
Il capitolo presenta un’idea potente della lingua come struttura di potere coercitivo, quasi una gabbia da cui fuggire. La letteratura e una particolare forma di semiologia sono indicate come vie di fuga, basate sul gioco e sullo “slittamento” dei segni. Tuttavia, non è del tutto chiaro come un approccio che resta comunque dentro il linguaggio, limitandosi a manipolarlo o a esplorarne gli scarti, possa effettivamente liberare dalla sua essenza impositiva e “fascista” descritta all’inizio. Il rischio è che si tratti più di un modo diverso di abitare la prigione, piuttosto che di uscirne. Per esplorare questa tensione e capire meglio le alternative, sarebbe utile confrontarsi con diverse visioni della lingua e del segno. Approfondire la linguistica strutturale, ad esempio Saussure, può aiutare a comprendere le basi del sistema linguistico che il capitolo critica. Esplorare altre correnti della semiotica, oltre a quella “negativa” proposta, può mostrare approcci diversi al significato e all’interazione dei segni. Infine, confrontarsi con autori come Barthes, che ha esplorato a fondo il rapporto tra testo, piacere e potere, o Foucault, che ha analizzato il potere insito nel discorso e nelle pratiche discorsive, può fornire strumenti critici per valutare l’efficacia liberatoria dell’approccio proposto nel capitolo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]