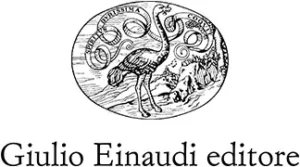Contenuti del libro
Informazioni
“Il primo libro di etica ambientale” di Robin Attfield è una guida super chiara per capire perché, oggi più che mai, dobbiamo pensare seriamente al nostro rapporto con il pianeta. Non è ambientato in un posto specifico, ma nel mondo che conosciamo, quello dell’Antropocene, dove l’impatto umano si vede ovunque, dalla deforestazione al cambiamento climatico. Il libro ti porta attraverso le idee fondamentali dell’etica ambientale, presentandoti pensatori che hanno cambiato il modo di vedere la natura, non solo come qualcosa da usare, ma con un suo valore intrinseco. Si parla di responsabilità intergenerazionale, cioè del casino che potremmo lasciare ai nostri nipoti e oltre, e di come affrontare il problema della non-identità, cioè come possiamo avere responsabilità verso persone che non esistono ancora e che potrebbero non esistere se facessimo scelte diverse. Attfield esplora diversi approcci etici, dal consequenzialismo al biocentrismo, per capire quale sia il migliore per guidare le nostre azioni. Non mancano temi super attuali come lo sviluppo sostenibile, la conservazione della biodiversità e, ovviamente, l’etica del cambiamento climatico, guardando anche al ruolo delle religioni e dei movimenti sociali. Alla fine, si interroga persino se il concetto stesso di natura sia ancora utile, arrivando a difenderne l’indispensabilità. È un libro che ti fa riflettere su questioni enormi con un linguaggio accessibile, perfetto per chi vuole capire le basi dell’etica ambientale e le sfide che abbiamo di fronte.Riassunto Breve
Il pianeta cambia tanto per colpa dell’uomo, siamo nell’Antropocene, un’era dove l’attività umana influenza tutto. Questo crea problemi come deforestazione, inquinamento e il clima che cambia. Prima non ci si pensava come a un’urgenza, ma ora si vede che i danni si possono evitare, così nasce l’etica ambientale. Pensatori come Leopold o Carson hanno fatto capire quanto la natura sia fragile. Altri, tipo Routley, hanno detto che non dobbiamo pensare solo agli umani. Naess ha parlato di ecologia profonda, che dice che tutte le forme di vita hanno lo stesso valore. Rolston dice che gli ecosistemi valgono di per sé, non solo per quello che ci danno. Concetti importanti sono cosa intendiamo per natura (non fatta dall’uomo), l’ambiente come un sistema unico. Si pensa che non solo gli umani abbiano ‘dignità morale’, ma anche gli esseri viventi che possono stare bene (biocentrismo). Il valore delle cose può essere ‘intrinseco’ (vale di per sé) o ‘strumentale’ (vale perché ci serve). L’ecocentrismo allarga ancora di più, dando valore a specie intere ed ecosistemi. Poi c’è la questione di chi viene dopo di noi. Già da tanto si pensa che le nostre azioni di oggi influenzano il futuro. Abbiamo una responsabilità verso i nostri discendenti, anche quelli lontani, soprattutto per cose che durano tanto come l’inquinamento o le scorie. C’è chi dice che non possiamo sapere chi saranno i futuri, ma l’importante è migliorare la vita media di chi verrà. Non si può dire ‘non ci penso’ solo perché è incerto o perché preferiamo le cose subito. Dobbiamo garantire ai futuri un ambiente sano. Per capire come agire, si guardano diverse idee etiche. Un’idea basata sui contratti tra persone non funziona bene per i futuri o gli animali. L’etica che guarda al carattere (virtù) è buona ma non basta se non pensa alle conseguenze. Le regole fisse (deontologia) servono, ma devono spiegare perché valgono per i nuovi problemi ambientali. Un’idea che guarda alle conseguenze delle azioni (consequenzialismo) sembra utile, specialmente se pensa al benessere di *tutti* i viventi, non solo umani (biocentrismo). Serve un mix di idee, ma il consequenzialismo biocentrico è un buon punto di partenza per la responsabilità verso il futuro e la natura. Questo porta a parlare di sviluppo sostenibile, che cerca di far andare d’accordo crescita e ambiente, pensando ai bisogni di oggi senza rovinare il futuro. C’è chi critica che non basta. È fondamentale salvare la varietà di vita (biodiversità), sia perché ci serve (farmaci, servizi) sia perché le specie hanno valore di per sé. Ripristinare gli ambienti rovinati è difficile, spesso si creano ‘nuovi ecosistemi’. Tanti gruppi diversi si occupano di questo: l’ecologia profonda che si sente parte della natura, l’ecofemminismo che lega l’oppressione delle donne allo sfruttamento della natura, l’ecologia sociale che dice che i problemi vengono dalla società, la giustizia ambientale che denuncia chi subisce di più i danni, i movimenti verdi che fanno politica per l’ambiente. Tutti insieme cercano soluzioni. Si guarda anche al ruolo delle religioni. Alcuni dicono che la tradizione cristiana ha portato a sfruttare la natura, ma altri dicono che c’è l’idea di ‘stewardship’, cioè gestire il creato in modo responsabile. Questa idea si trova anche in altre religioni e si può usare anche senza essere religiosi. Altre culture (orientali, indigene) hanno idee diverse sull’armonia con la natura. La sfida più grande oggi è il cambiamento climatico, causato dall’uomo. L’etica dice che dobbiamo agire subito per ridurre il danno, adattarci e aiutare chi è più debole. Ci sono idee su come dividere le responsabilità (tipo ‘Contrazione e Convergenza’) e accordi internazionali (Parigi). Servono energie pulite, riforestazione, modi di fare industria e trasporti più sostenibili. Le soluzioni tecnologiche estreme (geoingegneria) sono rischiose. Governi, aziende e persone singole hanno tutti la responsabilità di agire per il pianeta. Infine, c’è chi dice che dovremmo smettere di usare la parola ‘natura’. Alcuni pensano che non esista più qualcosa di incontaminato, o che la parola sia troppo confusa. Altri dicono che è solo una parola usata per dire cosa è giusto o sbagliato, sempre contro la ‘cultura’. Ma queste idee non convincono del tutto. L’universo ha cose naturali che non dipendono dall’uomo. E ‘natura’ ha tanti significati utili: non soprannaturale, non artificiale, la composizione delle cose. Capire la ‘natura’ di un organismo è fondamentale per capire il suo benessere e per l’etica. Senza questo concetto, è difficile giustificare valori importanti o capire noi stessi. La differenza tra sistemi naturali e sociali, basata sulla natura, serve per affrontare problemi globali come il clima. Capire e proteggere i sistemi naturali è vitale, e la parola ‘natura’ è uno strumento che ci serve per farlo.Riassunto Lungo
1. Le Fondamenta dell’Etica Ambientale
L’ambiente naturale sta cambiando molto a causa dell’azione dell’uomo. Si parla addirittura di Antropocene per indicare il periodo geologico attuale. Questa epoca è caratterizzata da quanto gli esseri umani influenzano il pianeta, cosa che si vede in problemi ambientali come la distruzione delle foreste, l’inquinamento e il cambiamento del clima. Un tempo questi problemi non sembravano urgenti, ma ora sappiamo che i danni si possono evitare. Per questo è nata l’etica ambientale.Figure chiave e nuove idee
Alcune persone sono state molto importanti per far capire quanto la natura sia fragile e quanto sia importante proteggere gli ecosistemi. Tra queste persone ci sono Leopold e Carson. Alcuni filosofi, come Routley, hanno messo in discussione l’idea tradizionale occidentale che mette l’uomo al centro di tutto. Routley ha proposto dei ragionamenti per far capire che dobbiamo considerare anche gli interessi degli esseri viventi non umani. Naess ha introdotto l’ecologia profonda, che sostiene che tutte le specie sono uguali e che ogni essere vivente deve potersi realizzare pienamente. Rolston ha sottolineato che gli ecosistemi hanno un valore di per sé, diverso dal valore che gli diamo noi in base a quanto ci servono.Concetti principali dell’etica ambientale
Per l’etica ambientale è importante capire bene cosa si intende per natura, distinguendola da ciò che è artificiale, e capire che l’ambiente è un sistema unico che riguarda tutto il mondo. Secondo Goodpaster, tutti gli esseri viventi capaci di stare bene hanno una loro importanza morale. Questa idea supera la visione tradizionale che mette l’uomo al centro e abbraccia invece il biocentrismo. Il valore, che sia un valore intrinseco o un valore utile per noi, è ciò che ci spinge a comportarci in modo etico. Il valore intrinseco, che riguarda il benessere degli esseri viventi e degli ecosistemi, è la base per un’etica ambientale che vuole proteggerli e rispettarli. L’ecocentrismo, infine, considera le specie e gli ecosistemi come entità che hanno un valore proprio, allargando ancora di più ciò che dobbiamo considerare dal punto di vista morale, andando oltre il singolo individuo.Ma se ogni specie ha valore uguale, come si gestiscono concretamente le scelte difficili tra tutela ambientale e necessità umane immediate?
Il capitolo introduce l’ecocentrismo come un ideale etico, ma lascia in sospeso la questione cruciale di come applicare concretamente questo principio in un mondo dove le necessità umane spesso entrano in conflitto con la tutela ambientale. Per rispondere a questa domanda, è necessario approfondire discipline come la filosofia morale, l’etica applicata e la politica ambientale. Autori come Peter Singer, con i suoi studi sull’etica pratica, e pensatori come Aldo Leopold, che ha proposto un’etica della terra, offrono prospettive utili per affrontare queste complesse sfide.2. Eredità Morale e Scelte Etiche
La Responsabilità Verso le Generazioni Future
La preoccupazione per chi verrà dopo di noi non è una novità recente. Già nell’Illuminismo si pensava che le nostre azioni di oggi avranno un impatto sul futuro. Si è così sviluppata l’idea di una responsabilità che lega le generazioni presenti a quelle future, anche le più lontane. Questa responsabilità si fa sentire soprattutto quando si considerano problemi ambientali che durano a lungo, come il cambiamento climatico causato dalle emissioni di carbonio o lo smaltimento delle scorie radioattive.Il Problema della Non-Identità: Una Sfida alla Responsabilità
Alcuni sollevano un dubbio importante, chiamato “problema della non-identità”. Se cambiamo le politiche di oggi, cambierà anche chi nascerà in futuro. Quindi, le nostre azioni non migliorerebbero la vita di persone specifiche che già esistono nel futuro, ma creerebbero persone diverse con vite diverse. Nonostante questo problema, si può rispondere che il nostro dovere è migliorare la qualità della vita futura in generale. Anche se non sappiamo chi saranno esattamente le persone del futuro, possiamo comunque impegnarci per un futuro migliore per tutti.Perché Preoccuparsi del Futuro? Superare Obiezioni e Preferenze Temporali
Non è giusto dire che gli interessi delle generazioni future non contano perché sono incerti o lontani nel tempo. Molte delle conseguenze negative delle nostre azioni di oggi sono prevedibili. Inoltre, non dovremmo dare più importanza ai nostri desideri immediati rispetto alla necessità di fare investimenti che porteranno benefici nel futuro. Pensare al futuro e agire di conseguenza è un atto di responsabilità.Bisogni Fondamentali e Azioni Concrete per il Futuro
Quando pensiamo alle generazioni future, è fondamentale concentrarsi sui loro bisogni primari, come avere un ambiente sano in cui vivere. Non possiamo sapere quali saranno i loro gusti o preferenze specifiche, ma possiamo fare delle scelte concrete per garantire loro un futuro vivibile. Il Protocollo di Montreal, un accordo internazionale per proteggere l’ozono, dimostra che è possibile agire concretamente per il bene del futuro. Per costruire un futuro sostenibile, è importante educare al rispetto dell’ambiente e adottare politiche che stabilizzino la popolazione mondiale. Inoltre, dovremmo trovare dei modi per dare voce agli interessi delle generazioni future nelle istituzioni che prendono decisioni, magari creando figure apposite o scrivendo garanzie nella Costituzione.Quali Principi Etici Guidano le Nostre Scelte?
Per capire come agire nel modo giusto, possiamo considerare diversi principi etici. Il modello contrattuale, che si basa su accordi tra persone razionali, non è molto utile quando si parla di generazioni future o di animali. L’etica della virtù, che guarda al carattere delle persone, è interessante ma non basta se non considera anche le conseguenze delle azioni. Le regole deontologiche, che si basano sul dovere, sono importanti ma hanno bisogno di essere giustificate meglio per affrontare i nuovi problemi ambientali.Verso un’Etica Ambientale Efficace: Il Consequenzialismo Biocentrico
Un approccio che sembra valido è quello consequenzialista. Questo approccio valuta le azioni in base ai risultati che producono. Se uniamo il consequenzialismo con una visione “biocentrica” del valore, otteniamo una prospettiva etica molto ampia. Un’etica biocentrica considera importante il benessere di tutti gli esseri viventi, sia quelli di oggi che quelli di domani. Questa visione supera i limiti di chi pensa che solo gli esseri umani siano importanti (antropocentrismo) o di chi si preoccupa solo degli esseri senzienti (sensiocentrismo). Per affrontare seriamente i problemi ambientali e la nostra responsabilità verso il futuro, è necessario mettere a confronto diverse idee etiche. Tuttavia, un’etica consequenzialista e biocentrica offre una base solida e completa per guidare le nostre azioni verso il futuro e la natura.Ma è davvero così solida e completa questa etica consequenzialista e biocentrica? Non rischia di semplificare eccessivamente la complessità delle scelte etiche ambientali, ignorando dilemmi pratici e teorici cruciali?
Il capitolo presenta l’etica consequenzialista biocentrica come una soluzione definitiva, quasi fosse l’unica risposta sensata alle sfide ambientali. Tuttavia, la realtà è che applicare un’etica biocentrica consequenzialista presenta sfide notevoli. Come si misurano e si confrontano le conseguenze per tutti gli esseri viventi? E chi decide cosa è “benessere” per una vasta gamma di specie diverse, alcune delle quali non conosciamo nemmeno bene? Per rispondere a queste domande, sarebbe utile approfondire le critiche al consequenzialismo, e studiare approcci etici alternativi, come l’etica della virtù applicata all’ambiente, o l’etica deontologica che pone vincoli morali intrinseci alle nostre azioni, indipendentemente dalle conseguenze. Autori come Martha Nussbaum, con il suo lavoro sulla giustizia animale e le capacità, o Holmes Rolston III, pioniere dell’etica ambientale, possono offrire spunti preziosi per arricchire la discussione.3. Armonie e Contrasti nell’Etica Ambientale
Lo Sviluppo Sostenibile: Un Equilibrio Necessario
Lo sviluppo sostenibile è diventato fondamentale per trovare un accordo tra il progresso e la protezione dell’ambiente. L’obiettivo principale è soddisfare i bisogni di oggi senza compromettere le possibilità delle generazioni future. Questa idea è stata promossa dal Rapporto Brundtland e dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) e Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si concentra sull’importanza di bilanciare la crescita economica, l’equità sociale e la tutela dell’ambiente. Nonostante la sua importanza, la sostenibilità ha ricevuto delle critiche. Alcuni esperti ritengono che non sia sufficiente per limitare l’utilizzo delle risorse naturali, mentre altri mettono in dubbio la sua effettiva applicazione pratica.La Conservazione della Biodiversità: Un Valore Cruciale
La protezione della biodiversità è un altro obiettivo molto importante, soprattutto considerando la rapida scomparsa di specie e ambienti naturali. Ci sono diverse ragioni per cui la conservazione è essenziale. Da un lato, ci sono motivazioni pratiche, come la possibilità di scoprire nuove medicine e il fatto che gli esseri umani dipendono dagli ecosistemi per molti servizi essenziali. Dall’altro lato, ci sono considerazioni etiche sul valore intrinseco della vita selvatica. Conservare la biodiversità richiede di fare delle scelte e di adattarsi, tenendo conto che gli ecosistemi cambiano continuamente e sono influenzati dalle azioni dell’uomo. Anche se recuperare gli ambienti naturali danneggiati è positivo, ci sono dei limiti e bisogna considerare la realtà dei “nuovi ecosistemi” che sono stati modificati dall’intervento umano.Movimenti Sociali e Politici per l’Etica Ambientale
Diversi movimenti sociali e politici partecipano al dibattito sull’etica ambientale, offrendo diverse prospettive e priorità.- Ecologia profonda: Questo movimento promuove un forte legame con la natura e riconosce un valore intrinseco a tutte le forme di vita.
- Ecofemminismo: Questo approccio evidenzia i collegamenti tra l’oppressione delle donne e lo sfruttamento dell’ambiente. Critica le divisioni nette e promuove un’etica basata sulla cura.
- Ecologia sociale: Questo movimento pone l’attenzione sulle cause sociali dei problemi ambientali e sostiene l’importanza di decisioni prese in modo democratico.
- Movimento per la giustizia ambientale: Questo movimento denuncia le ingiustizie nella distribuzione dei danni ambientali, che spesso colpiscono maggiormente le comunità più deboli.
- Movimenti verdi: Questi movimenti si impegnano attivamente nella politica per promuovere la sostenibilità, la riduzione delle emissioni inquinanti e il passaggio a fonti di energia rinnovabile. Si interrogano anche sulla compatibilità tra la difesa dell’ambiente e i modelli economici attuali.
Se la “stewardship” è un concetto così ampiamente accettato, perché non stiamo vedendo progressi più significativi nella protezione dell’ambiente?
Il capitolo introduce la “stewardship” come un principio guida per la responsabilità ambientale, suggerendo una diffusa accettazione di questo concetto. Tuttavia, la persistenza della crisi climatica e del degrado ambientale solleva interrogativi sulla sua efficacia pratica e sulla sua interpretazione. Per rispondere a questa domanda, è utile approfondire le diverse interpretazioni del concetto di “stewardship” all’interno delle tradizioni religiose e laiche, esaminando le critiche all’antropocentrismo e le barriere socio-economiche che ostacolano l’azione ambientale efficace, nonostante l’apparente consenso etico. Approfondimenti in filosofia ambientale, teologia ecologica e sociologia dell’ambiente potrebbero offrire una comprensione più critica e sfaccettata della questione.5. La Natura Indispensabile
Abbandonare il concetto di natura: un dibattito aperto
Si discute se sia necessario abbandonare il concetto di natura. Alcuni studiosi come Latour e Morton sostengono questa idea, partendo da diverse interpretazioni. Già in passato, McKibben e Vogel avevano espresso posizioni simili, affermando che la natura incontaminata non esiste più o che il termine stesso è diventato troppo ambiguo per essere utile. Nonostante queste opinioni, restano dei dubbi sulla validità di queste conclusioni. L’universo è immenso e contiene elementi naturali che esistono indipendentemente dall’uomo. Inoltre, la parola “natura” ha molti significati diversi e non si riferisce solo a ciò che è incontaminato.La critica di Latour: la natura come imposizione
Latour critica il termine “natura” perché lo considera un concetto che impone una certa visione del mondo e che viene sempre contrapposto alla cultura. Per questo motivo, Latour propone di eliminare del tutto questo termine. Questa critica, però, è troppo generalizzata. Spesso, “natura” è usato semplicemente per descrivere la realtà, soprattutto nelle scienze naturali, senza voler imporre nessuna particolare idea. Confondere le “leggi di natura” che descrivono i fenomeni, con la “legge naturale” che invece detta delle regole morali, è sbagliato.La visione di Morton: la natura come invenzione retorica
Morton, invece, ritiene che la natura sia solo un modo di dire, un concetto astratto senza una vera esistenza. Secondo Morton, solo i sostenitori di un ritorno al passato usano ancora questo termine. Pur criticando alcune posizioni ambientaliste, Morton ammette che un mondo naturale esiste. Tuttavia, la sua idea di “pensiero ecologico”, basata sul fatto che tutto è collegato a tutto, sembra troppo vaga e poco originale.Perché il concetto di natura è ancora fondamentale
Nonostante queste critiche, il concetto di natura è ancora indispensabile per diverse ragioni. In molte lingue, la parola “natura” ha diversi significati collegati tra loro, che si riferiscono a ciò che non è soprannaturale, a ciò che non è artificiale e alla composizione fondamentale delle cose. Questi significati sono utili e necessari per capire il mondo che ci circonda. La natura, intesa come l’insieme degli elementi che compongono gli organismi viventi, è essenziale per capire cosa serve al loro benessere e per riflettere sull’etica in generale. Se rinunciassimo a questo concetto, sarebbe difficile spiegare perché alcune cose sono importanti e capire la natura umana. Inoltre, distinguere tra sistemi naturali e sistemi sociali, basandosi proprio sull’idea di natura, è fondamentale per affrontare problemi globali come il cambiamento climatico. Capire e proteggere i sistemi naturali è cruciale per il futuro del pianeta e il concetto di natura è uno strumento indispensabile per raggiungere questo obiettivo.Il capitolo non rischia di semplificare eccessivamente le critiche al concetto di “natura” mosse da Latour e Morton, per poi difendere una visione forse troppo tradizionale e poco problematica di tale concetto?
Il capitolo presenta le posizioni di Latour e Morton in maniera piuttosto sintetica, quasi a volerle liquidare rapidamente per poi affermare con forza l’indispensabilità del concetto di natura. Tuttavia, le critiche di questi autori sono più articolate e mirano a mettere in luce come il concetto di natura sia storicamente e culturalmente costruito, e come possa essere utilizzato in modi problematici. Per comprendere meglio queste critiche, sarebbe utile approfondire il pensiero di Latour, in particolare i suoi lavori sulla sociologia della scienza e sulla critica al dualismo natura-cultura, e di Morton, con la sua riflessione sull’ecologia e sulla “iperoggetti”. Approfondire queste prospettive potrebbe arricchire la discussione e rendere la difesa del concetto di natura più consapevole delle sfide poste dal pensiero contemporaneo.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]