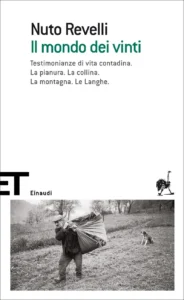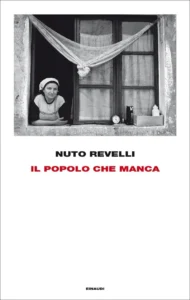1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
Il popolo che manca di Nuto Revelli ti porta dentro una realtà che sembra lontanissima, quella della vita contadina poverissima nelle montagne e colline italiane, soprattutto negli anni del boom economico. Nonostante l’Italia crescesse, qui la povertà rurale era estrema: si viveva di stenti, con cibo scarso e malattie diffuse, in case umide e con un lavoro durissimo che iniziava fin da bambini. Revelli racconta di un mondo patriarcale, dove le donne subivano violenze e i matrimoni erano affari tra famiglie. L’emigrazione italiana, verso la Francia o le Americhe, era spesso l’unica speranza per scappare da questa miseria, affrontando viaggi incredibili per trovare lavori pesanti ma pagati meglio. Le guerre, poi, hanno spezzato vite e comunità. Ma c’era anche una socialità forte nelle veglie, tra canti e storie di superstizione rurale come le masche. Questo libro è la memoria di un popolo che manca, di una cultura contadina che lo spopolamento montagna ha quasi cancellato, un racconto potente delle condizioni di vita contadini e della loro lotta per sopravvivere.Riassunto Breve
Durante il boom economico, mentre l’industria e l’agricoltura più ricca crescono, la piccola proprietà contadina e le zone rurali povere entrano in crisi profonda. Molti giovani lasciano la terra, specialmente in montagna e collina, per cercare lavoro nelle fabbriche, causando un grande spopolamento. La vita in questi luoghi è durissima, segnata dalla miseria e dalla fatica quotidiana. Si mangia principalmente polenta, patate e castagne; il pane è raro. I vestiti sono fatti in casa. La salute è precaria, con molte malattie diffuse e cure basate su rimedi popolari, mentre la mortalità infantile è alta. La famiglia è organizzata in modo patriarcale, anche se le donne lavorano moltissimo sia in casa che nei campi e subiscono violenze; i matrimoni sono spesso decisi dalle famiglie per interesse economico, a volte con l’aiuto di mediatori. Le ragazze madri vengono messe da parte dalla comunità. Il lavoro inizia da bambini, che vengono affittati per lavorare altrove. L’emigrazione, sia per brevi periodi che per sempre, verso la Francia o le Americhe, è l’unica via per sperare in una vita migliore, anche se i viaggi sono difficili e il lavoro all’estero è pesante. Le guerre, come la Grande Guerra e quelle fasciste, interrompono l’emigrazione e portano morte e sofferenza, costringendo i contadini ad arruolarsi senza capire perché e a vivere esperienze terribili al fronte; dopo l’8 settembre 1943, molti si uniscono ai partigiani. La vita sociale si concentra nelle veglie serali, dove si raccontano storie e si parla di credenze popolari, come la paura delle “masche” (streghe), figure ritenute capaci di fare del male, una credenza che si mescola alla fede religiosa. La religione è importante, con preghiere e riti, ma accanto ad essa ci sono superstizioni e figure come le “desmentiòure” che cercano di curare mali o togliere malefici. A partire dalla fine degli anni Cinquanta, si diffondono i matrimoni tra uomini del Nord e donne del Sud, che si spostano per sposarsi e cercare condizioni migliori, affrontando difficoltà di adattamento. Intanto, i paesi di montagna continuano a svuotarsi, le case crollano, i servizi chiudono e la terra viene abbandonata, perdendo la sua gente e il suo modo di vivere tradizionale.Riassunto Lungo
1. Un mondo che scompare: vita e miseria nella campagna povera
Negli anni del boom economico, mentre l’industria e l’agricoltura più ricca crescono, la piccola proprietà contadina e le zone rurali più povere affrontano una profonda crisi. I giovani iniziano a lasciare la terra in massa, attratti dalla possibilità di trovare lavoro nelle fabbriche delle città. Questo porta a un grande esodo, specialmente dalle aree di montagna e collina, svuotando paesi e campagne. Le scelte politiche di quel periodo favoriscono in modo deciso l’industrializzazione, senza però considerare l’importanza di mantenere un equilibrio con le forme tradizionali di agricoltura che per secoli avevano sostenuto intere comunità.La vita quotidiana e la povertà
La vita in questo mondo rurale in declino è segnata da una miseria diffusa e da una fatica incessante che iniziava fin dalle prime ore del giorno. L’alimentazione delle famiglie contadine è estremamente povera, basata prevalentemente su pochi alimenti come patate, castagne e polenta, mentre il pane è considerato un lusso raro e prezioso. Anche l’abbigliamento riflette questa povertà: i vestiti sono fatti in casa, spesso tessuti con materiali semplici come lana grezza e canapa, resistenti ma poco confortevoli. La salute è precaria per tutti, con un’alta incidenza di malattie legate alla malnutrizione e alle dure condizioni di vita, come il gozzo e il nanismo. Queste malattie vengono spesso curate con rimedi popolari tramandati di generazione in generazione, ma che risultano approssimativi e poco efficaci. La mortalità infantile è particolarmente elevata, e la perdita dei bambini viene spesso attribuita a mali misteriosi o a forze oscure, segno della mancanza di conoscenze mediche e delle difficili condizioni igieniche.La struttura familiare e il lavoro
La struttura della famiglia è fortemente patriarcale, con la figura maschile che detiene l’autorità principale, anche se le donne svolgono un ruolo cruciale nella gestione della casa, dei figli e spesso anche dei lavori agricoli più leggeri. Nonostante il loro ruolo fondamentale, le donne sono spesso soggette a violenze e soprusi all’interno delle mura domestiche. Il matrimonio non è una scelta d’amore, ma si basa su accordi tra famiglie e sull’interesse economico, a volte facilitato da mediatori che combinano le unioni. Le ragazze madri sono duramente giudicate e condannate dalla comunità, trovandosi spesso isolate ed emarginate. Il lavoro è una costante fin dalla più tenera età: i bambini sono costretti a lavorare duramente nei campi o vengono addirittura “affittati” ad altre famiglie in pianura o mandati a lavorare in Francia come manodopera a basso costo. In questo contesto, la forza fisica non è solo una qualità, ma un valore centrale, quasi l’unico capitale a disposizione per affrontare la fatica quotidiana e garantire la sopravvivenza.L’emigrazione e le guerre
Di fronte a una vita così difficile, l’emigrazione rappresenta spesso l’unica vera via di scampo dalla povertà estrema e dalla mancanza di opportunità. Molti partono, a volte solo stagionalmente per trovare lavoro nei periodi di maggiore richiesta in altre regioni o nazioni, altre volte in modo permanente, dirigendosi verso paesi come la Francia o le lontane Americhe nella speranza di un futuro migliore. Questi flussi migratori, vitali per l’economia delle comunità di origine che ricevevano le rimesse degli emigrati, vengono bruscamente interrotti dalle guerre. Conflitti come la guerra di Libia e soprattutto la Grande Guerra richiamano gli uomini al fronte e lasciano un segno profondo e doloroso nelle comunità rurali, che perdono i loro giovani e vedono alterati i loro equilibri sociali ed economici.Le veglie e le credenze popolari
Nonostante la fatica e le difficoltà, esistono momenti di socialità e condivisione. Le veglie serali, che si svolgono solitamente nelle stalle per sfruttare il calore degli animali, sono occasioni importanti per riunirsi. Durante le veglie, ci si racconta storie antiche, si gioca a carte e si discute delle credenze popolari che permeano la vita quotidiana. Tra queste, la paura delle “masche”, figure simili a streghe, è particolarmente forte e diffusa. Questa superstizione si lega spesso al ruolo del clero locale: alcuni preti sono figure positive, vicini ai bisogni dei poveri e impegnati ad aiutarli, mentre altri sono corrotti, ignoranti o addirittura contribuiscono ad alimentare queste credenze popolari e le paure ad esse connesse, mantenendo le comunità nell’oscurità.La scomparsa di un mondo
Questa particolare cultura contadina, ricca di saperi pratici legati alla sopravvivenza in un ambiente difficile e intrisa di tradizioni che affondano le radici in un passato lontano, è destinata a scomparire. L’abbandono progressivo dei paesi e delle campagne, causato dall’emigrazione e dal cambiamento economico, porta al degrado delle case e alla perdita delle pratiche quotidiane. La memoria di questo mondo che svanisce è affidata alle testimonianze dirette di coloro che l’hanno vissuto in prima persona, le ultime voci capaci di raccontare la fatica, le speranze e le credenze di una civiltà rurale ormai consegnata al passato.Ma davvero la scomparsa di quel mondo rurale era l’unica via possibile, o fu l’esito inevitabile di precise scelte politiche che avrebbero potuto essere diverse?
Il capitolo descrive con efficacia la fine di un mondo, ma sorvola sulle ragioni profonde e sulle alternative mancate che portarono a tale esito. Non si analizza a sufficienza il contesto delle decisioni politiche ed economiche che favorirono un certo tipo di sviluppo a scapito di altri, né si esplorano modelli diversi che avrebbero potuto preservare o trasformare in modo differente le comunità rurali. Per comprendere meglio questo passaggio cruciale, sarebbe utile approfondire la storia economica e sociale italiana del dopoguerra, la sociologia rurale e l’analisi delle politiche agrarie. Autori come Emilio Sereni o Manlio Rossi-Doria offrono prospettive fondamentali su queste dinamiche.2. La dura lotta per vivere e l’altrove cercato
La vita nelle comunità rurali è segnata da condizioni di estrema povertà e fatica. Le famiglie sono numerose, e le donne affrontano gravidanze frequenti e parti spesso difficili, assistite da “donne pratiche” o, in caso di complicazioni, da ostetriche. La mortalità infantile è alta, attribuita a malattie misteriose o al destino. Dopo il parto, le donne seguono riti religiosi e tradizionali, come la benedizione e il seppellimento della placenta, per evitare malocchi e sventure. Le cure mediche formali sono scarse; si ricorre a rimedi casalinghi come impacchi di petrolio, decotti, o persino brodo di topo. L’ospedale è visto con timore e diffidenza.L’alimentazione quotidiana
L’alimentazione si basa principalmente su polenta, patate, castagne e pane fatto con cereali misti o selvatici, cotto una volta all’anno. Carne e vino sono consumati molto raramente, solo nelle occasioni speciali. Il cibo è spesso monotono e scarso per tutti. Durante i pasti, si mangia separatamente per genere, con le donne che hanno il compito di servire e mangiano in piedi, a testimonianza di una rigida divisione dei ruoli e di una condizione di subalternità.Il lavoro e lo sfruttamento
Il lavoro inizia in età molto precoce sia per i bambini che per le bambine. Vengono impiegati come “vaché” o “servente” in cambio di vitto e alloggio, spesso in condizioni igieniche precarie e con orari estenuanti. Le attività principali includono il lavoro della terra, l’allevamento di bachi da seta e la filatura di canapa e lana. Le donne, in particolare, svolgono lavori fisicamente pesanti nei campi, come rompere le zolle con la zappa. Una fonte di guadagno, soprattutto per le ragazze, è la vendita dei capelli lunghi, tagliati per ottenere stoffa o pochi soldi, un segno visibile e doloroso della miseria diffusa.L’emigrazione come speranza
L’emigrazione, sia stagionale che permanente, verso la Francia o le Americhe (come Argentina e Stati Uniti), rappresenta l’unica via per cercare condizioni di vita migliori. Si parte a piedi o con mezzi di fortuna, affrontando viaggi lunghi e disagiati, dormendo in condizioni affollate e insalubri. All’estero si trovano lavori pesanti in agricoltura, miniere o edilizia, spesso senza tutele o garanzie. Nonostante le difficoltà, si mantiene la speranza di guadagnare abbastanza per comprare un piccolo pezzo di terra o migliorare la situazione familiare in patria. La vita all’estero è dura, ma la paga, seppur modesta per gli standard locali dei paesi di destinazione, è significativamente superiore a quella ottenibile nel luogo d’origine.Ma di quali comunità rurali stiamo parlando, e in che epoca?
Il capitolo descrive con efficacia le condizioni di vita estreme, l’alimentazione misera e la fatica del lavoro nelle campagne, culminando nell’analisi dell’emigrazione come unica via di fuga. Tuttavia, la narrazione rimane sospesa in un tempo e in uno spazio indefiniti, rendendo difficile valutare la specificità di queste esperienze. Le condizioni di povertà e le dinamiche migratorie variavano enormemente a seconda della regione italiana e del periodo storico considerato. Per fornire un quadro più solido, sarebbe fondamentale contestualizzare geograficamente e cronologicamente le vicende narrate, magari approfondendo la storia dell’Italia post-unitaria o del primo Novecento. Studi di autori come Emilio Sereni o Paul Ginsborg potrebbero aiutare a comprendere meglio le diverse realtà rurali e le loro trasformazioni.3. Matrimoni, lavoro e vita sociale nella campagna di una volta
Il matrimonio è spesso combinato dai genitori, che cercano unioni basate sulla convenienza economica e sulla proprietà terriera. Figure come il mediatore facilitano questi accordi tra famiglie, a volte ricevendo un compenso per il loro ruolo. Le donne lavorano duramente sia nei campi che in casa, svolgendo fatiche pari a quelle degli uomini. Nonostante questo impegno, in casa l’autorità spetta interamente all’uomo, a cui si deve obbedienza e rispetto. La conoscenza sul sesso è scarsa o del tutto assente, spesso basata unicamente su divieti e sulla paura delle conseguenze. Questo porta a una notevole impreparazione per la vita matrimoniale e, in alcuni casi, a gravidanze prima delle nozze. Le ragazze madri sono spesso emarginate dalla famiglia d’origine e dalla comunità locale. In passato, a causa della mancanza di opzioni e della diffusa miseria, alcune donne ricorrevano a metodi clandestini e pericolosi per interrompere gravidanze indesiderate.Vita Sociale e Nuove Unioni
La vita sociale si svolge principalmente nelle veglie serali, momenti di ritrovo che si tengono specialmente nelle stalle durante l’inverno per trovare riparo dal freddo. Qui le persone si riuniscono per filare la lana, cantare vecchie canzoni, ballare al suono di qualche strumento improvvisato e giocare a carte. Il gioco d’azzardo è molto diffuso tra gli uomini, coinvolgendo persone di ogni ceto sociale, e può portare a perdite economiche importanti per le famiglie. A partire dalla fine degli anni Cinquanta, si diffondono nuovi tipi di unioni, come i matrimoni tra uomini del Nord Italia e donne del Sud, spesso combinati tramite lo scambio di fotografie e l’aiuto di mediatori. Queste donne emigrano dalle loro regioni d’origine per sposarsi, cercando migliori condizioni di vita rispetto alla povertà e al duro lavoro che affrontavano nei loro paesi. L’ambientamento nel nuovo contesto è spesso difficile, richiede di imparare un nuovo dialetto e adattarsi a usanze e tradizioni diverse rispetto a quelle a cui erano abituate. A volte, le donne del Sud devono affrontare la diffidenza o il pregiudizio da parte della comunità locale di arrivo. Le feste di matrimonio tradizionali che seguono queste unioni prevedono riti specifici che variano a seconda delle usanze regionali e grandi pranzi che riuniscono le famiglie per celebrare l’evento.Come si concilia, nel vissuto di queste comunità, una fede religiosa così radicata con la persistenza di credenze nelle “masche” e il ricorso a pratiche magiche?
Il capitolo descrive efficacemente la compresenza di devozione religiosa e credenze nelle “masche”, ma non approfondisce il meccanismo logico o psicologico che permette a queste due sfere, apparentemente in contraddizione, di coesistere e intrecciarsi nella vita quotidiana. Per esplorare questa complessa dinamica, sarebbe utile rivolgersi agli studi di antropologia e storia delle religioni popolari, considerando autori che hanno analizzato il sincretismo e la magia nel contesto europeo, come Carlo Ginzburg o Ernesto De Martino.5. Il Prezzo della Terra e della Guerra
Le guerre sono una maledizione, peggiori delle calamità naturali, che portano fame e distruzione nella vita dei contadini. Anche i più fragili vengono arruolati e mandati al fronte, spinti solo dal dovere imposto, senza comprendere le ragioni politiche che li muovono. Le esperienze al fronte sono segnate da condizioni estreme come sete, fame, sporcizia, malattie e la brutalità dei combattimenti corpo a corpo. Spesso gli ufficiali mostrano disprezzo per i soldati contadini, considerati semplicemente carne da cannone. La guerra del 1915 sconvolge profondamente la società contadina. La guerra fascista causa la perdita di un’intera generazione giovane. Dopo l’8 settembre 1943, molti contadini si uniscono alla resistenza partigiana, vedendo i fascisti come stranieri pericolosi e una minaccia diretta.Il declino della montagna
Parallelamente alle difficoltà della guerra, le comunità montane affrontano un declino inesorabile. I paesi si svuotano, le case crollano, e i servizi essenziali come scuole e uffici postali chiudono uno dopo l’altro. I giovani lasciano la montagna per cercare lavoro nelle fabbriche in pianura, lasciando indietro una popolazione prevalentemente anziana. Di conseguenza, la terra, un tempo curata con dedizione, viene abbandonata e invasa dai rovi. La mancanza di strade e infrastrutture adeguate rende ancora più difficile la vita e il lavoro in queste aree. Anche il turismo, a volte, non risolve il problema dello spopolamento, anzi, può evidenziare le differenze e portare disagi aggiuntivi. La montagna sta perdendo la sua gente e con essa il suo modo di vivere tradizionale.Il capitolo accosta il ‘Prezzo della Terra’ al ‘Prezzo della Guerra’. Ma il legame tra il dramma bellico e lo spopolamento montano è così diretto come suggerisce il titolo?
Il capitolo presenta il dramma della guerra e il declino delle comunità montane come fenomeni paralleli, ma non esplicita in modo causale come le specifiche guerre menzionate abbiano determinato direttamente i fattori principali dello spopolamento, come la ricerca di lavoro in pianura, la mancanza di infrastrutture o l’abbandono delle terre. Per comprendere la complessità di tali processi, che spesso affondano le radici in trasformazioni economiche e sociali di più ampio respiro, sarebbe utile approfondire la storia rurale, la storia economica e la sociologia del territorio, esplorando autori che hanno analizzato le dinamiche demografiche e socio-economiche delle aree interne italiane nel corso del Novecento.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]