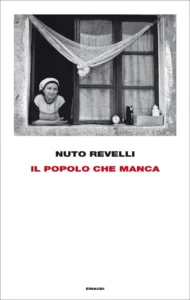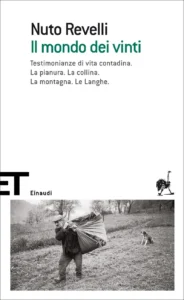1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il popolo che manca” di Nuto Revelli ci porta nelle `campagne cuneesi` per scoprire la `vita contadina` di un’Italia che cambiava velocemente. È un viaggio nel cuore del `boom economico Italia`, ma visto dalla parte di chi quel progresso non l’ha cavalcato, anzi, ne è stato schiacciato: i `vinti`. Revelli raccoglie le `voci` e le `testimonianze rurali` di queste persone, un `popolo che manca` perché la modernità e l’`emigrazione rurale` lo stavano svuotando. Attraverso le loro parole, emerge un mondo fatto di `povertà rurale` estrema, lavoro durissimo fin da bambini, una `cultura contadina` ricca di saperi antichi ma anche di superstizioni (`masche`), l’ombra costante della `guerra` che ha segnato generazioni, e la lotta quotidiana per la sopravvivenza. Non ci sono personaggi singoli, ma un coro di `testimoni` che raccontano `storie di montagna` e di pianura, di fatica, dignità e di un mondo che, piano piano, scompare. È un libro potente che ci fa capire da dove veniamo e cosa abbiamo perso.Riassunto Breve
La vita nelle campagne, come quella delle zone montane, è segnata da una povertà diffusa e da condizioni di esistenza difficili. Le famiglie sono spesso numerose, ma la sopravvivenza dei bambini è incerta a causa dell’elevata mortalità infantile e della mancanza di cure adeguate. L’alimentazione è povera e ripetitiva, basata su pochi ingredienti come polenta, patate e castagne, mentre carne e pane bianco sono rari lussi. La fame è una realtà costante, affrontata con ingegno per preparare piatti semplici ma nutrienti. Il vestiario è essenziale e logoro, e persino i capelli possono diventare merce di scambio nei momenti di estrema miseria. La medicina popolare, spesso inefficace, è l’unica risorsa contro le malattie, e l’ospedale è visto come un’ultima speranza. Il lavoro nei campi è estenuante e coinvolge tutti, inclusi i bambini fin da piccoli. La servitù è una condizione comune. L’emigrazione, stagionale o definitiva, rappresenta una via di fuga dalla miseria, portando molti a cercare fortuna in Francia o nelle Americhe. La struttura familiare è patriarcale, con le donne che sopportano grandi sacrifici pur avendo un ruolo centrale nella gestione della casa. Il matrimonio è spesso combinato, un affare economico e sociale con rituali precisi. La sessualità è un argomento tabù, avvolto nel silenzio e nella vergogna, portando a ignoranza e paura, specialmente nelle donne, e a pratiche rischiose come l’aborto clandestino. Nonostante le difficoltà, esistono momenti di socialità come le veglie nelle stalle o il ballo, anche se il gioco d’azzardo è un vizio diffuso tra gli uomini. A partire dagli anni ’50, si diffondono i matrimoni tra uomini del Nord e donne del Sud, facilitati da mediatori, che generano sfide di adattamento culturale ma anche nuove opportunità. La religiosità popolare è forte, fatta di pratiche quotidiane e rispetto per le figure ecclesiastiche, che possono essere viste sia come guide che come oggetti di critica. Questa fede convive con un mondo di superstizioni e magia, dove le “masche” incarnano paure ancestrali e si ricorre a pratiche magiche per protezione e cura. La guerra è una presenza costante e devastante, peggiore di ogni calamità naturale. Le case conservano i segni dei conflitti passati, e il ricordo della guerra riaffiora facilmente. Le esperienze belliche, dalla Libia alla Prima Guerra Mondiale, sono vissute come un massacro senza senso, fatto di fame, pidocchi, fango e ordini disumani. La guerra lascia traumi profondi e decima generazioni. Dopo i conflitti, le zone montane si spopolano, i paesi si svuotano, le scuole chiudono e l’isolamento aumenta. I giovani emigrano verso le fabbriche in pianura, lasciando gli anziani soli. La montagna appare abbandonata, priva di servizi essenziali, e il turismo non risolve i problemi, anzi, accentua il divario e accelera la perdita di identità. La montagna muore lentamente, in silenzio, lasciando solo i ricordi di una vita passata. Le testimonianze orali raccolte danno voce a questo mondo di difficoltà, resilienza e progressiva scomparsa, preservando la memoria di una cultura contadina arcaica e resistente.Riassunto Lungo
1. Voci dalla Terra dei Vinti
Il contesto storico e sociale
Durante il boom economico italiano, le campagne cuneesi hanno vissuto un periodo di grandi cambiamenti. Questo capitolo analizza la vita dei “vinti” in queste zone, ispirandosi alle opere di Nuto Revelli. Nonostante la rapida crescita industriale del Paese, le piccole proprietà agricole entrarono in crisi e le aree rurali si impoverirono. I giovani, attratti dalle opportunità offerte dalle fabbriche, abbandonarono la terra, mentre la politica si concentrava sul progresso industriale, trascurando la difficile situazione dei contadini poveri.Le testimonianze e i temi principali
La ricerca si basa su testimonianze raccolte nel corso del tempo, che rivelano una cultura di persone abituate a sopravvivere in condizioni estreme. Queste storie di vita sono state raggruppate per temi principali, come il lavoro, l’alimentazione, la guerra e la magia. In questo modo, emerge il quadro di una cultura antica e resistente, con proprie regole e usanze. Rispetto ai libri di Revelli, questo studio non si concentra tanto sulle storie personali o sui luoghi specifici, ma cerca di mettere in luce gli aspetti culturali più profondi e generali di questo mondo contadino.Aspetti della vita quotidiana
La vita di queste persone era caratterizzata da diversi aspetti importanti. I rituali legati alla nascita e all’infanzia avevano un ruolo centrale, così come il difficile percorso di crescita e apprendimento della vita. L’alimentazione, pur essendo povera, era ricca di saperi tradizionali. Le pratiche mediche erano spesso rudimentali. I legami sociali erano molto forti, ma esistevano anche conflitti intensi. I bambini erano spesso sfruttati come forza lavoro, subendo un vero e proprio “spossessamento” del proprio corpo. Lavoro ed emigrazione erano strettamente legati, con spostamenti continui di lavoratori stagionali e migrazioni verso la Francia e le Americhe in cerca di migliori opportunità.Famiglia, credenze e guerra
La famiglia era organizzata in modo patriarcale, con le donne che si sobbarcavano grandi sacrifici, pur essendo fondamentali nella gestione della casa. La fede religiosa e la magia convivevano, con figure religiose a volte ambigue e la presenza delle “masche”, figure misteriose legate a paure e antiche superstizioni. La guerra era un’esperienza costante che segnava profondamente le persone, attraversando intere generazioni e diversi fronti.Povertà, emigrazione e memoria
La povertà era una condizione molto diffusa, che limitava l’accesso alla sanità, all’istruzione e a beni essenziali come il pane. L’emigrazione rappresentava spesso una via di fuga obbligata per migliorare le proprie condizioni di vita. Le testimonianze orali, raccolte grazie all’aiuto di persone che facevano da intermediari, restituiscono un quadro di grande difficoltà, ma anche di forte capacità di resistenza e di una cultura contadina che stava scomparendo. L’obiettivo principale di questo studio è dare voce a questi “testimoni”, rispettando pienamente i loro racconti senza modificarli.Ma definire queste comunità rurali solamente come “vinti” non rischia di appiattire la complessità delle loro reazioni e strategie di fronte ai cambiamenti del boom economico?
Il capitolo, pur descrivendo efficacemente le difficoltà incontrate dalle comunità rurali, utilizza la categoria di “vinti” che potrebbe risultare eccessivamente passiva. Sarebbe utile interrogarsi se questa definizione non limiti la comprensione delle capacità di resilienza e delle forme di resistenza messe in atto da queste popolazioni. Per approfondire questa prospettiva, si suggerisce di esplorare studi di antropologia e sociologia rurale che analizzano le dinamiche di potere e le strategie di adattamento in contesti di marginalità, come ad esempio le opere di Pierre Bourdieu, che offrono strumenti concettuali utili per decostruire categorie semplicistiche e comprendere le complesse interazioni tra strutture sociali e agency individuale.2. Corpi e Campagne: Un Secolo di Vita Rurale Italiana
Difficoltà alla nascita e mortalità infantile
La vita in campagna in Italia, fino a non molti anni fa, era difficile fin dalla nascita. Le famiglie avevano molti figli, ma tanti bambini morivano nei primi anni di vita. Per questo motivo, la nascita e i primi mesi dei neonati erano accompagnati da riti religiosi e credenze popolari. Questi riti mostrano quanto la società rurale fosse legata alle tradizioni antiche. In caso di malattia, le persone si affidavano alla medicina popolare, che spesso non funzionava ed era rischiosa. L’ospedale era considerato l’ultima possibilità, e la morte, soprattutto infantile, era frequente e accettata.Alimentazione e scarsità di risorse
Il cibo era semplice e sempre uguale: soprattutto polenta, patate e castagne. Mangiare carne e pane di grano era raro, considerato un lusso. La fame era un problema costante. Le persone usavano la loro creatività per preparare piatti nutrienti con quello che avevano a disposizione, anche se povero. La mancanza di risorse si faceva sentire in ogni aspetto della vita, dal cibo ai vestiti.Vestiti semplici e lavoro nei campi
I vestiti erano semplici e dovevano essere utili per il lavoro. Le scarpe non erano adatte e i vestiti venivano riparati molte volte per farli durare di più. Nei periodi di grande povertà, anche i capelli potevano essere venduti per ottenere qualcosa di necessario per vivere. Il lavoro nei campi era molto faticoso e continuo. Uomini, donne e bambini lavoravano nei campi fin da piccoli. Molte persone erano serve, e per scappare dalla povertà e dalla fame, spesso l’unica soluzione era emigrare. Si andava in Francia per lavoro stagionale, oppure in America per cambiare vita per sempre. La vita era una lotta continua per sopravvivere, piena di sacrifici, malattie e lavoro pesante. Nonostante le difficoltà, la comunità era molto unita e le tradizioni erano importanti.Ma il capitolo non rischia di presentare un quadro eccessivamente idilliaco delle tradizioni rurali, dimenticando le loro intrinseche limitazioni di fronte a problemi concreti come malattie e povertà?
Affermare che la società rurale fosse legata alle tradizioni è un’affermazione generica. Per comprendere appieno il ruolo delle tradizioni, sarebbe necessario analizzare criticamente come queste tradizioni abbiano effettivamente influenzato la capacità delle comunità rurali di affrontare le sfide quotidiane. Approfondimenti in antropologia culturale e storia sociale potrebbero offrire strumenti utili per valutare in modo più critico il rapporto tra tradizioni, resilienza e progresso nelle società rurali del passato. Si consiglia di approfondire autori come Ernesto De Martino, che ha studiato le culture popolari del Sud Italia.3. Legami e Tradizioni
La vita di coppia e le norme sociali
La vita di coppia nelle campagne era molto regolamentata da regole sociali rigide. L’età e l’appartenenza alla generazione definivano in modo preciso i comportamenti accettabili. La vita privata delle coppie era molto limitata, perché la comunità locale controllava costantemente ogni aspetto della loro esistenza. C’era molta ignoranza sul tema della sessualità, mantenuta di proposito attraverso il silenzio e la mancanza di dialogo aperto. Nonostante questa repressione, la sessualità esisteva e si manifestava, a volte in modo più libero di quanto le apparenze lasciassero intendere, come dimostrano i casi frequenti di gravidanze che avvenivano prima del matrimonio.Il matrimonio come affare familiare
Il matrimonio non era considerato una scelta individuale, ma piuttosto un affare che riguardava interamente le famiglie. Spesso, infatti, erano i genitori a decidere l’unione dei figli, ricorrendo a mediatori per combinare i matrimoni. La donna che viveva in campagna lavorava duramente quanto un uomo nei campi, ma in casa era comunque sottoposta all’autorità maschile del marito. Il matrimonio rappresentava un passaggio importante sia dal punto di vista economico che sociale, e la dote e il corredo della sposa avevano un valore significativo. Le nozze erano celebrate seguendo rituali ben precisi, che includevano pranzi separati per uomini e donne e usanze locali caratteristiche, come “la sparada” e “la ciabra”.Sessualità e silenzi
L’argomento del sesso era considerato un tabù in questo contesto sociale, avvolto da un senso di peccato e da un silenzio opprimente. Non esisteva alcuna forma di educazione sessuale, e questa mancanza di informazione generava paure e incomprensioni, soprattutto nelle donne. Molte donne vivevano il rapporto sessuale all’interno del matrimonio come un dovere sgradevole, e quindi sperimentavano la sessualità con sentimenti di vergogna e timore. Nonostante i rischi e la condanna sociale, l’aborto clandestino era una pratica diffusa, segno della disperazione di molte donne e della mancanza di alternative accettabili.Socialità e svaghi
Le stalle non erano solo luoghi di lavoro, ma anche importanti spazi di socialità serale. Qui, i giovani si incontravano per attività come filare la lana, ma anche per giocare e per avviare relazioni di corteggiamento. Il ballo rappresentava un’altra forma di svago e socializzazione, anche se da alcuni era visto con sospetto e disapprovazione. Il gioco d’azzardo era un passatempo molto diffuso, ma anche un vero e proprio vizio tra gli uomini di tutte le classi sociali. Osterie e cascine diventavano spesso centri di gioco, attività che a volte portava con sé gravi conseguenze economiche per le famiglie.I matrimoni misti degli anni ’50
A partire dagli anni ’50 del Novecento, si diffusero i cosiddetti “matrimoni misti”, cioè unioni tra donne provenienti dal Sud Italia e uomini del Nord. Questi matrimoni erano spesso facilitati da persone che si proponevano come “piazzisti” matrimoniali, utilizzando fotografie per far conoscere e combinare le coppie. Le donne meridionali, spinte da condizioni economiche e sociali difficili nelle loro regioni di origine, vedevano nel matrimonio con uomini del Nord la possibilità di costruirsi una nuova vita e migliorare la propria condizione. L’incontro tra culture diverse generava inevitabilmente sfide di adattamento e integrazione, ma allo stesso tempo creava nuove opportunità e legami familiari che arricchivano il tessuto sociale.Ma è davvero così singolare questo “doppio mondo”?
Il capitolo descrive la compresenza di fede religiosa e credenze magiche nelle comunità rurali quasi fosse una specificità locale, trascurando un aspetto fondamentale: la coesistenza di elementi religiosi ufficiali e credenze popolari è un fenomeno ampiamente documentato in diverse culture e periodi storici. Per una comprensione più approfondita, sarebbe utile esplorare studi antropologici e sociologici sulla religione popolare e il sincretismo religioso. Autori come Ernesto de Martino o Mircea Eliade potrebbero offrire preziose chiavi di lettura per interpretare queste dinamiche in un contesto più ampio e comparativo.5. Echi di Battaglia, Silenzi di Montagna
La Guerra come Presenza Costante
La guerra è una realtà sempre presente nella vita dei contadini, considerata una sciagura peggiore delle calamità naturali. Le case rurali conservano ancora i segni dei conflitti passati, spesso visibili nelle fotografie dei soldati caduti. Il ricordo della guerra è sempre vivo e basta poco a risvegliarlo: un pezzo di pane può far tornare alla mente la fame del passato, oppure la neve grigia può evocare le ritirate militari e le notti trascorse all’aperto.La Guerra di Libia e la Prima Guerra Mondiale
La guerra in Libia è ricordata come un evento privo di senso e lontano dalle motivazioni patriottiche. Fu un periodo segnato da grande sofferenza, sete, malattie e violenze contro le popolazioni locali. La Prima Guerra Mondiale ebbe un impatto devastante sulla società contadina, trasformando anche i più deboli in soldati da mandare al fronte. I contadini non comprendevano le grandi ideologie nazionali, ma vivevano la guerra come un destino inevitabile, una carneficina in cui il concetto di patria perdeva significato di fronte alla fame, ai pidocchi e al fango delle trincee.La Brutalità della Guerra e il Trauma
Le testimonianze dirette raccontano la violenza degli assalti, la mancanza di umanità degli ordini impartiti, la paura, la morte e la prigionia. La guerra è sinonimo di rovina e distruzione, sia fisica che psicologica, lasciando traumi profondi anche dopo il ritorno alla vita civile. La ritirata di Caporetto rappresenta il punto più basso, un disastro segnato dal tradimento e dalla confusione. Anche la guerra durante il periodo fascista lasciò un segno doloroso, annientando un’intera generazione di giovani contadini.Spopolamento e Declino Post-bellico
Dopo i conflitti bellici, nelle valli di montagna si diffonde un senso di tristezza e malinconia. I paesi si svuotano, il numero delle nascite diminuisce, le scuole chiudono e l’isolamento aumenta sempre di più. Le comunità si disgregano, i giovani vanno via per lavorare nelle fabbriche di città, lasciando gli anziani soli ad affrontare una montagna che si spopola e viene invasa dalla vegetazione. La montagna appare abbandonata, dimenticata dalle istituzioni e priva di servizi essenziali come strade e scuole. Il turismo, invece di risolvere i problemi, mette in luce la differenza tra la realtà montana e quella urbana, accelerando l’abbandono e la perdita di identità culturale. La montagna si spegne lentamente e silenziosamente, lasciando spazio solo ai ricordi di un passato ormai lontano, di comunità un tempo piene di vita e adesso ridotte a pochi abitanti isolati.Ma è davvero solo la guerra la causa dello spopolamento montano, o non stiamo forse ignorando altri fattori socio-economici cruciali?
Il capitolo sembra concentrarsi eccessivamente sull’impatto della guerra, rischiando di trascurare altre dinamiche complesse che influenzano lo spopolamento montano. Per comprendere appieno questo fenomeno, sarebbe utile esplorare discipline come la sociologia rurale e la storia economica, approfondendo autori che hanno studiato le migrazioni interne, i cambiamenti economici strutturali e le politiche territoriali.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]