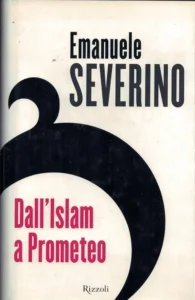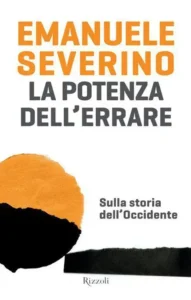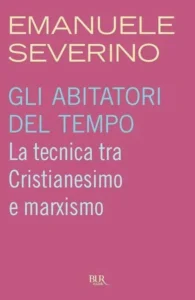1X
🔊 100%
Contenuti del libro
Informazioni
“Il parricidio mancato” di Emanuele Severino è un viaggio intenso alle radici del pensiero occidentale, partendo dalla filosofia greca per capire perché la nostra civiltà funziona come funziona. Severino ci porta a confrontarci con l’idea centrale del divenire, cioè il cambiamento, e come i Greci, specialmente figure come Parmenide ed Empedocle, abbiano lottato con il rapporto tra l’essere, il divenire e il niente. L’autore sostiene che l’Occidente si fonda su una specie di “follia” originaria: la convinzione profonda che le cose possano nascere dal niente e tornarvi, che in fondo le cose “siano niente”. Questo “parricidio mancato” – il tentativo di superare Parmenide senza riuscirci davvero – ha plasmato tutto, dalla nostra visione della violenza e del dominio (pensiamo alla tecnica moderna) fino alla nostra stessa percezione della realtà. Severino ci sfida a vedere questa “evidenza del divenire” come una credenza, non una verità assoluta, e a considerare l’alternativa: l’eternità delle cose al di là del loro apparire e scomparire. È un libro che scava a fondo per mostrare come idee filosofiche antichissime influenzino ancora oggi la nostra vita, la nostra scienza e persino la minaccia dell’annientamento.Riassunto Breve
Il pensiero occidentale si fonda su una visione del divenire che affonda le radici nella filosofia greca. Si distingue un divenire dionisiaco, legato all’abbondanza di vita e al desiderio di distruzione e creazione infinite, che accetta dolore e annientamento come parte dell’eternità della vita, da un divenire romantico, che nasce dalla mancanza e cerca quiete o eternizza una sofferenza finita. La cultura occidentale, pur riconoscendo l’evidenza del cambiamento, non afferra la sua radice filosofica profonda. Questa radice si trova nel pensiero greco, che vede il divenire come un’oscillazione tra essere e niente, fonte di terrore. Contro questo terrore, la filosofia greca crea una difesa, l’apollineo, che cerca forme stabili.La musica, considerata il linguaggio originario, esprime la verità fondamentale della vita: l’esistenza è un divenire costante, pieno di contrasti e sofferenza, ma anche gioia nell’annullamento che garantisce l’eternità. Anche il linguaggio porta i segni di questo contrasto, con suoni legati all’azione umana (flessibile) e suoni legati agli ostacoli e al destino (inflessibile). La civiltà occidentale, sviluppando il senso greco del divenire, dell’essere e del niente, spinge questo processo all’estremo. La sapienza del divenire si manifesta oggi nella scienza e nella tecnica, che mirano a dominare ogni aspetto del mondo, trattando la vita stessa come un’opera tecnica. La musica moderna, sfidando le strutture fisse, riflette questa volontà di liberazione da principi immutabili e il desiderio di dominio sul divenire.Dopo Parmenide, che si concentra sull’Essere immutabile e considera il mondo che appare come “non-essente” e quindi niente, Empedocle guarda ai “testimoni” del mondo, gli elementi e le forze che generano le cose mutevoli. Queste cose mortali, le mescolanze degli elementi, esistono solo per un tempo e prima e dopo la loro forma “sono niente”, anche se gli elementi sono eterni. Questa convinzione che le cose nascono dal niente e vi ritornano diventa una fede centrale per l’Occidente. La “Necessità” in Empedocle descrive il processo di cambiamento ed è il “responso” che il divenire è evidente. Affermare l’esistenza delle cose molteplici e divenienti, che per Parmenide sono niente, significa affermare che il niente “è”. Questo tentativo di superare Parmenide non riesce a liberarsi dall’idea che ciò che non è l’Essere sia niente. L’evidenza del molteplice diventa l’evidenza di un assurdo. Melisso esplicita il “duplice apparire”: il divenire appare, ma la ragione lo nega. Empedocle si concentra sull’evidenza del divenire come testimone inoppugnabile. Questa volontà che l’uscire e il ritornare nel niente appaia è il fondamento della storia occidentale.L’esperienza umana mostra l’incongruenza tra volere e accadere. Il volere è decidere, e decidere significa spezzare i legami delle cose con il tutto eterno, credendo che siano isolate e dominabili. La civiltà occidentale si basa sull’edificazione, una forma di dominio che mira a plasmare la realtà. Questa volontà di dominio si fonda sull’isolamento delle cose, che, viste separate dal tutto, appaiono come niente. Il nichilismo, la persuasione che le cose sono niente, è inseparabile dalla volontà di dominio. L’edificazione è quindi nichilismo. In contrasto, si può pensare che tutte le cose siano eterne e inseparabilmente legate, e il divenire sia il loro mostrarsi. La scienza moderna, nella sua pretesa di dominare, agisce per “decisione”, interpretando il consenso come prova della sua potenza, basandosi sulla separazione e sull’interpretazione della realtà. La volontà di potenza è la decisione che il suo contenuto sia potenza.La violenza e il dialogo non sono opposti, ma espressioni della stessa essenza, radicata nel senso che la ragione ha assunto in Occidente. Il *logos* greco, che raduna il divenire, diventa *episteme* (verità stabile) e poi fede (sapere ipotetico come la scienza). Ogni fede è violenza perché esclude sensi alternativi senza ragione assoluta. La fede dominante è l’amministrazione scientifico-tecnologica. Il dialogo diventa scontro di fedi per ottenere consenso, un momento teorico della violenza. La politica, la morale e la logica dell’azione organizzano le forze che spingono le cose nell’essere e nel niente. La giustificazione della violenza politica è il successo nel dominare. L’aspetto più terrificante della minaccia nucleare, l’annientamento, è già accaduto nel pensiero occidentale con la fede nell’esistenza del divenire inteso come capacità delle cose di essere niente. Questa fede è la “follia estrema” che annienta le cose nel proprio sogno. La storia dell’Occidente è la manifestazione di questa follia. Credere che le cose possano uscire dal niente e tornarvi significa credere che il non-niente sia niente. Questa credenza, considerata l’evidenza suprema, è la follia che dice alle cose: “Voi siete niente”. Le cose, nella loro essenza, sono ingenerabili, incorruttibili, immutabili, eterne; il divenire è il loro comparire e scomparire. L’annientamento avviene nel sogno della follia, senza intaccare l’eternità delle cose. La pace cercata oggi, anche quella che evita la distruzione fisica, è una “pace dei morti”, costruita nel sogno di annientamento. Il superamento della violenza richiede il tramonto di questa follia fondamentale e la scoperta della vera natura eterna delle cose.Riassunto Lungo
1. Il Divenire Infinito e la Difesa Greca
Nietzsche vede due modi di vivere: il dionisiaco e il romantico. Il dionisiaco è tipico dell’antica Grecia e si oppone all’idea cristiana. Nasce quando c’è tanta energia e voglia di vivere. Desidera un cambiamento continuo e senza fine, accogliendo anche la distruzione e il dolore come parte della creazione. Questa visione celebra la vita in modo grato. Il romantico, invece, non è greco e ha radici cristiane. Nasce dalla mancanza di vitalità e cerca una pace che ferma tutto o rende eterna una singola sofferenza. Rappresenta un cambiamento limitato, che finisce nel nulla o si ripete sempre uguale. Il dionisiaco è un divenire che non finisce mai, un eterno ritorno della vita.La paura del divenire e la risposta greca
Nietzsche ribalta l’idea che il divenire infinito sia romantico; per lui è dionisiaco. Il divenire, inteso come un continuo passaggio tra l’esistenza e il nulla, genera un profondo senso di terrore. Questa paura ha radici antiche nel pensiero greco, soprattutto in Platone. Di fronte a questo cambiamento radicale e spaventoso, la filosofia greca ha trovato una potente difesa: l’apollineo. L’apollineo cerca di creare forme stabili e fisse, qualcosa di immutabile, proprio per sfuggire a quel terrore del divenire continuo e incontrollabile.La visione occidentale e la vera rivoluzione
La cultura occidentale accetta l’idea che tutto cambi, ma non capisce fino in fondo la sua origine nel pensiero greco né il legame con ciò che è immutabile. Per esempio, l’idea di lavoro, vista solo come un modo per cambiare le forme delle cose, nasce da questa visione che viene da Platone. Il lavoro viene considerato una condizione naturale, qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà. La vera rivoluzione, secondo questa visione, non è cambiare le forme esteriori, ma mettere in discussione l’idea stessa del divenire così come è stata pensata dai Greci. È sfidare la base su cui poggia la nostra comprensione del cambiamento.Ma è plausibile ridurre la complessità del pensiero greco e la nostra idea di lavoro a una mera reazione di terrore di fronte al divenire?
Il capitolo traccia una linea diretta tra la paura del divenire, la risposta greca (Platone, l’apollineo) e la visione occidentale del cambiamento, inclusa l’idea di lavoro. Questa lettura, pur suggestiva, rischia di semplificare eccessivamente secoli di pensiero e pratiche sociali. Per comprendere meglio queste connessioni, è utile non fermarsi all’interpretazione proposta ma esplorare direttamente le opere di autori come Nietzsche, Platone e Aristotele. Approfondire la storia della filosofia e la sociologia del lavoro può offrire prospettive più ampie sulla genesi delle nostre categorie mentali e sociali, che difficilmente si esauriscono in un’unica causa psicologica o filosofica.2. La Voce del Divenire e i Timbri del Mondo
Il grido segna l’inizio della vita umana ed è al centro delle comunità antiche. Rievocare questo grido, quando le voci si uniscono, dà vita alla musica. Nelle società primitive, la musica è il cuore della festa, un elemento fondamentale per la comunità, molto diverso dalla semplice evasione che rappresenta oggi. La musica è vista come il linguaggio originale, capace di esprimere la verità profonda dell’esistenza. Questa verità, secondo il saggio Sileno, è che la cosa migliore per l’uomo sarebbe non nascere, e la seconda migliore sarebbe morire presto. Questo perché la vita è un flusso continuo, un divenire eterno fatto di contrasti e sofferenze, ma che trova anche gioia nell’annullamento, garantendo così l’eternità della vita stessa. La musica riflette fedelmente questo incessante divenire.I Timbri del Linguaggio
Anche il linguaggio umano porta in sé i segni di questo contrasto fondamentale che caratterizza la vita. Nella storia più antica delle lingue occidentali, si possono distinguere due tipi di suoni, o timbri, che esprimono aspetti diversi della realtà. Ci sono le consonanti liquide, come ‘r’ e ‘l’, che sono legate all’azione dell’uomo, alla sua arte e alla capacità di modificare il mondo, rappresentando l’aspetto flessibile dell’esistenza. Accanto a queste, si trovano le consonanti occlusive o spiranti, come ‘p’, ‘t’, e ‘s’, che richiamano gli ostacoli, il destino e l’aspetto immutabile del mondo, ciò che è inflessibile. Questi due gruppi di suoni sono come parole primordiali che esprimono la tensione tra ciò che l’uomo può plasmare e ciò che, invece, gli sfugge e non può essere piegato.La Civiltà della Tecnica
La civiltà occidentale si è sviluppata partendo dall’approfondimento greco dei concetti di divenire, essere e niente. Questo percorso ha portato all’estremo la tendenza a comprendere e dominare la realtà. La sapienza legata al divenire, che un tempo trovava espressione nella musica, si manifesta oggi nella scienza e nella tecnica. Queste discipline rappresentano la volontà umana di controllare e manipolare ogni aspetto del mondo. Anche ciò che una volta era considerato immutabile o inflessibile è ora visto come potenziale oggetto di dominio tecnico. La vita stessa, in questa prospettiva, viene sempre più considerata e trattata come un’opera di ingegneria o un processo tecnico.La Musica Moderna
La musica dei tempi moderni, come la dodecafonia, mette in discussione le strutture musicali fisse e tradizionali, rifiutando le regole armoniche consolidate. Questo approccio riflette un profondo rifiuto dei principi immutabili che hanno governato la musica per secoli, cercando nuove vie espressive. Tale sfida alle forme predefinite si lega a un desiderio più ampio presente nella cultura contemporanea: quello di liberarsi da ogni struttura o regola imposta dall’esterno. È un impulso che si manifesta in diversi ambiti e che trova una sua potente espressione nell’arte sonora. In questo senso, la civiltà dominata dalla tecnica, con la sua spinta al controllo e alla manipolazione, incarna pienamente questa volontà di esercitare un dominio totale anche sul divenire dell’esistenza, riflettendosi nelle forme d’arte che sfidano ogni limite.Qual è la base linguistica o scientifica per affermare che specifici suoni consonantici incarnino concetti astratti come l’azione umana o il destino?
Il capitolo, nel delineare un legame tra specifici ‘timbri’ consonantici e concetti astratti come l’azione umana o il destino, presenta un’affermazione suggestiva ma priva di un chiaro fondamento esplicitato nel testo. Questa associazione tra fonetica e metafisica necessita di un’analisi più rigorosa per valutarne la validità al di là dell’interpretazione simbolica. Per approfondire la questione e cercare basi più solide per tali legami, sarebbe opportuno esplorare studi nel campo della linguistica, in particolare la fonosemantica o il simbolismo fonetico, e autori che si sono occupati del rapporto tra suono e significato nelle lingue naturali da una prospettiva empirica o teorica non esclusivamente filosofica.3. L’evidenza del divenire e il niente delle cose mortali
Invece di concentrarsi sull’Essere unico e immobile come faceva Parmenide, Empedocle ci invita a osservare il mondo che ci circonda. Ci chiede di guardare i “testimoni”: gli elementi fondamentali e le forze che li uniscono e li separano. Sono questi elementi e queste forze a creare tutte le cose diverse e mutevoli che vediamo. Questo mondo visibile, ciò che Empedocle chiama il “manifesto”, è proprio quello che Parmenide non ha considerato, come se fosse abbagliato dalla luce del suo Essere unico.Le Cose che Nascono e Muoiono
Le cose che vediamo intorno a noi, quelle che sono destinate a morire, esistono solo per un certo periodo di tempo. Sono fatte dalla mescolanza degli elementi. Ma prima di prendere forma e dopo essersi disciolte, queste cose “sono niente”. Questo accade anche se gli elementi di base che le compongono sono eterni e non si distruggono mai. L’idea che le cose nascano dal niente e vi ritornino, anche se Empedocle la nega per le mescolanze complete, emerge come una verità profonda nel suo pensiero. Questa convinzione, che ciò che non è eterno sia di fatto “niente”, è diventata una fede centrale per la civiltà occidentale nel corso della storia.La Forza del Cambiamento: La Necessità
Per Parmenide, la “Necessità” indicava l’immutabilità dell’Essere, il fatto che non potesse cambiare. In Empedocle, invece, la “Necessità” descrive il processo stesso del cambiamento nel mondo. È la forza che regola la divisione e la riunificazione degli elementi, creando e distruggendo le cose. Il “responso” di questa Necessità è chiaro: il divenire, il cambiamento, esiste ed è evidente a tutti. La Necessità implica quindi due cose: l’obbligo di riconoscere che il cambiamento avviene, perché lo vediamo, e l’eternità di questo processo di cambiamento stesso.La Sfida Filosofica: L’Esistenza del Niente?
Affermare che le cose diverse e che cambiano esistono significa andare contro Parmenide. Lui diceva che tutto ciò che non è l’Essere unico e immutabile è “non-essente”, cioè niente. Quindi, affermare l’esistenza delle cose che cambiano sembra voler dire che il niente “è”. Questo tentativo di superare l’idea di Parmenide che il cambiamento non esiste è come un “parricidio” filosofico. Ma è un parricidio che non riesce del tutto, perché non si libera dall’idea di base che ciò che non è l’Essere eterno sia semplicemente niente. Così, l’evidenza che il mondo cambia e contiene molte cose diverse diventa l’evidenza di qualcosa che, dal punto di vista di Parmenide, è assurdo.L’Importanza del Mondo che Vediamo
Anche se Parmenide negava che il mondo che appare ai nostri sensi (la “doxa”) fosse la vera realtà, riconosceva comunque che questo mondo ci appare. Un suo seguace, Melisso, ha reso più chiara questa idea del “doppio apparire”: il cambiamento ci appare, lo vediamo, ma il ragionamento logico (il “logos”) ci dice che non è la vera realtà. Empedocle, invece, si concentra sulla forza di questo primo apparire, sull’evidenza che le cose cambiano e nascono e muoiono. Per lui, questa evidenza diventa il testimone più forte, il responso definitivo della Necessità. Questa scelta di dare valore all’evidenza che le cose escono dal niente e vi ritornano è il fondamento su cui si è costruita gran parte della storia del pensiero occidentale.Se la civiltà occidentale si basa sul ‘dominio’ e questo dominio nasce dal vedere le cose come ‘niente’, come può il capitolo affermare che ogni sua espressione – dalla filosofia alla scienza – sia, in fondo, nichilismo?
Il capitolo propone una visione molto specifica e radicale della civiltà occidentale, legando indissolubilmente il suo agire al nichilismo attraverso l’idea di “separazione”. Questa generalizzazione rischia di ignorare la ricchezza e le contraddizioni interne del pensiero occidentale. Per comprendere meglio questa tesi e le sue possibili critiche, è utile approfondire la storia della filosofia, esaminando le diverse correnti che hanno affrontato i temi della volontà, del potere, della relazione tra l’uomo e il mondo, e del significato. Lo studio di autori come Nietzsche, per una comprensione più ampia della “volontà di potenza”, o di pensatori che hanno criticato la metafisica tradizionale o proposto visioni alternative della civiltà, può offrire strumenti per valutare la validità di un’equazione così diretta tra agire occidentale e nichilismo.5. La Follia Originaria e la Violenza del Pensiero Occidentale
La violenza e il dialogo non sono forze opposte nei rapporti umani, ma piuttosto manifestazioni diverse della stessa radice profonda. Questa radice si trova nel significato che la ragione ha assunto nella storia della civiltà occidentale. Tutto inizia con il pensiero greco, che ha visto il logos come ciò che raccoglie e ordina il continuo cambiamento delle cose. Più avanti, il logos filosofico, inteso come episteme (una verità assoluta e definitiva), ha cercato di imporre un ordine fisso su questo cambiamento costante.Il pensiero greco, però, ha anche aperto la strada a un’idea particolare: che le cose possano passare dall’essere al non essere e viceversa, quasi come se avessero una “tendenza al niente”. Nell’Occidente, si è radicata una convinzione profonda, spesso non detta, che le cose, pur esistendo, siano in realtà niente. Questo modo di pensare è la violenza più estrema che si possa fare alle cose stesse, perché nega la loro vera natura. Questa convinzione nascosta è la fonte segreta della storia occidentale e della sua inclinazione alla violenza.Dal Sapere alla Fede: La Violenza Nascosta
Quando l’episteme, intesa come verità assoluta, ha perso la sua forza, il logos si è trasformato in fede. Questa fede è un sapere che si ritiene vero ma che è solo ipotetico e temporaneo, come accade nella scienza moderna. Ogni forma di fede porta con sé una violenza intrinseca, perché esclude altri modi di vedere il mondo senza avere una ragione definitiva per farlo. Oggi, la fede più forte è quella nell’organizzazione scientifica e tecnologica della vita. Questa fede ottiene l’approvazione di molti e mette in secondo piano tutte le altre credenze.In questo scenario, il dialogo non si basa più sul rispetto reciproco visto come una verità immutabile (un’idea che svanisce insieme all’episteme). Il dialogo diventa invece uno scontro tra diverse fedi, ognuna delle quali cerca di prevalere sull’altra per ottenere maggiore consenso. È come se il dialogo fosse una fase “teorica” della stessa violenza che si manifesta in altri modi.La Follia e l’Annientamento
La politica, la morale e il modo in cui organizziamo le nostre azioni (che culmina nella scienza e nella tecnica) sono tutti ambiti in cui si manifestano le forze che spingono le cose verso l’esistenza o verso il niente. La violenza nella politica, ad esempio, non viene più giustificata da una legittimità basata su una verità assoluta (episteme), ma dal successo nel dominare e ottenere l’approvazione generale.L’aspetto più spaventoso della minaccia nucleare, cioè la possibilità di annientare tutto, è qualcosa che è già accaduto nel pensiero occidentale più di duemila anni fa. È successo con la convinzione che il cambiamento delle cose significasse che esse potevano diventare niente. Questa credenza è la “follia più grande”, quella che annienta le cose nella propria immaginazione. La storia dell’Occidente non è altro che la manifestazione concreta di questa follia.La Vera Natura delle Cose e la Pace Autentica
Credere che le cose possano apparire dal niente e scomparire di nuovo nel niente significa credere che ciò che non è niente sia in realtà niente. Questa idea, che la nostra civiltà considera una verità ovvia, è la follia che sussurra alle cose: “Voi siete niente”. Ma le cose, nella loro essenza più profonda, non sono così. Sono ingenerabili, non possono essere distrutte, non cambiano nella loro natura fondamentale e sono eterne. Il loro “divenire” è solo il loro modo di apparire e poi ritirarsi dalla nostra vista.L’annientamento delle cose, quindi, avviene solo all’interno del sogno creato da questa follia. Non tocca minimamente la loro eternità. La storia degli uomini e degli dèi è il sogno di questa follia. La pace che cerchiamo oggi, anche quella che vuole evitare la distruzione fisica, è una “pace dei morti”, una pace costruita rimanendo prigionieri del sogno di annientamento. Per superare davvero la violenza, è necessario che questa follia fondamentale tramonti. Solo così potremo scoprire la vera natura eterna e immutabile delle cose.Ma davvero la complessa storia della violenza occidentale si riduce a una singola “follia” metafisica sull’essere e il nulla?
Il capitolo propone una tesi affascinante ma estremamente riduttiva, che lega ogni forma di violenza occidentale a un’unica, nascosta convinzione filosofica sulla natura delle cose. Questa tesi, per quanto suggestiva, trascura la miriade di fattori storici, sociali, economici e politici che hanno plasmato i conflitti e le manifestazioni di violenza nel corso dei secoli. Per comprendere appieno la complessità del fenomeno, è necessario integrare questa prospettiva filosofica con studi più ampi. Si consiglia di approfondire la storia della filosofia occidentale, in particolare il pensiero presocratico (come Parmenide ed Eraclito) e le successive riflessioni sull’ontologia e la metafisica, ma anche di confrontarsi con la storiografia che analizza le cause concrete dei conflitti e delle trasformazioni sociali. Autori come Tucidide o Machiavelli, pur distanti nel tempo, offrono spunti fondamentali sulla natura del potere e del conflitto che vanno oltre la sola dimensione metafisica.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]