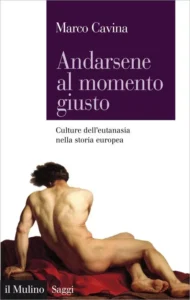Contenuti del libro
Informazioni
“Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi” di Marco Cavina è un libro che ti porta in un viaggio incredibile attraverso la storia per capire come è cambiato il ruolo del padre. Non è sempre stato quello che pensiamo! Si parte dall’antichità, tipo l’antica Roma con la sua patria potestas quasi illimitata, e si vede come l’idea di famiglia patriarcale si è sviluppata tra ebrei, greci e poi nel Medioevo, dove il padre era un po’ il re della casa. Il libro esplora come la legge, la religione (pensiamo al cristianesimo) e poi lo Stato hanno messo paletti a questo potere, soprattutto sul controllo dei matrimoni o sull’educazione dei figli. Si analizza l’influenza di codici importanti come il Codice Napoleonico che hanno iniziato a smontare l’autorità paterna tradizionale. Il percorso arriva fino al Novecento, chiamato il “secolo del bambino”, dove lo Stato prende sempre più spazio nella vita familiare, e l’idea di patria potestà si trasforma in responsabilità genitoriale, mettendo al centro i diritti del minore. È una storia affascinante che attraversa civiltà e sistemi legali, mostrando come il potere del padre sia passato da quasi assoluto a una forma di tutela limitata.Riassunto Breve
La figura del padre e il suo potere sulla famiglia hanno subito grandi trasformazioni nel corso della storia. In origine, nelle società preistoriche, prevalevano strutture diverse, spesso basate sul matriarcato, e solo lentamente si afferma il ruolo paterno nella procreazione e la famiglia patrilineare nel Neolitico. Nelle civiltà antiche, come quelle mesopotamiche e l’ebraica, il padre detiene un’autorità forte, con leggi severe per i figli disubbidienti; nella tradizione ebraica il potere è quasi assoluto, poi limitato, con un forte dovere di onorare i genitori. Nel mondo greco, modelli come quello spartano vedono i figli come proprietà dello Stato, mentre ad Atene la casa resta patriarcale con il padre come capo. Il potere paterno romano, la patria potestas, è il più esteso, conferendo al padre autorità quasi illimitata sui figli per tutta la vita, inclusi diritti sulla persona e sui beni, sebbene nella pratica fosse mitigato da fattori sociali e leggi imperiali che riconoscono una certa autonomia patrimoniale ai figli (peculium); la giustizia domestica romana, pur basata sull’autorità paterna, spesso coinvolgeva un consiglio familiare. Il cristianesimo introduce una nuova prospettiva, ponendo l’accento sul Padre celeste e sulla comunità dei credenti, a volte creando tensione con i legami familiari terreni, e mostrando maggiore attenzione verso i bambini e i doveri reciproci. Le popolazioni germaniche presentano un modello di autorità paterna più limitato, spesso terminante con la maggiore età o l’idoneità militare. Nel Medioevo, l’autorità paterna è centrale, derivata dal diritto romano e dalla filosofia dell’oeconomica, con il padre visto come un re nella sua casa, responsabile dell’educazione dei figli, trasmettendo beni materiali e simbolici; esiste un dibattito sull’uso della severità o della moderazione nella correzione. La patria potestà conferisce al padre ampi poteri sui beni e sulla persona dei figli, con limiti posti dalla legge e dalla morale per evitare castighi crudeli o la vendita. Un punto cruciale è il controllo paterno sui matrimoni dei figli, con il diritto secolare che sanziona le unioni senza consenso per preservare l’ordine sociale e patrimoniale, mentre la Chiesa afferma la validità del matrimonio basato sul consenso degli sposi, anche senza approvazione paterna, portando a pratiche come gli “atti rispettosi”. L’emancipazione rappresenta la via d’uscita dalla patria potestà, potendo avvenire formalmente, tacitamente o coattivamente in caso di abusi. L’autorità paterna costituisce un fondamento della struttura familiare e sociale per secoli, manifestandosi nel controllo sui matrimoni e potendo imporre sanzioni patrimoniali come la diseredazione, sebbene il matrimonio celebrato sia valido. La figura del servo domestico, pur parte della famiglia, è distinta, vista come strumento del padrone con potere asimmetrico e unidirezionale, sebbene la mercede diventi essenziale per i servi liberi. Filosofi e giuristi dibattono i limiti del potere paterno, con alcuni che vedono la famiglia come modello per lo Stato e altri che cercano di limitare il potere in nome dei diritti individuali o dell’intervento statale, specialmente nell’educazione; lo Stato può intervenire per sostenere o supplire l’autorità paterna, considerandola una “autorità incatenata” a quella sovrana. La patria potestà si sposta da un potere privato quasi assoluto a una funzione più regolata e coordinata con l’autorità pubblica. Il Codice Napoleonico, nel regolare la patria potestà, si discosta dal diritto romano adottando principi consuetudinari di origine germanica, indebolendo le antiche famiglie e creando nuove strutture sociali, limitando la libertà testamentaria e parificando uomini e donne nell’eredità. Tuttavia, in contesti diversi, si propone di rafforzare la patria potestà per ricostruire i legami sociali e il rispetto per il sovrano. Il giusnaturalismo ha contestato la patria potestà tradizionale, proponendo un potere basato sull’educazione e limitato alla minore età. La Rivoluzione Francese ha cercato di abolire il dispotismo paterno, stabilendo la maggiore età come termine della potestà e considerando i figli membri della società. Il Codice Napoleonico rappresenta un compromesso, ripristinando parzialmente l’autorità paterna ma mantenendo alcuni principi rivoluzionari. Negli Stati italiani preunitari, si tende a preferire un modello più tradizionale e patriarcale. La concezione della patria potestà si trasforma radicalmente, passando da un potere quasi assoluto e perpetuo a un’autorità più limitata e temporanea, distinguendo tra una potestà “naturale” basata sul bisogno di educazione e una potestà “civile” che riflette le strutture statali. Con l’avvento di idee liberali e democratiche, l’autorità paterna viene ridimensionata, con tentativi di limitare il potere di correzione e controllo sui matrimoni. La magistratura inizia a esercitare un ruolo moderatore, limitando l’arbitrio paterno e tutelando gli interessi dei figli. Il potere di diseredare si indebolisce progressivamente, e la libertà matrimoniale dei figli guadagna terreno. Nel Novecento, l’autorità sui figli minori passa gradualmente dai genitori allo Stato, giustificato dall’interesse superiore del bambino; il ventesimo secolo viene definito il “secolo del bambino”, con un’enfasi sui diritti dell’infanzia. Questo puerocentrismo diventa un principio guida per l’intervento statale nella vita familiare, orientando i figli verso l’ideale di cittadino desiderato dal regime politico dominante. Regimi come il fascismo e il nazismo, pur esaltando la famiglia patriarcale, la sottomettano agli obiettivi dello Stato. In Italia, il codice civile del 1942 introduce l’obbligo di educare i figli secondo la morale e il sentimento nazionale fascista. Dopo la seconda guerra mondiale, si assiste a un’omogeneizzazione delle dinamiche familiari in Europa, con il puerocentrismo e l’uguaglianza tra i genitori che diventano centrali; la figura del capo famiglia scompare, aumenta l’intervento giudiziale nell’interesse del minore, e il potere correzionale viene meno. La riforma del diritto di famiglia in Italia nel 1975 sostituisce la “patria potestà” con la “potestà dei genitori”, esercitata di comune accordo, eliminando il dovere di onorare i genitori e concentrandosi sull’interesse e le aspirazioni del figlio. L’evoluzione porta al concetto di “responsabilità genitoriale”, dove i genitori hanno doveri verso il figlio, non diritti su di esso; lo Stato agisce come garante dei diritti del minore, potendo intervenire in caso di negligenza o abuso. Questa trasformazione riflette il passaggio da un modello familiare basato sull’autorità paterna a uno incentrato sui diritti individuali del bambino e sul ruolo di controllo e supplenza dello Stato.Riassunto Lungo
1. Le radici del potere paterno: da Roma alla fede
La figura del padre come capo della famiglia, così come la conosciamo, non è sempre esistita. Nelle società più antiche, prima della storia scritta, spesso le strutture sociali si basavano sulla figura della madre (matriarcato). La comprensione del ruolo del padre nella nascita dei figli si è sviluppata lentamente nel tempo. È solo nel Neolitico, con i cambiamenti legati all’agricoltura, che si afferma un nuovo modello di famiglia, dove l’autorità principale passa al padre (famiglia patrilineare). Questo cambiamento segna l’inizio di un lungo percorso che porterà all’idea del padre come figura centrale e potente.L’Autorità Paterna nelle Civiltà Antiche
Nelle antiche civiltà del Medio Oriente, come quelle fiorite in Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi), il padre aveva già un potere notevole sui suoi figli. Le leggi di quei tempi mostrano quanto fosse importante rispettare i genitori, prevedendo pene severe per i figli che non lo facevano. La tradizione ebraica, in particolare, ha dato vita a una famiglia dove il padre era la figura dominante. All’inizio, il suo potere era quasi assoluto, potendo decidere persino della vita o della morte dei figli, anche se questa facoltà venne poi limitata nel tempo. Uno dei comandamenti fondamentali era proprio quello di onorare il padre e la madre, sottolineando l’importanza del loro ruolo. L’educazione dei figli era considerata un dovere essenziale del padre, e questo poteva includere anche correzioni fisiche per garantire disciplina e rispetto.Il Modello Greco
Nel mondo greco, le idee sull’autorità paterna variavano a seconda della città-stato. A Sparta, per esempio, i figli erano visti quasi come proprietà dello Stato (la polis), che ne controllava l’educazione e la vita fin da piccoli. Questo significava che l’autorità statale prevaleva spesso su quella del padre. Ad Atene, invece, i figli avevano una certa libertà di gestire i propri beni (patrimonio), ma la casa (chiamata oikos) rimaneva un luogo dove il padre esercitava il suo potere. Il filosofo Aristotele descrisse questo potere paterno paragonandolo a quello di un re sui suoi sudditi, evidenziando la sua importanza all’interno della famiglia.La Potenza della Patria Potestas Romana
Il potere del padre romano, noto come patria potestas, è forse il più famoso e studiato. Questo potere era eccezionalmente vasto e durava per tutta la vita del figlio, indipendentemente dalla sua età o posizione sociale. Teoricamente, il padre aveva diritti quasi illimitati sia sulla persona dei figli che sui loro beni. Questo includeva, in teoria, il diritto di vita e di morte, la possibilità di vendere i figli come schiavi o di abbandonarli (esposizione). Era un’autorità che non aveva eguali in altre civiltà contemporanee.Tuttavia, nella vita di tutti i giorni, questo potere teoricamente assoluto era spesso mitigato da diversi fattori. Le usanze sociali, le condizioni di vita e la demografia (la durata media della vita) rendevano difficile esercitare un controllo così ferreo per decenni. Inoltre, con il passare del tempo, specialmente durante l’epoca dell’Impero, le leggi intervennero per limitare gli aspetti più duri della patria potestas. Si iniziò a riconoscere ai figli una crescente autonomia nella gestione di alcuni beni (il peculium). Anche se la giustizia all’interno della famiglia restava nelle mani del padre, spesso le decisioni importanti venivano prese consultando un consiglio composto dai parenti più stretti. L’esclusione definitiva di un figlio dalla famiglia (chiamata abdicatio) era vista come una punizione molto severa.
L’Influenza del Cristianesimo
L’arrivo del cristianesimo portò una nuova visione sui legami familiari e sull’autorità paterna. Anche se riconosceva l’importanza della famiglia e il ruolo del padre, come si legge nelle lettere di San Paolo, introdusse un elemento nuovo. Il messaggio evangelico metteva al centro la figura del Padre celeste e l’idea di una comunità di credenti che trascendeva i legami di sangue. Questo poteva creare, e spesso creò, una certa tensione tra l’obbedienza al padre terreno e la chiamata a seguire una vocazione religiosa o spirituale. Il cristianesimo portò anche una maggiore attenzione verso i bambini e sottolineò i doveri reciproci che legavano tutti i membri della famiglia, non solo l’obbedienza dei figli al padre.Il Potere Paterno tra i Popoli Germanici
I popoli germanici, che si stabilirono in Europa dopo la caduta dell’Impero Romano, avevano un modello di autorità paterna diverso da quello romano. Il potere del padre (spesso chiamato mundium) era generalmente più limitato e non durava per tutta la vita del figlio. Terminava di solito quando il figlio maschio raggiungeva la maggiore età o diventava idoneo a combattere nell’esercito. Il mundium era più un potere di protezione e tutela, piuttosto che un controllo assoluto sulla persona e sui beni. C’erano comunque variazioni tra le diverse tribù germaniche; per esempio, tra i Longobardi, il mundium aveva caratteristiche più legate alla gestione dei beni familiari.Il Medioevo: Conflitti e Nuove Prospettive
Nel Medioevo, il rapporto tra l’autorità del padre e le scelte individuali dei figli divenne un tema centrale, spesso raccontato nelle storie e nelle vite dei santi. Molti giovani, spinti da una forte fede, sceglievano di dedicarsi alla vita religiosa, entrando in monastero o diventando chierici. Questa scelta significava spesso andare contro la volontà del padre, che magari aveva altri progetti per loro, come un matrimonio combinato o la gestione dei beni di famiglia. Queste storie simboleggiano il conflitto più ampio tra le esigenze del mondo terreno (la famiglia, la proprietà, il lignaggio) e quelle del mondo spirituale (la vocazione, la salvezza dell’anima). Mostrano come, anche in un’epoca in cui l’autorità paterna rimaneva forte, emergevano forze (come la fede religiosa) capaci di mettere in discussione il suo potere assoluto e di aprire nuove strade per l’individuo.Ma siamo davvero sicuri che la figura del padre ‘come la conosciamo’ sia nata nel Neolitico, dopo un’era di matriarcato?
Il capitolo introduce una visione lineare delle origini della famiglia che merita un approfondimento critico. La transizione da presunte strutture “matriarcali” a quelle “patriarcali” nel Neolitico è un modello interpretativo che è stato oggetto di ampio dibattito e non gode di consenso unanime tra gli studiosi. Le prove archeologiche e antropologiche relative alle società pre-storiche sono spesso frammentarie e aperte a diverse interpretazioni. Per comprendere meglio la complessità di questo argomento e le diverse teorie sulle origini delle strutture familiari e di potere, è utile esplorare i lavori di antropologi e archeologi che si sono occupati di società pre-agricole e della transizione neolitica, come ad esempio Marija Gimbutas (spesso associata alle teorie sul matriarcato pre-indoeuropeo, sebbene controverse) o autori che hanno criticato tali modelli evoluzionistici unilineari. Approfondire gli studi sulla parentela e l’organizzazione sociale nelle diverse culture può fornire una prospettiva più sfumata rispetto a un’unica linea evolutiva.2. La Potestà del Padre e i Confini della Casa
La figura del padre nel basso Medioevo e nell’età moderna aveva un’autorità fondamentale sulla famiglia. Questa autorità derivava dal diritto romano e dalle idee di Aristotele sulla gestione della casa, chiamata oeconomica. Questa scienza si occupava specificamente di come governare l’ambiente domestico, distinguendosi dall’etica personale e dalla politica della città. Il padre era visto quasi come un re nella sua casa, con potere sui figli, sulla moglie e sui servi, anche se questo potere era considerato meno completo rispetto a quello di un sovrano sulla città. Un compito essenziale del padre era l’educazione dei figli, un modo per trasmettere non solo beni ma anche un patrimonio di valori.Educazione, Poteri e Limiti
Riguardo all’educazione, si discuteva se fosse meglio usare severità o moderazione nella correzione dei figli. Alcuni pensavano che l’uso di punizioni fisiche fosse necessario per evitare comportamenti sbagliati, mentre altri, come Erasmo e Montaigne, promuovevano un approccio basato sull’affetto e il rispetto. L’autorità paterna dava al padre ampi poteri sui beni dei figli e sulla loro persona, compresa la possibilità di dare punizioni moderate. Tuttavia, questo potere non era illimitato; la legge e la morale stabilivano dei confini, vietando castighi crudeli o la vendita dei figli, tranne in casi di estrema necessità. La madre aveva un ruolo nell’educazione dei figli più piccoli, ma l’autorità principale spettava sempre al padre.Matrimonio ed Emancipazione
Un punto importante di scontro era il controllo del padre sui matrimoni dei figli. Le leggi civili tendevano a punire i matrimoni fatti senza il consenso paterno o quelli tra persone di classi sociali diverse, per mantenere l’ordine e il patrimonio della famiglia. La Chiesa cattolica, specialmente dopo il Concilio di Trento, affermò invece che il matrimonio era valido se basato sul consenso degli sposi, anche senza l’approvazione del padre, pur considerandolo un atto disonesto. Questa differenza portò alla nascita di pratiche come gli “atti rispettosi”, che chiedevano ai figli di informare i genitori delle loro intenzioni di matrimonio come segno di rispetto. Uscire dall’autorità paterna era possibile tramite l’emancipazione, che poteva avvenire formalmente davanti a un giudice, in modo tacito (ad esempio, vivendo separati e gestendo i propri beni), o forzatamente in caso di gravi abusi da parte del padre. Nonostante l’emancipazione, rimanevano alcuni doveri verso i genitori, e l’ingratitudine poteva portare a ritrovarsi di nuovo sotto la loro autorità.Ma se la Chiesa poteva validare matrimoni senza il consenso paterno, quanto era davvero ‘re’ il padre nella sua casa?
Il capitolo identifica correttamente il conflitto tra legge civile e legge canonica sul consenso matrimoniale come un punto di scontro importante. Tuttavia, non esplora a sufficienza le conseguenze pratiche di tale dicotomia. Comprendere come questa tensione legale influenzasse concretamente le dinamiche familiari, le scelte matrimoniali dei figli e l’applicazione dell’autorità paterna è cruciale per valutare la reale portata del potere descritto. Per approfondire, è utile studiare la storia del diritto, in particolare il diritto canonico, e la storia sociale della famiglia nell’età moderna.3. Il Padre, la Casa e lo Stato: Poteri e Limiti nell’Antico Regime e Oltre
Il potere del padre è stato per secoli un pilastro fondamentale nella struttura della famiglia e della società. Il padre aveva un’autorità molto ampia sui figli, sulla moglie e anche sui servi che vivevano in casa. Questa autorità si vedeva chiaramente nel controllo che esercitava sui matrimoni dei figli. Era necessario il suo consenso per le pubblicazioni e poteva punire chi non rispettava la sua volontà, ad esempio escludendolo dall’eredità. Anche se il matrimonio celebrato senza consenso era considerato valido, le conseguenze patrimoniali potevano essere severe. La povertà della persona scelta non era sempre un motivo valido per il padre per opporsi, a meno che non ci fosse anche una differenza di posizione sociale troppo grande.La Figura del Servo Domestico
La posizione del servo domestico era diversa da quella dei figli, pur essendo parte della famiglia. Il servo era spesso visto come uno strumento al servizio del padrone, quasi come se la sua identità individuale si annullasse nell’unità della casa. Il potere del padrone sul servo era sbilanciato e andava in un’unica direzione. Era permesso punire i servi anche fisicamente, ma con moderazione. Un elemento importante per i servi liberi era il pagamento di un salario. Tuttavia, ricevere regolarmente la paga non era sempre scontato, il che poteva creare tensioni e a volte portare i servi a rubare.Il Dibattito sul Potere Paterno e il Ruolo dello Stato
Molti pensatori e uomini di legge hanno discusso a lungo sulla natura e sui limiti del potere paterno. Alcuni, legati alle idee più tradizionali, vedevano la famiglia come un modello per lo Stato, dove il padre rappresentava l’autorità e le tradizioni da rispettare. Altri, pur riconoscendo l’importanza della famiglia, cercavano di limitare questo potere. Lo facevano per proteggere i diritti dei figli come individui o per dare spazio all’intervento dello Stato, specialmente per quanto riguarda l’educazione. Lo Stato, soprattutto in certi periodi come la Restaurazione, interveniva per supportare o, se necessario, sostituire l’autorità del padre. Vedeva il potere paterno come un’autorità “legata” a quella del sovrano, utile per mantenere l’ordine sociale. Così, la patria potestà si è trasformata nel tempo: da un potere quasi assoluto e privato è diventata una funzione più regolata e coordinata con l’autorità pubblica.Davvero la fine del potere paterno assoluto è solo merito di leggi e ‘nuove idee’, o c’è una storia economica e sociale che il capitolo dimentica?
Il capitolo illustra efficacemente il mutamento della patria potestà attraverso le trasformazioni giuridiche e ideologiche, ma la sua narrazione sembra concentrarsi prevalentemente sugli aspetti normativi e filosofici. Per comprendere appieno un cambiamento così radicale nella struttura familiare, sarebbe fondamentale esplorare anche le profonde trasformazioni socio-economiche che hanno accompagnato e forse persino guidato queste evoluzioni legali. Discipline come la storia sociale, la storia economica e la sociologia della famiglia offrono strumenti e prospettive essenziali per analizzare come l’industrializzazione, l’urbanizzazione, il mutare dei ruoli economici all’interno del nucleo familiare e la progressiva perdita di centralità della terra come base del potere paterno abbiano contribuito a ridefinire i rapporti di forza e l’idea stessa di famiglia, andando oltre la mera applicazione di nuove leggi o la diffusione di nuove idee. Approfondire autori che si sono occupati di storia della famiglia e di storia sociale potrebbe fornire il contesto mancante.6. Il Secolo del Bambino sotto l’Ala dello Stato
Nel Novecento, l’idea tradizionale di patria potestà, che dava grande potere al padre all’interno della famiglia, cambia profondamente. L’autorità sui figli più piccoli passa gradualmente dai genitori, soprattutto dal padre, allo Stato. Questo cambiamento avviene perché gli organi statali intervengono sempre di più nella vita delle famiglie, dicendo di agire per il bene superiore del bambino.Il Novecento: il secolo del bambino
Il ventesimo secolo viene chiamato il “secolo del bambino”. Questo perché si inizia a dare molta importanza ai diritti dei bambini, sia in Italia che negli altri paesi. Questa centralità del bambino diventa una guida per lo Stato, che la usa per intervenire nell’educazione e nella crescita dei figli. Lo scopo è orientarli a diventare il tipo di cittadino che il governo del momento desidera, che sia un governo democratico, totalitario o comunista.Lo Stato e la famiglia nei regimi del Novecento
Alcuni governi, come il fascismo in Italia e il nazismo in Germania, dicevano a parole di voler rafforzare la famiglia tradizionale con il padre al comando, ma in realtà toglievano autonomia alle famiglie per sottometterle agli obiettivi dello Stato. In Italia, le leggi del 1942 stabiliscono che i figli devono essere educati secondo i valori fascisti e che i genitori possono perdere l’autorità se non lo fanno. In Unione Sovietica, dopo la rivoluzione, si pensa all’inizio di superare la famiglia come la si conosceva, ma poi si capisce che la famiglia può essere utile per formare i buoni cittadini. Quindi, lo Stato controlla molto i genitori, quasi come se fossero impiegati statali incaricati di educare i figli.Il dopoguerra e la famiglia moderna
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le famiglie in Europa diventano più simili tra loro. L’idea che il bambino sia al centro e che i genitori siano uguali diventa fondamentale. La figura del capo famiglia sparisce, i giudici intervengono più spesso per proteggere l’interesse dei bambini, e il potere di “correggere” i figli con la forza diminuisce. In Italia, nel 1975, una nuova legge sulla famiglia cambia la “patria potestà” in “potestà dei genitori”. Questa autorità viene esercitata da entrambi i genitori insieme, si elimina il dovere dei figli di “onorare” i genitori e ci si concentra sull’interesse e sui desideri del figlio.Dalla potestà alla responsabilità
Questo percorso porta al concetto di “responsabilità genitoriale”. Con questo concetto, i genitori hanno dei doveri verso i figli, non dei diritti “su” di loro. Lo Stato ha il compito di garantire che i diritti dei bambini siano rispettati e può intervenire se i genitori trascurano i figli o li maltrattano. Questo cambiamento mostra bene il passaggio da un modello di famiglia dove contava l’autorità del padre a uno dove sono importanti i diritti del singolo bambino e dove lo Stato ha un ruolo di controllo e di aiuto quando serve.Se lo Stato interviene per creare il “cittadino desiderato”, agisce davvero per il “bene superiore” del bambino?
Il capitolo, pur riconoscendo che lo Stato interviene dicendo di agire per il bene superiore del bambino, ammette anche che lo scopo è orientarlo a diventare il tipo di cittadino che il governo desidera. Questa tensione tra l’interesse individuale del bambino e l’interesse collettivo dello Stato merita un’analisi più approfondita. Per comprendere meglio le implicazioni di questo ruolo statale, si possono esplorare le teorie sulla relazione tra famiglia e potere politico, leggendo autori come Michel Foucault, o approfondire il dibattito filosofico sui diritti individuali e l’autorità statale, studiando pensatori come John Locke.Abbiamo riassunto il possibile
Se vuoi saperne di più, devi leggere il libro originale
Compra il libro[sc name=”1″][/sc] [sc name=”2″][/sc] [sc name=”3″][/sc] [sc name=”4″][/sc] [sc name=”5″][/sc] [sc name=”6″][/sc] [sc name=”7″][/sc] [sc name=”8″][/sc] [sc name=”9″][/sc] [sc name=”10″][/sc]